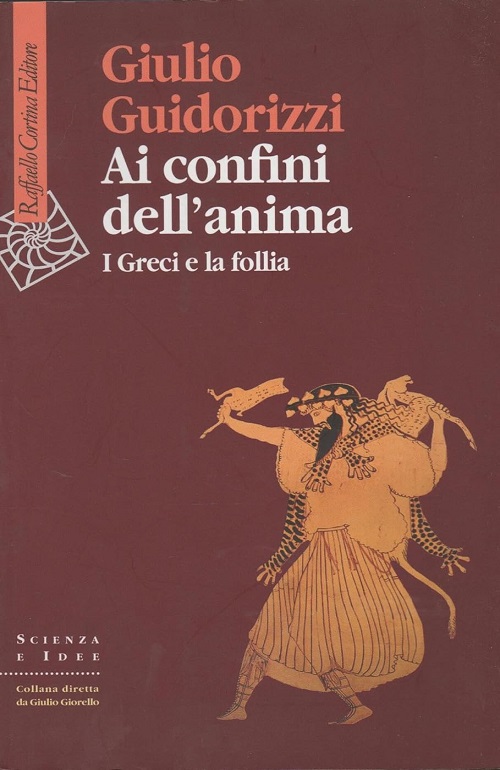SINOSSI
Nella Grecia delle origini la follia non fu solo malattia, ma mezzo per forzare i limiti dell'anima e dilatare la personalità. Faceva parte dell'esperienza religiosa, stava alla base dell'attività di profeti e persino di politici, era la voce degli oracoli. C'era metodo in quella pazzia: ispirava poeti e cantori, né mancavano culti estatici, come quello di Dioniso, in cui gli adepti avevano esperienze visionarie, come tuttora avviene nei riti di possessione diffusi in numerose altre civiltà. In Grecia i pazzi non venivano reclusi: piuttosto la società era capace di modellare la follia al proprio interno, sfruttandola in modo creativo. Questo libro mostra quanto la stessa civiltà dell'Occidente debba alla non-ragione.
RECENSIONE
Chi è il folle, cos'è la malattia e quali sono le sue forme e i suoi aspetti all'interno della società: questi sono i grandi interrogativi che danno vita a questo brillante saggio di Giulio Guidorizzi. Il grande grecista ripercorre, su un piano antropologico e psicopatologico, le forme della follia nel mondo antico, soggetta a mutazione in quanto inclusa nelle diverse fasi storiche. Quando si sente parlare di Grecia antica, si pensa spesso a un unico grande blocco e le parole prototipiche che ne saltano fuori sono forse "classico", "Atene", "polis", "Pericle", "Zeus", "miti", come se tutto questo aspetto complesso dovesse essere racchiuso in un unico monolite, cosa certamente non vera. Non esiste un'unica tipologia culturale greca, ma tante sono le forme che, all'interno di uno spazio temporale periodizzato, si trasformano, si intrecciano e cominciano a includersi, ma mai a escludersi del tutto, all'interno di questo mondo affascinante. Questo saggio si propone, dunque, di analizzare parallelamente la follia in due momenti ben precisi, la Grecia arcaica e la Grecia classica, due periodi sicuramente diversi, eppure perennemente in dialogo tra loro, che creano una forma ibrida in cui tutto si mantiene ma allo stesso tempo si ricerca, si sonda, si scava. Nell'Illuminismo ateniese del V secolo a.C affiora una nuova domanda, che comincia con una semplice congiunzione a cui ogni uomo si accosta durante la propria esperienza umana: "perché?". Questo interrogativo dirotta verso una nuova esplorazione eziologica, remata da nuove forme solide di conoscenza, quali la filosofia, la scienza, la medicina che, insieme al patrimonio collettivo e simbolico dell'ambiente in cui nascono, cercano di ispezionare cause, motivi e ragioni di carattere naturale, seppur irrimediabilmente errato sarebbe l'ammettere una contrapposizione assoluta tra mythos e logos, poiché entrambi si muovono sullo stesso territorio ed eliminare anche una singola traccia dell'uno o dell'altro, significherebbe far crollare un'intera cultura. Il perno sismico che porta alla fioritura di nuovi e diversi saperi e la curiosità e l'esercizio degli intellettuali che li indagano, sono il frutto di nuovo ampliamento di paradigma, che si concentra sulla dislocazione da una sfera tutta soprannaturale a una più umana e terrena. Tale scenario cambia, non solo nelle manifestazioni sintomatiche delle malattie redatte nei trattati di Ippocrate, ma anche nella sfera culturale più ampia dell'intera civiltà, esempio eclatante è sicuramente la rappresentazione scenica della tragedia, si pensi soprattutto al grande cambiamento della messa in scena teatrale del tragediografo Euripide, rispetto al più vecchio Eschilo. È proprio in questa concezione unitaria ma spazializzata, il cui sguardo si affaccia verso nuovi orizzonti, che si muove il saggio dell'autore. La follia, dunque, all'interno di questa visione, si guarda allo specchio e si contempla come manifestazione interiore dell'uomo e allo stesso tempo come altro da sé, come malattia del corpo e insieme dilatazione di coscienza. Possedere follia significa anche fare follia e fare follia significa fare esperienza. Nella storia del mondo greco, il folle nasce come un soggetto contaminato dal dio, si macchia di colpa, si sviluppa nel conflitto, diventa vittima di esclusione sociale e, successivamente, si cerca istituzionalmente di reintegrarlo. La follia nella Grecia arcaica è l'espressione fisica di ciò che la pulsione reprime, ecco perché si ritiene che la follia debba essere ammansita e non debellata, ad essa viene riconosciuta una dimora, presente dentro ogni uomo. Inoltre, la follia, sperimentata attraverso l'estasi o la trance, porta una conoscenza di saperi per un'intera collettività, se ne può capire meglio la portata se pensiamo che si scaglia principalmente su figure come poeti, profeti o eroi, tutti soggetti a un'esperienza estatica, la cui conoscenza viene poi successivamente elargita come bene di un'intera comunità. Potrei continuare a parlarne per ore, ma nessuno meglio del professore Giulio Guidorizzi riesce a trascinare così profondamente negli aspetti più sinceri e culturali di un mondo così lontano e complesso, ma a cui fortunatamente gli studiosi e gli innamorati fanno ritorno, restituendoci un preziosissimo tesoro che riguarda la nostra storia del mondo.
[RECENSIONE A CURA DI MIRIAM DI MICELI]
| Autore | Giulio Guidorizzi |
| Editore | Raffaello Cortina Editore |
| Pagine | 226 |
| Anno edizione | 2009 |
| Collana | Scienza e idee |
| ISBN-10(13) | 9788860303134 |
| Prezzo di copertina | 19,00 € |
| Categoria | Realistico - Cronaca - Saggi - Biografia |