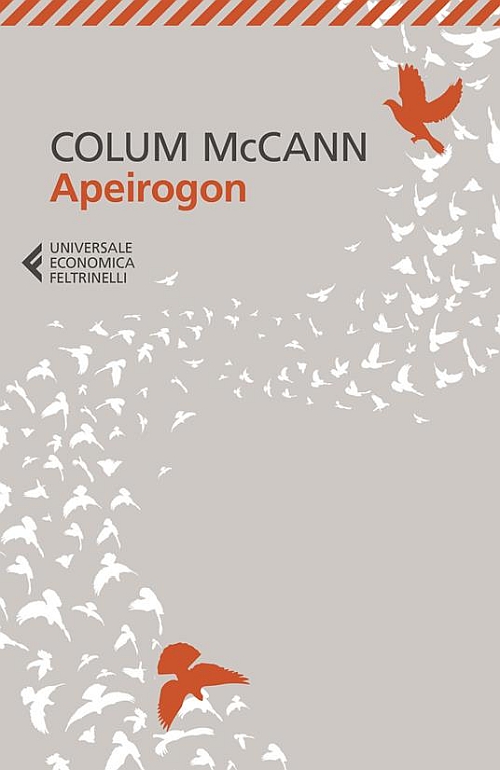SINOSSI
Bassam Aramin è palestinese. Rami Elhanan è israeliano. Il conflitto colora ogni aspetto della loro vita quotidiana, dalle strade che sono autorizzati a percorrere, alle scuole che le loro figlie, Abir e Smadar, frequentano, ai check point. Sono costretti senza sosta a negoziare fisicamente ed emotivamente con la violenza circostante. Come l'Apeirogon del titolo, un poligono dal numero infinito di lati, infiniti sono gli aspetti, i livelli, gli elementi di scontro che vedono contrapposti due popoli e due esistenze su un'unica terra. Ma il mondo di Bassam e di Rami cambia drammaticamente e irrimediabilmente quando Abir, di anni dieci, è uccisa da un proiettile di gomma e la tredicenne Smadar rimane vittima di un attacco suicida. Quando Bassam e Rami vengono a conoscenza delle rispettive tragedie, si riconoscono, diventano amici per la pelle e decidono di tentare di usare il loro comune dolore come arma per la pace. Nella sua opera più ambiziosa, McCann crea Apeirogon con gli ingredienti del saggio e del romanzo. Attraversa i secoli e i continenti, cucendo insieme tempo, arte, storia, natura e politica, in un racconto nello stesso momento struggente e carico di speranza. Musicale, cinematografico, muscolare, delicato, Apeirogon è un romanzo per i nostri tempi.
RECENSIONE
Letto quando uscì mi sembra più che mai di attualità.
Apeirogon si inserisce nel filone narrativo di chi, da tempo, si batte per la fine del conflitto israelo-palestinese. A differenza di molti scrittori israeliani o palestinesi – come A. Yehoshua (Fuoco amico) e Susan Abulhawa (Ogni mattina a Jenin) – Colum McCann è un autore irlandese-statunitense. Il suo sguardo esterno gli permette di raccontare la complessità della tragedia mediorientale con uno sguardo forse più imparziale, che unisce distacco analitico e profonda empatia. Il romanzo narra la storia vera di Rami Elhanan e Bassam Aramin, due uomini che appartengono a mondi opposti, ma uniti da un dolore che li accomuna e li trasforma. Rami è un israeliano, ebreo di Gerusalemme ovest, proveniente da una famiglia di lunga tradizione militare, con un passato da soldato nell'esercito israeliano e un presente di grafico professionista. Bassam è un palestinese di Anata, un ex combattente che ha passato sette anni nelle carceri israeliane per aver partecipato alla lotta armata da giovane. Entrambi sono uomini segnati da un vissuto complesso e contraddittorio, costretti a ripensare il proprio ruolo nel conflitto dopo aver perso ciò che avevano di più caro: le figlie Smadar e Abir. Ѐ da questa tragedia condivisa che nasce il loro legame. Smadar, la figlia di Rami, viene uccisa a tredici anni in un attentato suicida nel centro di Gerusalemme, mentre si trovava con le amiche a comprare libri. Abir, la figlia di Bassam, viene colpita alla testa da un proiettile di gomma sparato da un soldato israeliano da un’autoblindo, mentre usciva da scuola per andare a comprare una caramella. Aveva solo dieci anni. Questi due eventi sconvolgenti sono il cuore pulsante del libro, raccontati con una precisione emotiva che non scade mai nel patetico. Rami e Bassam, dopo un incontro inizialmente segnato da diffidenza, scelgono di trasformare il loro dolore in un atto di resistenza pacifica. Diventano testimoni e ambasciatori di un messaggio di pace, viaggiando insieme in tutto il mondo per raccontare la loro storia e quella dei loro popoli. Portano avanti una testimonianza scomoda, che si scontra tanto con le politiche ufficiali quanto con le narrazioni più radicali da entrambe le parti. Ma è proprio questa scomoda verità a rendere il loro impegno così potente. Rami è un uomo razionale, un intellettuale che cerca di sublimare il proprio dolore attraverso l’impegno e la narrazione. Nonostante l’apparente freddezza e il suo modo pacato di raccontarsi, la sua sofferenza emerge a tratti come un dolore sordo, mai del tutto elaborato. La morte di Smadar lo trasforma radicalmente: da cittadino che accettava passivamente le contraddizioni del suo Paese, diventa un attivista per la pace, pronto a mettere in discussione la propria identità nazionale pur di impedire ad altri genitori di vivere la sua stessa tragedia. Bassam, al contrario, è un uomo viscerale, la cui umanità emerge con forza nonostante le ingiustizie subite. La prigionia, le torture e le umiliazioni che ha vissuto da giovane non hanno soffocato in lui la capacità di sperare e di sognare un futuro diverso per il proprio popolo. La morte di Abir è il punto di svolta definitivo: invece di lasciarsi sopraffare dall'odio, Bassam sceglie il perdono come atto politico e personale. La sua è una figura profondamente toccante, segnata dalla resilienza e da una capacità straordinaria di restare umano in condizioni disumane.
Il romanzo si articola in 1001 brevi frammenti, come a voler evocare Le mille e una notte, ma qui non si raccontano fiabe: è la realtà che si fa narrazione, disgregata e molteplice, come le infinite facce dell’Apeirogon, il poligono con un numero illimitato di lati da cui il libro prende il nome. L’Apeirogon, dunque, come metafora di una molteplicità di punti di vista e una complessità delle storie che si intrecciano in una narrazione frammentata ma coesa. Questa struttura formale non è solo un espediente stilistico, ma una vera e propria dichiarazione di intenti: McCann ci mostra che la verità non è mai lineare, che la storia di Rami e Bassam è mille storie, che la loro voce è quella di milioni di altre persone che abitano la stessa terra e subiscono lo stesso destino. I brevi capitoli creano un ritmo incalzante che richiama la frammentazione della realtà in Israele e Palestina e, nel contempo, la continuità del dolore, della memoria e della speranza. McCann costruisce un’opera che è al tempo stesso denuncia e invocazione. Non fa sconti a nessuno: mostra la durezza della vita nei Territori Occupati, la brutalità dell’occupazione israeliana, la disperazione che spinge alcuni palestinesi verso la violenza. Tuttavia, in alcuni passaggi, il suo sguardo appare eccessivamente idealistico. Il messaggio di pace, affidato quasi esclusivamente alla buona volontà dei singoli, rischia di sembrare una soluzione semplicistica rispetto alla complessità del conflitto. McCann, pur non ignorando la sofferenza dei palestinesi, tende a sorvolare sulle responsabilità politiche e militari che perpetuano l'occupazione. Chi ha visitato Israele e la Palestina sa bene che la vera violenza si annida nella quotidianità: nei checkpoint, nei muri, nell’umiliazione sistematica, nella segregazione che scandisce le vite di milioni di persone, nelle differenze abissali di diritti e opportunità tra israeliani e palestinesi. Eppure, il romanzo riesce comunque a mostrare come, anche in mezzo a questa realtà opprimente, sia possibile trovare voci che chiedono riconciliazione. Nonostante queste riserve, Apeirogon resta un'opera necessaria. È un libro che scuote, che chiede al lettore di interrogarsi, che invita a non voltarsi dall’altra parte. La testimonianza di Rami e Bassam è potente, non solo per ciò che racconta, ma per il modo in cui ci costringe a guardare l’altro, anche il "nemico", con occhi diversi. I protagonisti ci mostrano che, pur nella tragedia più assoluta, esiste sempre la possibilità di scegliere: tra odio e speranza, tra vendetta e perdono.
Il romanzo è duro e struggente, impietoso nel denunciare i meccanismi di odio e paura che alimentano il conflitto; un romanzo che parla di dolore, di perdita, ma soprattutto di scelta: quella di trasformare la sofferenza in un ponte per l’incontro anziché in un muro che divide. Da leggere, con attenzione e con rispetto per la complessità che affronta.
[RECENSIONE A CURA DI MENTI55]
| Autore | Colum McCann |
| Editore | Feltrinelli |
| Pagine | 528 |
| Anno edizione | 2022 |
| Collana | Universale economica |
| ISBN-10(13) | 9788807896576 |
| Prezzo di copertina | 15,00 € |
| Prezzo e-book | 8,99 € |
| Categoria | Contemporaneo - Attualità - Sociale - Psicologico |