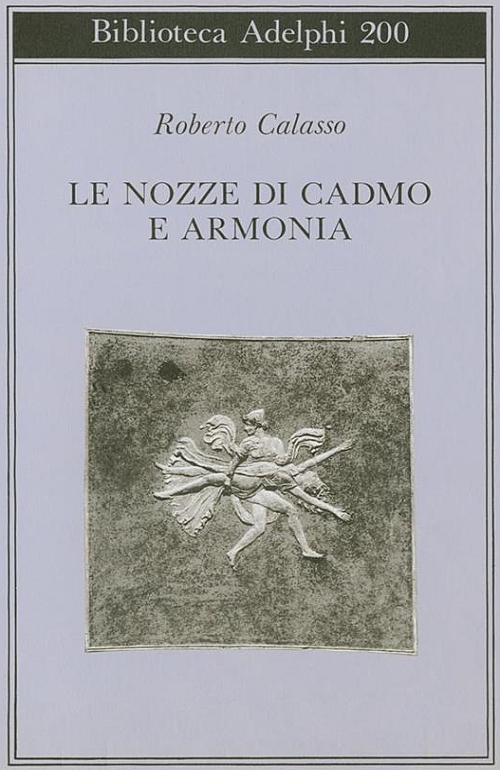SINOSSI
Le nozze di Cadmo e Armonia furono l'ultima occasione in cui gli dèi dell'Olimpo si sedettero a tavola con gli uomini, per una festa. Ciò che accadde prima di allora, per anni immemorabili, e dopo di allora, per poche generazioni, forma l'albero immenso del mito greco. Nelle "Nozze di Cadmo e Armonia" un soffio di vento torna a muovere le fronde di quell'albero. Come scrisse un antico, «queste cose non avvennero mai, ma sono sempre». Raccontarle, intrecciandole fin nei minimi dettagli, impone alcune domande, che anch'esse «sono sempre»: perché gli dèi dell'Olimpo assunsero figura umana, e perché quella figura? Perché le loro storie sono così scandalose, e misteriose? Che cos'è un simulacro? Perché l'età degli eroi fu breve, convulsa e irripetibile? Da che cosa Zeus si sente minacciato? Forse il mito è una narrazione che può essere capita solo narrando. Forse il modo più immediato per pensare il mito è quello di raccontarne di nuovo le favole. Una luce radente, netta, qui le investe tutte e le mostra nelle loro molteplici connessioni, come una vasta e leggerissima rete che si posa sul mondo.
RECENSIONE
Qualche giorno fa, arrivata all'ultima del libro, ho istintivamente girato questo bel mattoncino e ricominciato immediatamente la lettura tutta daccapo. Se non avessi nulla da fare probabilmente lo rileggerei ancora una terza volta, un po' per avviarmi come fossi una giovane iniziatica, un po' per concepire una ricerca quasi archeologica di quel telos (il fine ultimo) che si presenta apparentemente come groviglio di una matassa inestricabile, ma che forse è una rappresentazione medesima che si muove e si espande dentro un flusso atemporale di indifferente distanza. Il filo circola tra le mani di Arianna e si propone come guida labirintica; si cuce e si scuce nel telaio di Penelope, che manomettendolo quotidianamente, infonde e rinnova in lei una salvezza e una speranza per la sua sorte, per la sua patria e per il suo sposo; lo stesso filo, infine, lo vediamo approdare fatalmente nel palazzo di bronzo delle Moire, dove qui diventa il disegno di una linea della vita e del destino umano. Roberto Calasso è un portento umano, la sua prosa robustissima e difficilissima si intreccia in intenzioni saggistiche e critiche per decantare una delle più antiche bellezze che l'uomo ha inventato nella storia della civiltà: il mito.
Cosa posso dire di fronte a tanto materiale composito? Calasso è una lettura molto soggettiva, o piace o non piace, ma se piace sei fregato perché questo autore ha una penna superba che oscilla tra l'antico e il primordio. Mi verrebbe quasi da dire che Calasso tratta i suoi lettori con indifferenza, principalmente perché non vuole appassionati, vuole esclusivamente seguaci. Le parole di Roberto Calasso disegnano una sconvolgente linearità che prende forma ciclica; con il suo inchiostro, l'autore sembra fare il giro del mondo per poi ritornare al punto di partenza e ripartire ancora una volta per una strada che non è mai solo una strada, ma equivale a tutte le forme del possibile, accettando così la costituzione del visibile, Calasso mette in guardia sulla fisicità dell'invisibile, come se fossimo più portatori di quel destino che abbiamo scartato, come se fossimo noi stessi il corpo di quell'assenza. Questo cerchio, in fin dei conti, è la costellazione che bagna il cielo dell'antica Grecia, dove tutto nasce, prosegue, si chiude, ricomincia e ancora una volta si ripete nelle infinite varianti del mito. Le varianti della narrazione sbocciano come fiori di primavera dalle fonti filologicamente ricostruite e, ogni volta, psichicamente più destabilizzanti, in cui la traduzione diversa di una singola parola o di una minuscola e falsa debole congiunzione abbatte il sistema e di nuovo lo inventa con coraggio e follia d'interpretazione. A chi potrebbe piacere questo libro? A chi cerca radici, a chi cerca significati nascosti tra i fumi delle libagioni, a chi cerca errori, a chi non ha paura di guardare all'empietà, proprio perché il primordio partorisce Necessità, non di certo morale, non sicuramente etica, al massimo si potrebbe ipotizzare il presupposto per la costruzione dell'ethos, ma il viaggio è ancora troppo lungo per poterlo vedere all'orizzonte. Generazione di nuovi dei oltrepassano vecchi dei e per tre volte la stirpe divina si ripete. Zeus è l'apparire, è luce, eppure in lui regna il visibile e l'invisibile, è il primo e come tutti coloro che furono i primi, anche lui commette la colpa del padre: inghiottire tutto l'universo, inghiottire Fanes e poi vomitare l'intero cosmo, in cui tutto ciò che è, diviene ancora una volta, purificato e pronto per la sacra nuova dimora dell'Olimpo. Il dio greco è un dio che, a causa della Necessità, commette colpa e la usa, mentre l'uomo, a causa della stessa Ananke, commette colpa e la subisce. La colpa nel mondo terrestre si fa corpo, si fisicizza, distrugge uomini, famiglie, intere stirpi. Il dio greco è un dio capriccioso, testardo, insolente, ma soprattutto è un dio che esige immancabilmente di essere riconosciuto.
Un grande studioso italiano del Settecento, Giambattista Vico, paragona le tre età dell'uomo a tre stadi diversi della vita: l'infanzia corrisponde al senso, la fanciullezza alla fantasia e l'età adulta alla ragione. Vico prende questo studio sull'uomo e lo traspone, anticipando quel concetto che circa un secolo dopo, il fenomeno rivoluzionario Romantico porrà come base per una nuova estetica, un nuovo profilo di indagine che diventa nuova scienza: la Storia. Tutto si secolarizza e ogni cosa assume il significato primo e il significato ultimo, così Vico lavora più in grande, applica e paragona lo schema evolutivo dell'uomo alle fasi storiche dell'umanità stessa: l'infanzia diviene l'età degli dei, la fanciullezza l'età degli eroi e l'età adulta prende sembianze assolutamente umane. Qual è la verità sconvolgente e, al tempo stesso, inaccettabile che Giambattista Vico porta nella cultura dei suoi anni? Il dichiarare consapevolmente che la cultura classica, a cui l'Italia faceva affidamento e totale riferimento fin dai tempi dell'Umanesimo e del Rinascimento, non era per nulla una poesia che si basava sulla sapienza e sulla saggezza ma, al contrario, la poesia antica si basava sul senso inteso come pura forza irrazionale e primitiva. Vico accende una fiamma che negli anni a venire divampa, ricapitola i poemi omerici con uno sguardo che non è più ossessionato dall'afferrare sapienza ma che accoglie, al contrario, quella nuova forza fantastica nel vigore della violenza e della passione.
Il dio greco è furia di passioni ma è anche un dio annoiato, invidioso della mortalità degli uomini e da questa invidia si scatenerà il principio della metamorfosi e della mescolanza: il dio migra sulla terra, subdolo si traveste da animale per “armonizzare” a suo piacimento i destini mortali. Due sono principalmente gli animali che il divino incarna e uccide: il toro e il serpente, da intendere come sacri e sacrificabili. Attraverso il principio della metamorfosi gli dei giocano con la violenza, spargendo il proprio seme sulla terra, violando uomini e fecondando donne da cui si avvierà l'inizio di una nuova genesi, ovvero quella degli eroi. Questi eroi, ebbri di infatuazione divina ma condannati irrevocabilmente alla morte, sono i più splendenti tra tutti gli uomini e, al tempo stesso, più mortali di tutti i mortali, così possiamo parlare di Achille, Odisseo, Giasone, Eracle, Teseo e di una lunga lista che ancora continua. Tra tutte le imprese degli eroi, la guerra di Troia è quella che ha fatto tremare di più gli dei. Infatti, c'è stato un momento in cui l'Olimpo ha avuto paura che la disposizione teologicamente preparata dal dio potesse completamente rovesciarsi, tanto da far scomparire la Tyche così attentamente disegnata e predestinata dal dio stesso. Cosa mai sarebbe successo? O per meglio dire, cosa è effettivamente successo? A quale nuovo paradigma indiziario si è giunti? Una parola: Hybris. La tracotanza dell'eroe, in quanto possessore e posseduto, colpevole e vittima della sua condizione semi-divina, risiede nel volersi spingere oltre questa pianificazione a lui sconosciuta ma intessuta nella sua stessa pelle. Colui che forse ha più subito questa condizione è stato Eracle, colui che, invece, l'ha più bramata è stato probabilmente Achille. Di fronte all'ira di Achille, gli dei decidono che è arrivato il momento di sterminare gli eroi, diventati temibili e terribilmente scomodi; quale miglior modo di fare piazza pulita se non indire una guerra per mostrare gloriosamente la nera Ate? Dalle fiamme di Troia si stabilisce subito un nuovo ordine: il mondo degli uomini e la nascita di Atene. Nessuna lacrima, nessun re caduto, nessuna vittoria, nessuna mancanza di sepoltura degna, nessuna predizione di Cassandra, nessuna parola saggia di Priamo potrà cambiare le sorti di quella morte fatale e della sua consequenziale nuova rinascita.
Questo libro è immenso e immerso nell'abisso del significato profondo da cui si diramano altri significati nascosti nel destino di donne bellissime, abbandonate, tradite, uccise, alcune figlie di re, altre barbare, altre ancora sacerdotesse, sparse per tutta la Grecia, lontane ma così profondamente vicine nel loro delirio o nella sophrosyne (prudenza), legata sottilmente alla Metis (capacità di proporre soluzioni specifiche), di cui solo le donne si rivelano vere portatrici; un significato profondo ancora abita nei segretissimi misteri di Eleusi, nei fumi allucinatori della Pizia, nei sogni premonitori, nei riti cadenzati ma inevitabilmente erranti, come errante è il mito che passa da cantore ad aedo per non dimenticare. Ed è proprio la memoria il dono più bello che ci hanno fatto gli eroi. Quando la ninfa Teti, addolorata nel suo cuore di madre, emerge fuori dalle acque e parla ad Achille, colui che ha segnato, per primo, il concetto di “unico” tra gli uomini mortali, lei sa già quale destino seguirà, conosce la risposta al bivio d'opposizione che si pone davanti al figlio: se la scelta sta nel decidere della propria felicità o della gloria eterna, non vi è dubbio che Achille sceglierà la gloria imperitura ed è proprio in quella risposta che gli eroi ci hanno donato il regalo più bello del mondo, poiché ci hanno responsabilizzato di una memoria che deve essere tramandata ora e per sempre, un racconto che deve essere cantato per ricordare da dove arriviamo, chi eravamo, che cosa abbiamo fatto, quanto abbiamo patito, come abbiamo sofferto, ed è solo con la poesia che noi uomini ci siamo innamorati, così come con la poesia, a discapito dei progetti divini, gli eroi hanno conquistato la loro immortalità.
[RECENSIONE A CURA DI MIRIAM DI MICELI]
| Autore | Roberto Calasso |
| Editore | Adelphi |
| Pagine | 483 |
| Anno edizione | 2004 |
| Collana | Biblioteca Adelphi |
| ISBN-10(13) | 9788845918926 |
| Prezzo di copertina | 25,00 € |
| Prezzo e-book | 7,99 € |
| Categoria | Realistico - Cronaca - Saggi - Biografia |