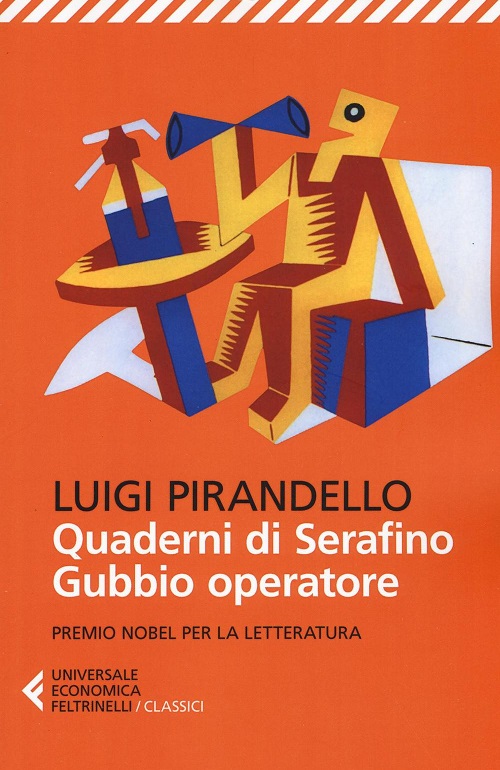SINOSSI
Chi volesse riassumere in due parole la trama si troverebbe certo in imbarazzo: il nucleo della storia è infatti una storiaccia passionale, che rimanda ai modelli del melodramma e del romanzo tardo-romantico replicati in tutte le possibili varianti dal romanzo d'appendice. Abbiamo un perfetto esemplare di femme fatale, slava, bellissima, tormentata e crudele, la solita donna "più tigre della tigre", il cui fascino funesto causa la morte di due uomini... Il punto è che quella fabula è assunta da Pirandello come una materia romanzesca da rielaborare in una direzione completamente diversa: la storiaccia c'è, con tutti i suoi stereotipi, ma è assunta come una materia grezza che il romanzo si incarica di anatomizzare, straniare, ridicolizzare, reinterpretare. In altre parole, Pirandello ci racconta una storia e contemporaneamente sviluppa una riflessione sulle possibilità della scrittura narrativa, conducendo a compimento la dissoluzione dei modelli romanzeschi tradizionali.
RECENSIONE
Pubblicato nel 1916 con il titolo "Si gira..." (mutato poi in quello attuale e definitivo nove anni dopo), Quaderni di Serafino Gubbio operatore è il classico romanzo filosofico: trama di fatto semplice (una "storiaccia passionale" da romanzo d'appendice, come la definisce Simona Micali nella sua bella Postfazione all'edizione Feltrinelli), rispetto alla quale al lettore è richiesto uno sforzo esegetico tutt'altro che banale. Serafino Gubbio è cineoperatore alla Kosmograph, ma precisa sin dalle primissime pagine che nel suo lavoro, di fatto, non opera alcunché: "Colloco sul treppiedi a gambe rientranti la mia macchinetta. [...] E io mi metto a girar la manovella". In questo gesto ripetitivo è racchiuso il dramma della sua alienazione: egli non è altro che un ingranaggio di un grande apparato tecnico. La sua utilità è subordinata alle potenzialità della macchina, al punto che quando questa - come è facile pronosticare - sarà in grado di girare da sé, non occorrerà più alcun operatore (pp. 11-12). La caratteristica principale di Serafino è l'impassibilità: il suo lavoro consiste nel dare in pasto alla macchina le scene da riprendere, senza alcun coinvolgimento emotivo. Alla cinepresa non si può chiedere empatia, ma solo efficienza nella registrazione. Assistiamo così, nella lettura (che è essa stessa un gesto passivo), al dipanarsi della trama che coinvolge i vari personaggi. Serafino li osserva, ne descrive con ostentato distacco l'operato riportando le proprie impressioni su sette quaderni a mo' di diario, e infine ci consegna il suo responso (una sorta di morale): "nessuna saggezza m'è apparsa più saggia di questa, che insegna a guarir d'ogni voglia, disprezzandola" (p. 193).
Il romanzo, in definitiva, è un manifesto antifuturista, pur senza ostentare alcuna presa di posizione ideologica. La denuncia contro la civiltà delle macchine (o potremmo forse meglio dire, 'galimbertianamente', l'era della tecnica) è implicita ed emerge riflettendo proprio sulla passività di Serafino, operatore che non opera. Impressiona, in questo, la lucidità di analisi di Pirandello in uno scritto di oltre un secolo fa. La tecnica - intesa quale più alta espressione della razionalità umana al servizio della produttività - ha un solo scopo: la massima resa con l'impiego minimo dei mezzi. Essa riduce l'uomo a funzionario di apparati, assegnandogli mansioni specifiche che non prevedono affatto che si abbia cognizione del processo nel suo insieme. Cosa produco, a quale scopo, per quale fruitore finale? Queste domande evaporano nella società della tecnica: ciò che conta è esclusivamente l'efficienza, nel rigido rispetto del mansionario assegnato. Basta girare la manovella, direbbe Serafino. Il quale però giustamente, non senza angoscia, si interroga: "Ma che cosa poi farà l'uomo quando tutte le macchine gireranno da sé, questo [...] resta ancora da vedere" (p. 12).
Nei Quaderni, tuttavia, il discorso va oltre questa riflessione. A ben vedere, Pirandello ci offre una versione parodica del romanzo tradizionale, mettendo in discussione lo stesso ruolo del romanziere, cui non resterebbe che un'arte vacua e insignificante. Icastiche sono, al riguardo, le rappresentazioni del violinista incapace di accompagnare musicalmente un pianoforte automatico, e di Mirelli, i cui quadri raggiungono il sublime ma a costo della vita (in quanto ispirati dalla tigre-Nestoroff). Serafino, in altre parole, teorizza la morte dell'arte nella modernità: una morte lenta ma inesorabile, conseguenza inevitabile della mercificazione degli stessi prodotti artistici, simboleggiati dalla cinematografia, che a suo dire ucciderebbe la creatività per vendere al grande pubblico prodotti in serie, stereotipati e preconfezionati. In quest'ottica va letta anche l'afasia che colpisce il protagonista nel finale, in conseguenza dello shock cagionato dall'epilogo tragico del Nuti e della Nestoroff. Il silenzio di Serafino è quello dello stesso Pirandello, che infatti, significativamente, abbandonerà il romanzo fino all'ultima, definitiva opera (Uno, nessuno e centomila), nella quale al muto distacco si sostituirà la follia come unico salvagente possibile per restare a galla in un mondo che pare avere smarrito la propria dimensione umana. I Quaderni, pertanto, sono un 'non-romanzo': appunti di un cineoperatore, riflessione postuma di un artista che si sente morto, incapace di comunicare. In gioco c'è il senso stesso dell'arte narrativa, a partire da una domanda (non esplicitata, ma evidente) molto semplice: è ancora possibile scrivere un romanzo nella società delle macchine?
[RECENSIONE A CURA DI GIGIMALA]
| Autore | Luigi Pirandello |
| Editore | Feltrinelli |
| Pagine | 238 |
| Anno edizione | 2017 |
| Collana | Universale economica. I classici |
| ISBN-10(13) | 9788807902604 |
| Prezzo di copertina | 9,50 € |
| Prezzo e-book | 0,49 € |
| Categoria | Contemporaneo - Attualità - Sociale - Psicologico |