Ad integrazione di quanto da te ben descritto Max mi permetto di riportare un articolo del Sole 24 Ore incentrato sul libro di Paul Roberts:
Il cibo è finito, e se l'umanità non ne prenderà atto al più presto, i 9 miliardi di individui che affolleranno il pianeta tra poche decine di anni andranno incontro a sconvolgimenti oggi neppure immaginabili. Le prove sono attorno a noi e risiedono, per esempio, nel fatto che, nonostante la produzione di cibo sia pressoché per intero industrializzata, infezioni e contaminazioni anche mortali sono sempre più frequenti e, soprattutto, nel fatto che nonostante essa ecceda quasi del 20% le necessità, migliaia di persone continuano a morire ogni giorno per fame e contemporaneamente, in altri luoghi, molte di più muoiono per le conseguenze nefaste dell'iperalimentazione.
Queste le premesse del libro di Paul Roberts, intitolato appunto «La fine del cibo», tradotto in Italia per Codice Edizioni, risultato di mesi di viaggi nei sistemi alimentari più diversi, da quelli delle sterminate pianure Usa a quelli delle fattorie cinesi, e incentrato sull'analisi della delicatissima situazione attuale, in un'ottica di sistema economico globale. A Milano per presentare il libro nel l'ambito della due giorni promossa da Barilla sull'alimentazione del futuro, Roberts spiega innanzitutto che cosa intende per fine del cibo: «Sta finendo un sistema che probabilmente in futuro definiremo come l'età dell'oro dell'alimentazione, cioè una – breve – epoca in cui abbiamo avuto la sensazione che la produzione industriale di alimenti in enorme quantità e a prezzi bassissimi non dovesse avere mai fine, in cui abbiamo creduto che saremmo stati in grado di sfruttare sempre di più terreni che già erano esausti, e che avremmo avuto tutto il petrolio necessario per farlo e per trasportare il cibo da una parte all'altra del pianeta. Il risultato è che oggi mangiamo per lo più miscele di materie prime provenienti da paesi lontani lavorate in processi industriali energivori, conservate grazie ad additivi chimici e poi trasportate fino sotto casa. Oppure cibi già cotti, che nulla o quasi hanno a che vedere con pasti cucinati con alimenti naturali. È evidente che tutto ciò non regge più e che comunque non potrà durare con i trend demografici in atto».
Per far capire meglio l'industrializzazione della catena alimentare (compreso il biologico, oggi assoggettato sempre di più alla produzione su larga scala), Roberts racconta che cosa è successo nel 2006 negli Stati Uniti. La contaminazione di un tipo di spinaci da parte di un ceppo di E. coli causa la morte di tre persone e l'infezione di altre 200; 7 settimane dopo si scopre che nell'intestino dei maiali di una fattoria poco distante da uno dei campi di spinaci c'è lo stesso ceppo di E. coli, e l'equazione appare evidente: sono stati gli animali a contaminare le coltivazioni. Ma lo stesso battere si trova anche nello stallatico, nelle acque di irrigazione, negli scarichi e il sistema va in tilt. Casi come questi – spiega Roberts – sono sempre più frequenti, perché l'agricoltura intensiva ha stravolto gli ecosistemi, facendo diventare ogni passaggio vulnerabile e difficile da controllare.
Oltre a un'impostazione generale del tutto folle, ci sono poi singoli elementi il cui peso sta diventando insostenibile come la spinta dei paesi in via di sviluppo ad adottare la dieta di quelli ricchi, grassi e malati di benessere, in primo luogo per quanto riguarda la carne. «La carne, di per sé, non va demonizzata – chiarisce – e se tutti diventassimo vegetariani non riusciremmo a coltivare piante a sufficienza. Tuttavia l'eccesso cui siamo abituati non ha più senso, perché devasta l'ambiente e il nostro corpo e perché non è più sopportabile. Dobbiamo insomma ripensare al modo di ottenerla e alla quantità più opportuna per ciascuno». Il tema del ripensamento è fondamentale per capire quali siano le soluzioni possibili. Ancora Roberts: «Non possiamo permetterci di aspettare che le autorità politiche adottino misure drastiche né, forse, ha senso sperarlo. Ciascuno di noi deve fare la propria parte, cessando di essere solo un consumatore e iniziando a diventare un produttore. Anche se non si può pensare che tutti coltivino orti o allevino animali, è lecito invitare tutti a informarsi adeguatamente, a sostenere i produttori locali, a ricominciare a cucinare: se abbiamo tempo per la tv, ne abbiamo anche per i fornelli e per consumare pasti insieme». Infine, il mutamento più grande: quello di mentalità. Conclude Roberts: «Dobbiamo capire che stiamo entrando in un'era di scarsità di risorse, cibo incluso, e che ciò indurrà mutamenti molto significativi anche a livello politico, soprattutto se non saremo preparati. Paesi immensi come Cina e India avranno bisogno di più cibo, e lo cercheranno negli stessi posti dove lo stiamo cercando noi».
![]()
![]()
![]()
![]()
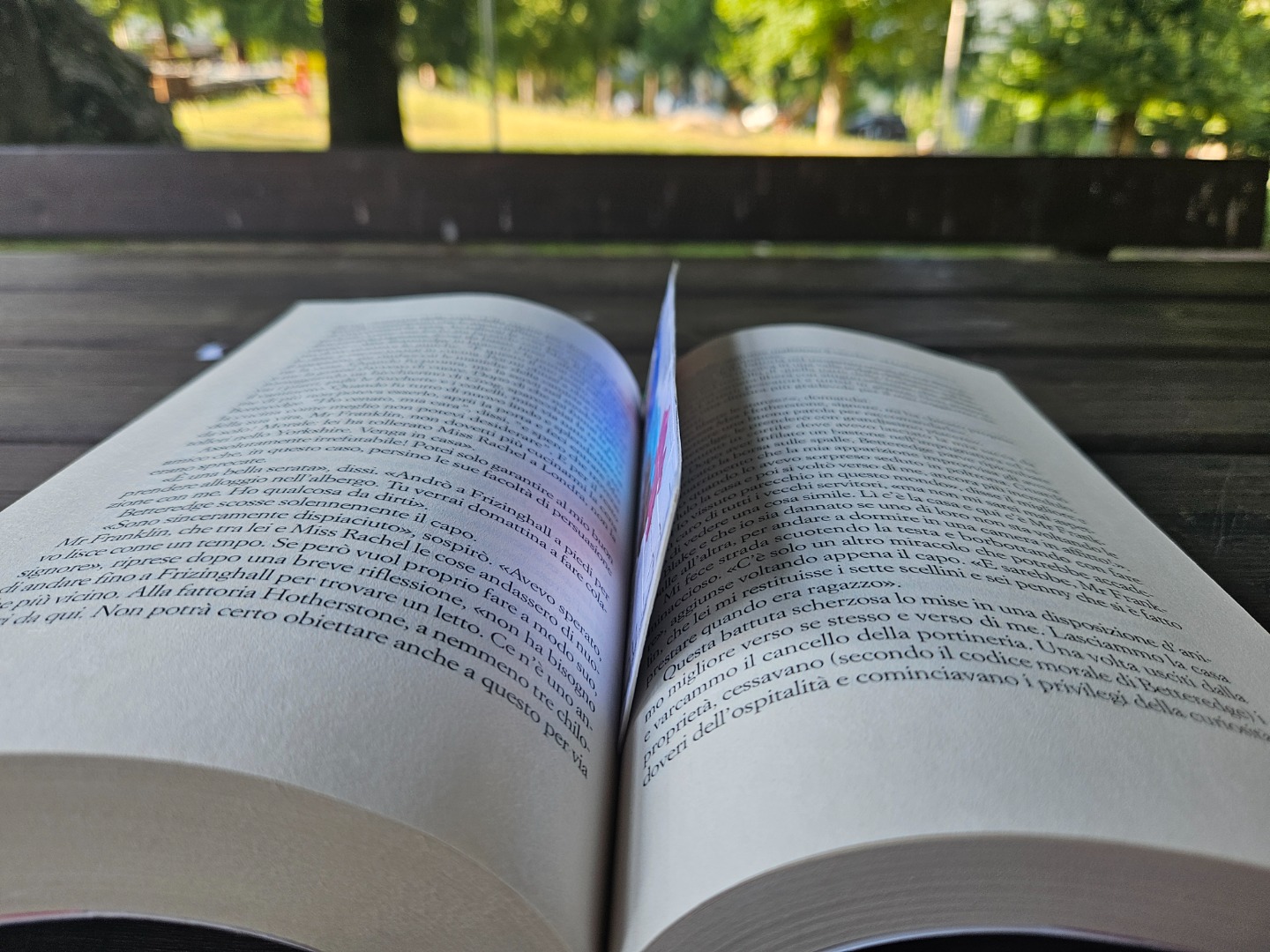 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano





