Sto continuando voracemente la lettura di questo saggio pieno di interessanti osservazioni e spunti di riflessione e, via via che lo leggo, lo consiglio ad amici e colleghi che, come me, lavorano molto con l'e-mail, come se avessi trovato un tesoro da condividere
Sono curioso di arrivare quanto prima agli spunti della seconda metà del libro, i quali dovrebbero essere da stimolo a ridurre l'uso della messaggistica digitale. Nel frattempo mi sto godendo il percorso e sto capendo sempre di più che quello che pensavo essere un mio problema, in realtà è un problema molto più ampio e diffuso.
L'autore, citando anche numerose fonti e svariati esperimenti, nonché alcune interviste che ha condotto personalmente per scrivere il saggio, conferma nettamente l'ipotesi iniziale per cui lo spostamento continuo dell'attenzione dai messaggi al lavoro e poi di nuovo ai messaggi,
riduce la capacità di pensare con chiarezza, generando
stress,
ansia,
angoscia,
infelicità, con conseguenze importanti sia dal punto di vista individuale che per l'azienda in cui lavoriamo.
Questo passaggio frequente da un'attività all'altra rallenta i nostri processi mentali. Attività complesse richiedono tempi sempre maggiori perché "
la corteccia prefrontale deve saltare avanti e indietro di continuo tra obiettivi diversi, ciascuno dei quali richiede il potenziamento e la soppressione di diverse reti neurali cerebrali" [...] "
Perché troviamo tanto difficile svolgere il nostro lavoro? Perché il nostro cervello non è progettato per mantenere l’attenzione su due diversi binari paralleli".
Interessante anche l'analisi antropologica che ne deriva, di cui riporto di seguito un estratto.
"
L'approccio frenetico alla collaborazione professionale genera messaggi a una velocità che non
siamo in grado di gestire: finiamo di scrivere e inviare una risposta, solo per scoprire che nel frattempo abbiamo ricevuto altre tre email. E mentre siamo a casa la sera, o durante il fine settimana, o in vacanza, non possiamo ignorare la consapevolezza che, in nostra assenza, le email nella casella di posta continuano ad accumularsi. [...] e spieghiamo al cervello che, se trascuriamo le possibili interazioni che affollano la casella di posta in entrata, non avremo problemi di sopravvivenza, non riusciremo comunque a evitare una sensazione d’ansia che si sviluppa in sottofondo. Nei nostri consolidati percorsi neurali, che si sono evoluti nel corso di millenni, superando le carenze di cibo grazie ad alleanze strategiche, questi messaggi lasciati senza risposta diventano l'equivalente psicologico della scelta di ignorare un membro della tribù che potrebbe rivelarsi essenziale per sopravvivere alla prossima siccità. In questa prospettiva, la casella di posta affollata di email non solo genera in noi frustrazione, ma è vissuta come una questione di vita o di morte."
C'è dunque una discordanza forte tra come saremmo predisposti per natura a comunicare e come invece siamo forzati a comunicare da una tecnologia divenuta imprescindibile per molti lavoratori.
L'autore continua la sua dissertazione facendoci pensare a come sia cambiata la modalità di comunicare anche all'interno delle aziende. Anni fa, prima dell'arrivo dell'e-mail, si faceva molta più "fatica" ad ottenere una risposta da qualcuno. Questo però induceva le persone a sforzarsi maggiormente di pensare e arrivare ad una risposta autonomamente. L'uso pervasivo dell'e-mail invece ha gradualmente eliminato questo sforzo in termini di tempo e capitale sociale, trasformandoci in persone molto più dipendenti dagli altri rispetto al passato. Inizialmente questo potrebbe sembrare un aspetto positivo, per via dell'aumentato numero di relazioni ma l'effetto collaterale di questo cambiamento è che abbiamo iniziato a delegare molto di più, provocando un continuo sovraccarico che ci sta portando alla disperazione e aumentando il carico lavorativo delle nostre giornate. "
Da quando la comunicazione è diventata gratuita, il carico di lavoro è aumentato, come effetto collaterale". Pensate infatti a quanto tempo della nostra giornata lavorativa spendiamo a rispondere a domande che ci vengono poste da altri. Io mediamente potrei considerarlo
almeno tra il 70% e l'80 % del mio tempo. Ed ecco che infatti, per fare ciò che dobbiamo fare, ci troviamo ad attingere al tempo libero, alle ore serali, a sabati e domeniche. E questo è male!
Tutte queste richieste, secondo l'autore, nascono dalla scarsità d'attrito creata artificialmente dagli strumenti di comunicazione digitale.
Come siamo arrivati a questo? "
Chi ha deciso quindi che tutti cominciassero a interagire cinque o sei volte più del normale? Per gli studiosi che indagano la questione da vicino, la risposta è radicale: è stata la tecnologia stessa".
E non è la prima volta che accade nella storia. "
Nel libro del 1962, Tecnica e società nel Medioevo, ormai divenuto un classico, White attinge sia dall’archeologia sia dalla linguistica per mostrare che l'introduzione della staffa fornisce un'ottima spiegazione della scelta, apparentemente improvvisa, di Carlo Martello di organizzare un'armata di truppe a cavallo".
L'idea che gli strumenti a volte possano orientare il comportamento umano è definita come
determinismo tecnologico. L'autore fa molti altri esempi.
La stampa (Gutemberg) ha cambiato il modo in cui il nostro cervello elabora ciò che accade nel mondo. "
Gutenberg, in altre parole, pensava di rendere disponibile alle masse una vasta quantità di informazioni, ma in realtà stava cambiando radicalmente le informazioni che le persone consideravano importanti".
Anche i "Mi piace" su Facebook sono un esempio perché costituiscono un flusso di indicatori di approvazione sociale. L'autore fa notare come inizialmente le persone accedessero occasionalmente a Facebook per vedere cosa accadeva ai loro amici mentre adesso sono molti di più quelli che vi accedono per vedere le reazioni scatenate da propri post. Instagram si nutre di questo comportamento.
Il determinismo tecnologico fa quasi paura. Può mettere a disagio se ci pensate. Tuttavia, pare che le innovazioni che alterano i nostri comportamenti lo facciano anche in modi che non erano né voluti né previsti da chi per primo ha adottato un certo strumento.
Questo deve farci riflettere molto secondo me, sull'uso che stiamo facendo delle nuove tecnologie. Qui potrebbero aprirsi numerosissimi temi e spunti di discussione. Pensate che queste tecnologie stanno modificando il comportamento abituale di noi adulti che difficilmente riusciamo ad opporci e/o a trovare soluzioni pratiche per non farsi opprimere dalle stesse. E i bambini? Come cambierà il cervello umano nel giro di 20/30 anni di esposizione a queste nuove tecnologie?
Nel frattempo, continuo la lettura...
![]()
![]()
![]()
![]()
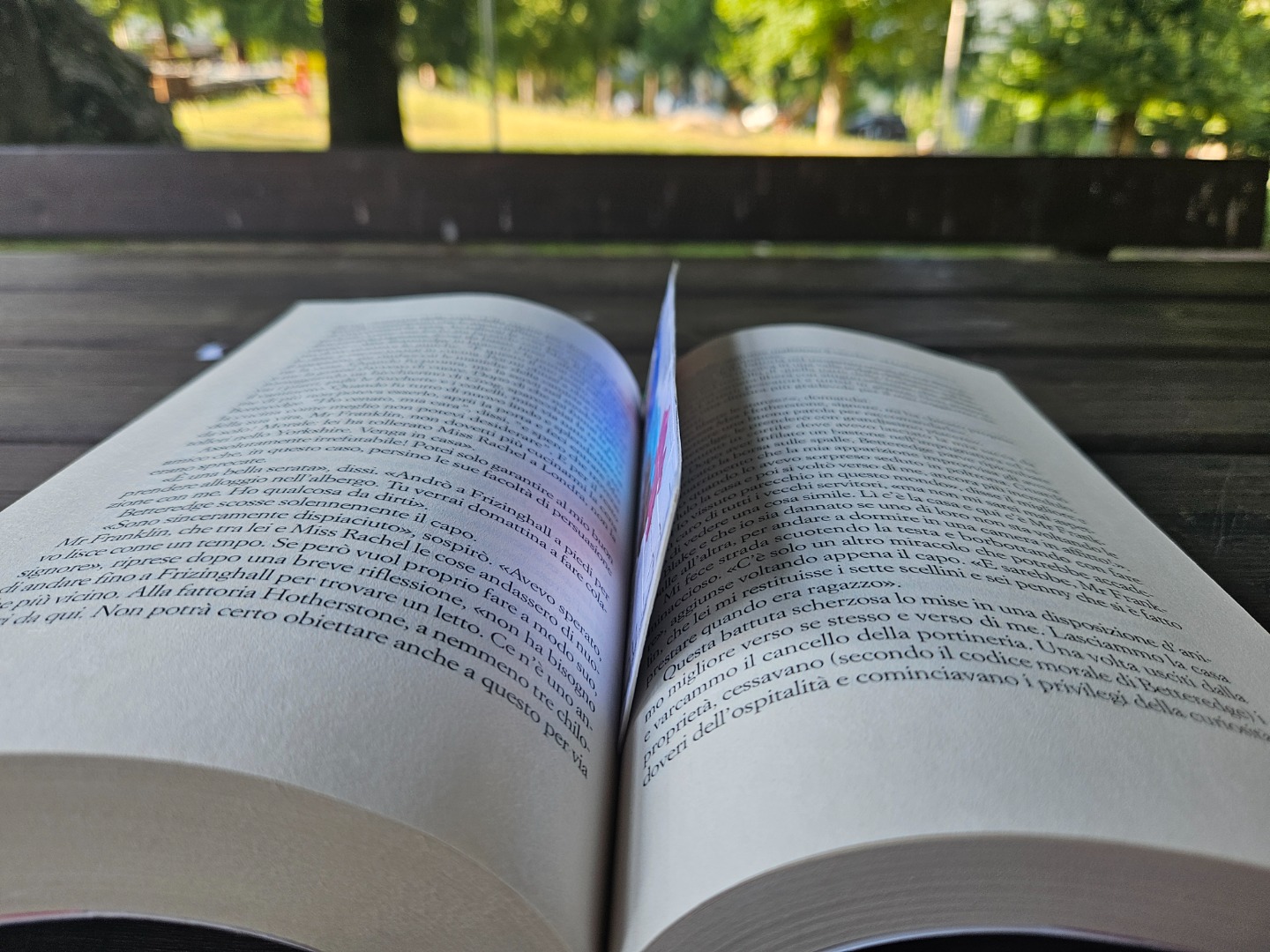 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano





