Fari della pace
Si è svolto ieri, giovedì 22 ottobre 2015, il VI Incontro del gruppo di lettura Il Grifone Rampante di Perugia. Il gruppo si è riunito di nuovo nella splendida sede della Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni, che per l’occasione ha messo a sua disposizione i propri libri sul tema della pace e della nonviolenza.
Proprio questo era infatti il tema di lettura: la pace e l’esperienza nonviolenta nel XX secolo. Ogni membro del gruppo ha letto un libro sull’argomento, presentandolo poi con i propri commenti e giudizi, facendo scaturire domande, dubbi e riflessioni. In particolare sono stati tre i punti toccati dalla nostra discussione:
- l’esperienza della nonviolenza e la difficoltà di metterla in pratica;
- l’idea della donna come portatrice di pace;
- il processo di formazione dell’Unione Europea come processo di pace per l’Europa.
Per parlare di nonviolenza in Italia non si può prescindere dall’esperienza di Aldo Capitini (Perugia, 1899-1968), che ha portato le idee di Gandhi nel nostro paese facendolo conoscere ed approfondendone le idee, primo di una serie di lunga studiosi che lo hanno succeduto.
Aldo Capitini, affascinato dalla cultura indiana, conobbe Gandhi durante uno dei viaggi italiani del mahatma. Capitini si lasciò affascinare dalle idee gandhiane, in generale in relazione alla nonviolenza, ma anche in aspetti più particolari come il vegetarianesimo, aspetto che ci ha illustrato all’incontro Laila, che ha letto la celebre autobiografia del mahatma intitolata La mia vita per la libertà.
Capitini si convinse facilmente della correttezza delle idee gandhiane. Una correttezza insindacabile, come giustamente diceva all’incontro Valentina, che ha letto Sulla violenza di Gandhi: ”Quando si legge Gandhi non si può non essere d’accordo”. Ma allora ci siamo chiesti perché è tanto difficile mettere in pratica la nonviolenza oggi. Come si può rispondere con la nonviolenza alla violenza e ai soprusi?
La questione è spinosa e ci ha fatto discutere. Ci ha fatto riflettere sull’idea che il mondo abbia sempre bisogno di punti di luce che siano dei fari della pace per un’umanità naturalmente portata alla violenza. Oltre Capitini e Gandhi, altri due personaggi sono stati presentati a questo riguardo durante l’incontro del gruppo di lettura.
La prima esperienza è quella di Josef Mayr-Nusser riportata da Francesco Comina nel libro Non giuro a Hitler, libro letto da Assunta. In quanto sudtirolese, Mayr-Nusser fu costretto nel 1939 a scegliere se appartenere alla Germania nazista o mantenere la propria identità italiana, perdendo però tra gli altri diritti, anche quello di parlare il tedesco. Si tratta di un episodio davvero poco noto della nostra storia nazionale e l’esperienza di Josef Mayr-Nusser è stata davvero molto interessante da scoprire: quest’uomo infatti divenne un punto di riferimento sociale quando nel 1943, dopo l’invasione armata tedesca dell’Italia settentrionale, si rifiutò di entrare nelle SS e di giurare ad Hitler per motivi religiosi, in quanto cristiano, procurandosi così l’ingresso nel campo di concentramento di Dachau al grido ”Le armi sono finite, la coscienza è infinita”
Un altro uomo dieci anni prima, quando nel 1933 il nazismo cominciava a prendere forma come dittatura politica in Germania, aveva avuto il coraggio di opporsi ad Hitler. Questa è l’esperienza di Armin Wegner raccolta da Gabriele Nissim nel libro La lettera a Hitler che ho letto dopo averlo conosciuto grazie ad una presentazione fatta dall’autore in biblioteca lo scorso luglio. Wegner, erudito tedesco, ebbe il coraggio di contestare le scelte politiche che nel 1933 il governo nazista stava compiendo, scrivendo una lettera aperta indirizzata ad Hitler denunciando gli errori di una politica che in effetti in seguito avrebbe portato esclusivamente morte e distruzione. In quanto personalità eminente della cultura tedesca, letterato e filosofo, Wegner fu contestato e scelse l’esilio in Italia, da dove continuò a combattere con la cultura e la letteratura l’ideologia totalitarista, arrivando a scrivere una nuova lettera aperta di protesta, questa volta indirizzata a Mussolini.
Il discorso sui fari della pace ci ha immersi poi nell’universo femminile, facendoci interrogare sull’importanza della donna, del suo modo di vedere e vivere la vita, per la causa della pace. Ciò che è uscito fuori dalla discussione è che il potere della donna sta nelle differenze rispetto all’uomo: la parità dei diritti non deve essere omologazione dei sessi, perché lo spirito femminile può insegnare, controbilanciare addirittura, quello maschile predominante solo se se ne riconoscono le differenze.
In questo senso è stato molto interessante conoscere Dieci donne di Marcella Serrano, letto da Francesca: l’esperienza di nove donne e della loro psicoterapeuta viste dal momento finale della cura, dalla soluzione dei propri problemi dopo l’accettazione del proprio essere e della propria esperienza, anche dolorosa e quasi mai facile (tra le vicende narrate si affrontano anche temi duri e ancora dibattuti, come quello dei desaparecidos).
L’idea della donna come forza di cambiamento sociale era stata già affrontata in passato dalle profetiche pagine di Virginia Woolf nel suo Le tre ghinee, presentatoci all’incontro da Tommasina. Alla Woolf nel 1938 viene chiesto un parere per evitare l’imminente guerra, di cui si sentivano già soffiare i venti. Le vengono chieste tre idee concrete e questo diviene per lei uno spunto di scrittura e riflessione: se avesse tre ghinee da spendere per la causa della pace ne impegnerebbe una per fornire di mezzi un college femminile. Una seconda la assegnerebbe per la creazione di un’associazione che favorisca l’ingresso delle donne nelle libere professioni, facendo attenzione al pericolo dell’omologazione con il sesso maschile per non rischiare di appiattire la forza dell’apporto del diverso modo di vivere delle donne. Una terza ghinea, infine, sarebbe destinata alla realizzazione di un’associazione pacifista femminile che possa affiancare e rafforzare quelle maschili già esistenti.
Parlare di fari della pace ci ha fatto infine interrogare sul nostro presente dal punto di vista politico: l’Unione Europea, nel suo processo in divenire iniziato sin dal 1950, può essere considerata come un esempio di pace per gli Stati europei che ne sono membri. La nostra storia europea, infatti, è da sempre costellata di guerre interne tra reggenti, sovrani, imperatori e papi. L’idea che ci sia una sovrastruttura che unisca e dia la possibilità di evitare la guerra e lavorare per la pace risale già a Immanuel Kant e al suo Per la pace perpetua, illustratoci all’incontro dal nostro nuovo membro Nicola. Kant non credeva che l’uomo possa diventare più buono o migliore, dimostrando una sfiducia plausibile nel genere umano storicamente guerrafondaio, ma ipotizzava la realizzazione di una sovrastruttura che operi in funzione della pace grazie a leggi e regolamenti comuni. Le parole di Kant risalgono al 1795, ma la sua intelligenza ha davvero guardato nel futuro e forse è stata di ispirazione per gli Stati che hanno cominciato ad ipotizzare un’Europa comunitaria e unita dopo i disastri delle due guerre mondiali.
...in medio stat virtus...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
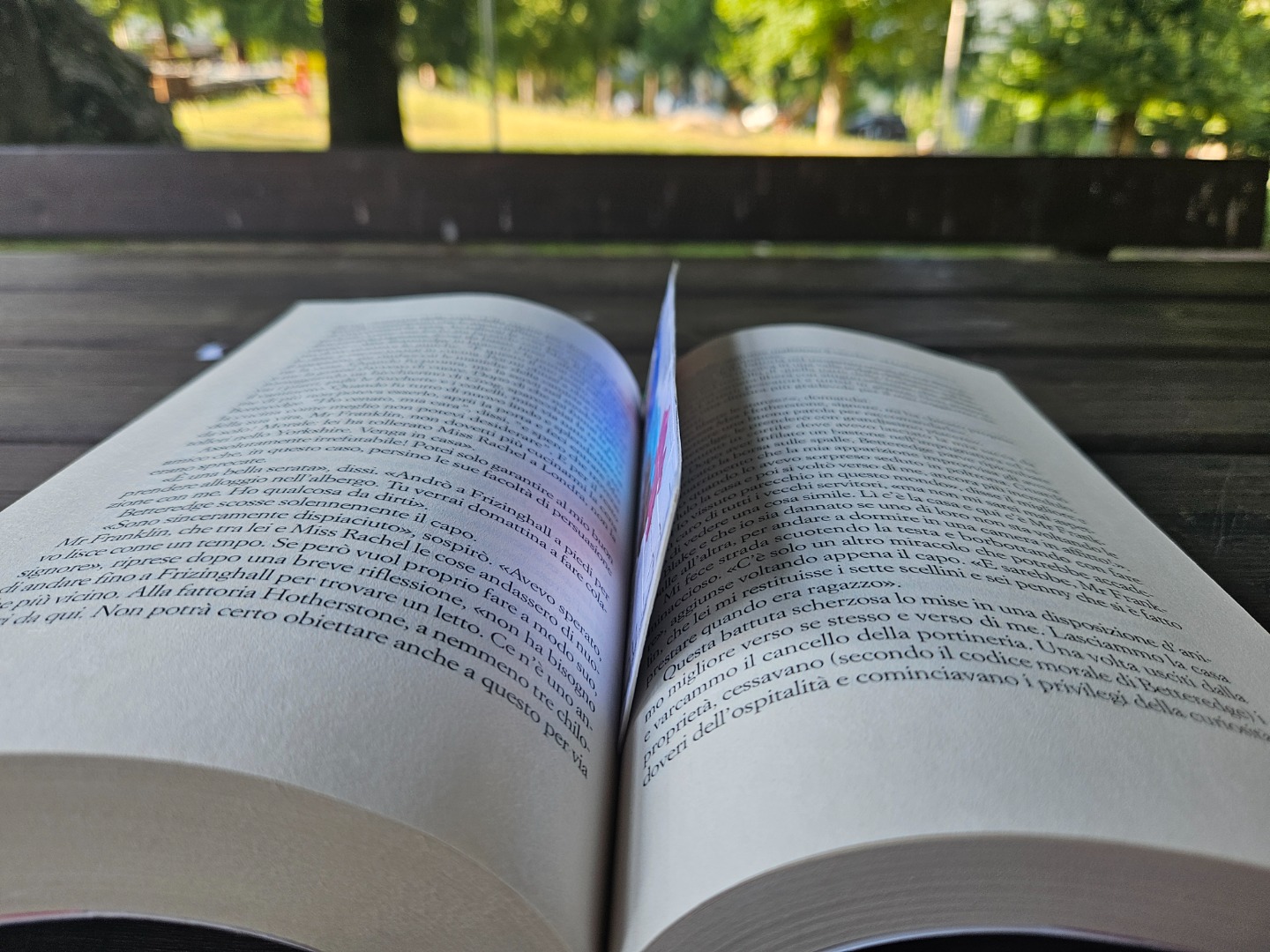 Venerdì, 23 Gennaio 2026 18:48
Da una parte c'è il più atroce dei delitti: l'omicidio. Dall'altra la pena (non il castigo, tramandato ...
Venerdì, 23 Gennaio 2026 18:48
Da una parte c'è il più atroce dei delitti: l'omicidio. Dall'altra la pena (non il castigo, tramandato ...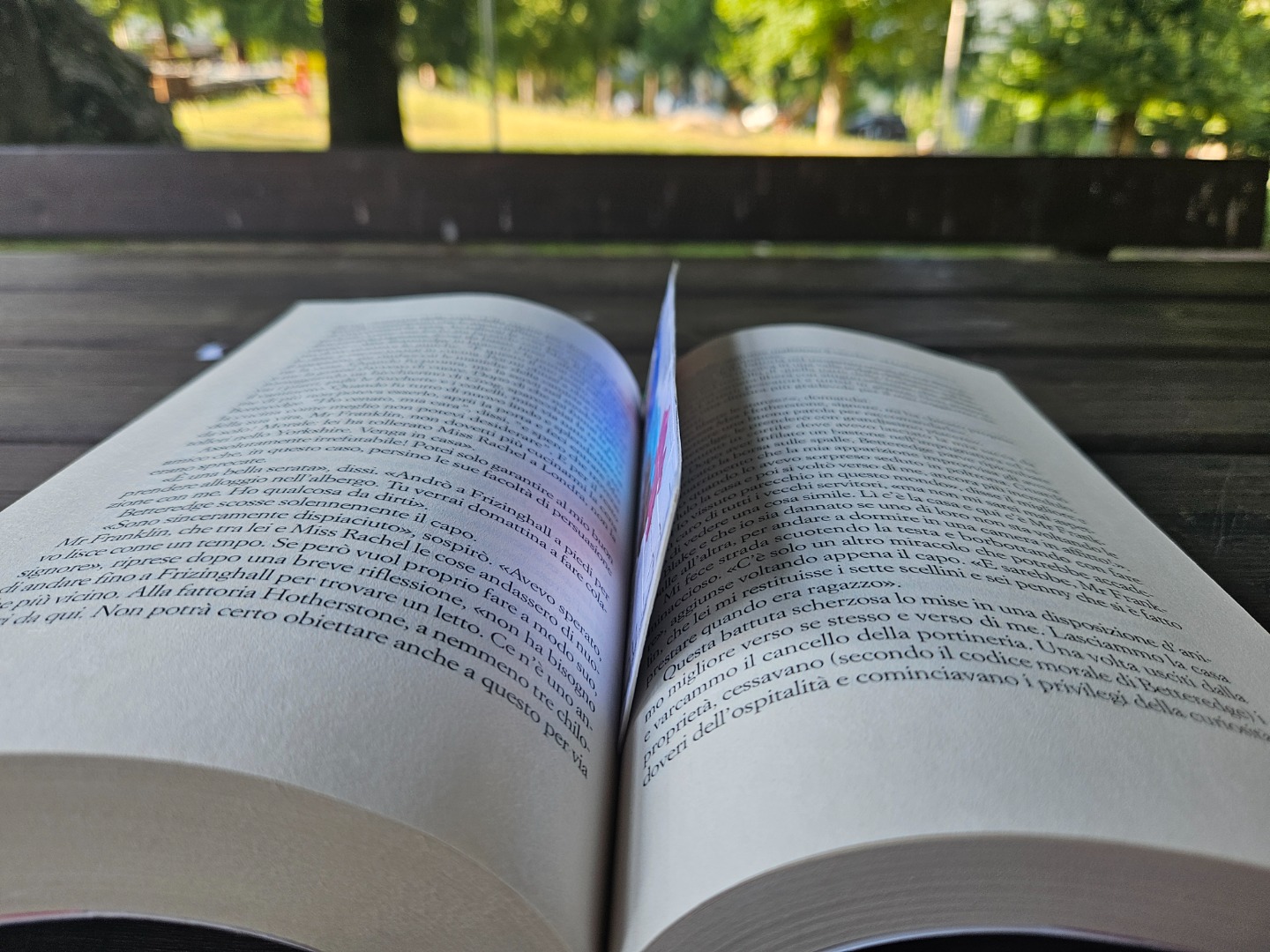 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...




