- Messaggi: 1
- Ringraziamenti ricevuti 0
Resoconto libro di Luglio: “Cecità” di José Saramago
Newsletter
Eventi
Shoutbox
Grande Pierbusa!!! Ciao! ![]()
Ciao Pietruzzo! Che bello risentirti!
E visto che ci sono un bacione a tutti i vecchi amici del club. ![]()
Buonasera a tutti. Sono Benny e voglio presentarmi a questa bella Comunità di cui ho apprezzato la passione per la lettura e l'impegno per il "sapere", non come curiosità, ma come arricchimento.
Ciao Alessandro, fai riferimento alle informazioni che trovi nella sezione del GdL di Napoli. Facci sapere. ![]()
Ciao, sono nuovo! Volevo chiedere quando fare incontro di lettura a Napoli ![]()
Buonasera mi sono appena unita al gruppo. Spero di partecipare presto agli incontri
Scalpo Fluente, con Mattia.P avevamo comunque deciso di leggerli entrambi e condividere una doppia moderazione, quindi se aspetti un po', con Le armi ci organizziamo per una lettura condivisa!
Ciao DarkMiryam! ![]()
Accedi per utilizzare la Shoutbox.
Raccolta fondi
Ultimi commenti
-
Delitto e castigo
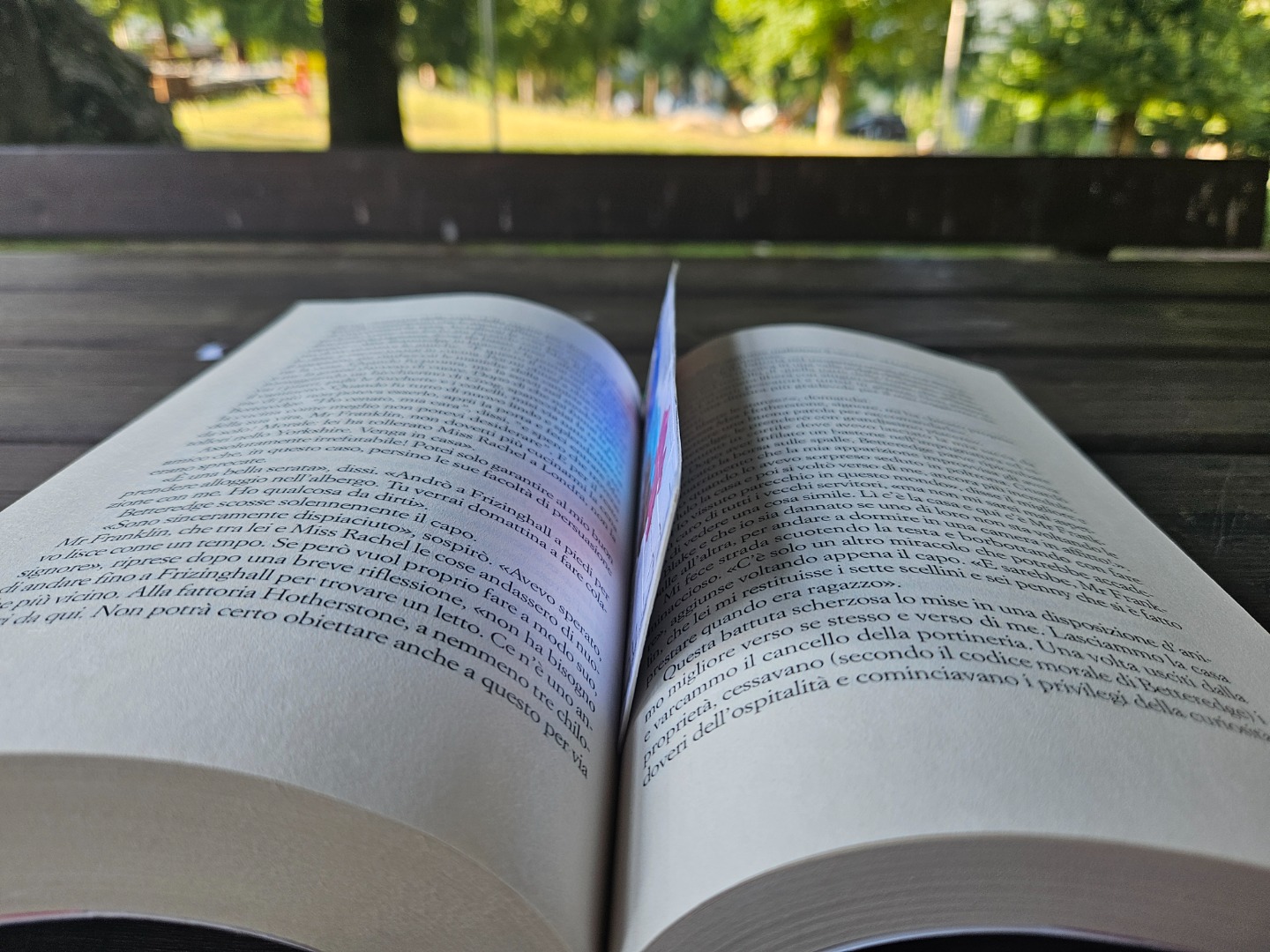 Venerdì, 23 Gennaio 2026 18:48
Da una parte c'è il più atroce dei delitti: l'omicidio. Dall'altra la pena (non il castigo, tramandato ...
Venerdì, 23 Gennaio 2026 18:48
Da una parte c'è il più atroce dei delitti: l'omicidio. Dall'altra la pena (non il castigo, tramandato ... -
Intermezzo
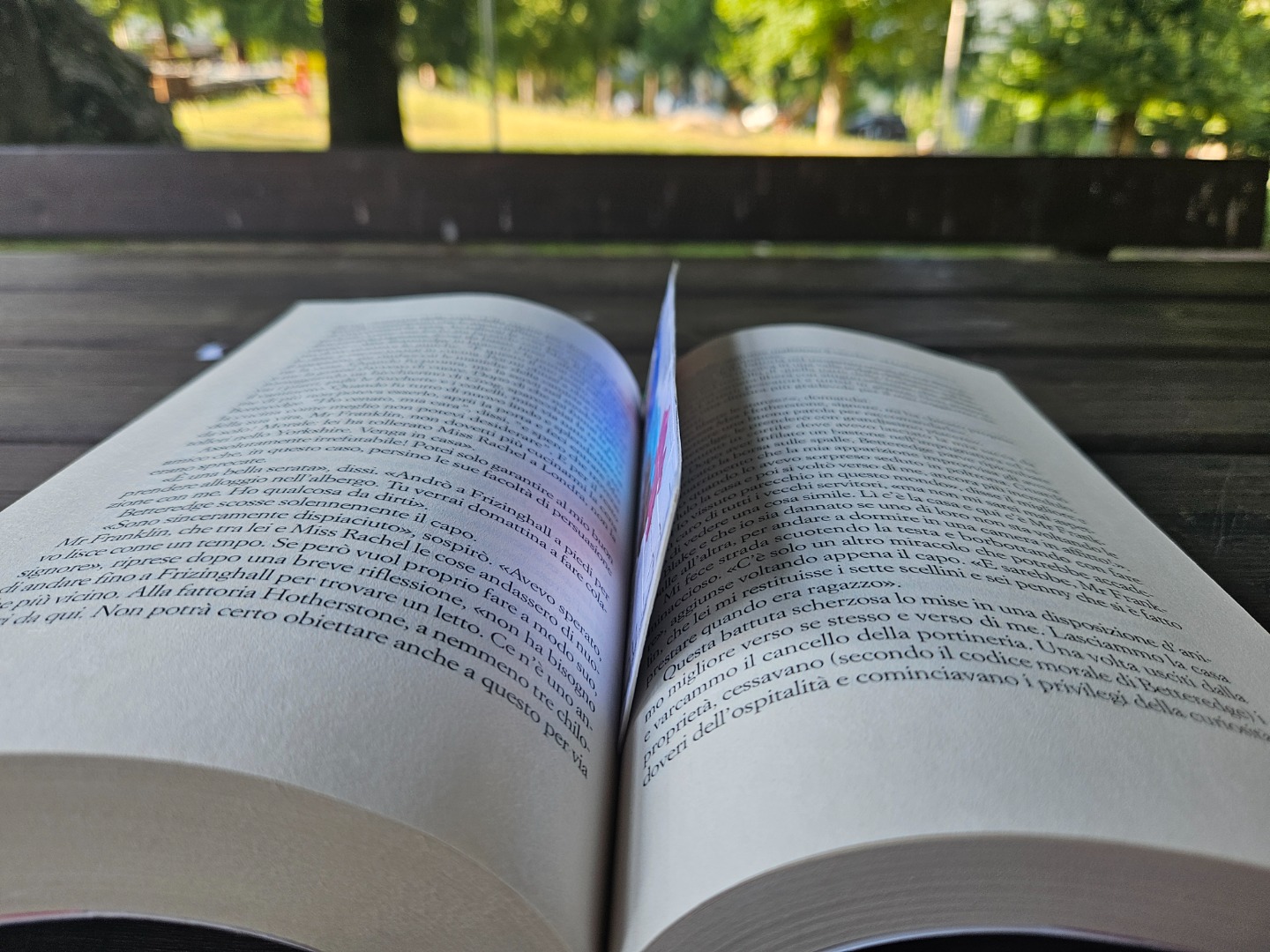 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. -
Luxnova. L'inizio
Martedì, 09 Dicembre 2025 12:36bellissimo e coinvolgente!!! -
Dentro il libro - Il deserto dei tartari e l'attesa del futuro: Dino Buzzati nell'era delle
 Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... -
Gruppo di lettura di Roma (LeggerMente Letturati) - Incontro di Novembre 2025
Sabato, 22 Novembre 2025 15:27Peccato questo l’ho perso.. grazie per la risposta!! A presto
ULTIME NOTIZIE
STATISTICHE
- Utenti registrati 10416
- Articoli 3256
- Visite agli articoli 7891836





