Domenica 6 aprile gli elefanti sono marciati da Magistro Caffè per discutere del libro "L'altra verità. Diario di una diversa", di Alda Merini.
Dopo la presentazione dei nuovi membri (ben 5 nuovi acquisti), la discussione è iniziata sin da subito con una grande certezza per tutti: la stragrande maggioranza non ha apprezzato la lettura. Giorgia, Emanuele, Maria, Antonio, Francesca e Mariateresa hanno trovato il libro noioso, ripetitivo e poco coinvolgente.
Molti non hanno percepito alcun trasporto emotivo rispetto alle vicende narrate, anche le più atroci, e questo ha giocato a sfavore della piacevolezza della lettura. Per Emanuele, questo può essere legato anche alla precisazione che la Merini fa rispetto agli eventi narrati: sono eventi verosimili, non veri, e pertanto potenziali frutti della fantasia dell’autrice. Martina T. non concorda appieno con questo punto di vista: ritiene infatti che proprio questa narrazione spersonalizzante permetta al lettore di riempire i “vuoti narrativi” con la propria emotività.
Fabio, Anna, Serena e Santi ritengono che questa mancanza di emotività sia da imputarsi ad una mancanza di metacognizione della Merini, legata ad anni di farmaci ed elettroshock che hanno appiattito la sua sfera emotiva. Serena ha concluso dicendo che è un desiderio del lettore quello di entrare nella mente di qualcuno altro, ma chi ha un trauma spesso non sa raccontare l’evento con la dovizia di particolari che noi vorremmo.
Rispetto alle capacità metacognitive della Merini, Anna e Lucrezia hanno notato una mancanza di oggettività nel modo in cui l’autrice racconta se stessa, soprattutto in relazione agli altri: in particolare, Alda tende a narrarsi come una persona buona, capitata in manicomio per sbaglio, e questo le fa spesso assumere un atteggiamento paternalistico verso gli altri internati (è come se dicesse: “Io non sono come voi, sono capitata qui per sbaglio, voi siete i pazzi veri invece”). In realtà, come dice Fabio, anche la Merini compie azioni di dubbia moralità, come appiccare un incendio; anche la Merini sarebbe dunque “cattiva”, e in stato psichico alterato tanto quanto gli altri; semplicemente, non se lo riconosce, e questo si vede anche dallo spazio che viene dedicato alla narrazione di questi eventi (una riga scarsa).
Martina, non completamente concorde, punta l’attenzione sui numerosi momenti di empatia presenti nel testo, come quello in cui la donna anziana schiaffeggia Alda e lei la abbraccia per rassicurarla. Per alcuni questi stralci sono da vedere con tenerezza; per altri, potrebbero essere interpretati come un’ennesima dimostrazione dell’atteggiamento paternalistico dell’autrice. Per dirimere la querelle, Francesca fornisce un punto di vista super partes: la cattiveria degli altri non è né reale né morale, ma è una narrazione dell’abbrutimento del genere umano in condizioni disumanizzanti come il manicomio.
Di fronte a questo degrado, solo una cosa sembra poter salvare la Merini: l’amore. Il gruppo si è brevemente soffermato sulla figura di Pierre, che come dice Mariateresa è per Alda l’aggancio con l’umanità. Marco ha notato che le numerosi narrazioni a sfondo sessuale possono essere lette come tentativi della Merini di ricevere contatto e conforto dall’altro.
Anna nota pure una tendenza dell’autrice ad infantilizzare tutti. Secondo Martina T., ciò è da vedersi come una ricerca dell’infanzia come luogo di candore e purezza perduti, talmente intimi che nessuno può portarli via. Questo potrebbe essere visto, per alcuni membri del gruppo, come una strategia per fronteggiare il trauma che affonda le radici nell’infanzia, e in particolare nel rapporto dell’autrice con la propria madre. Come detto da Serena, ai tempi non si aveva l’idea che un cattivo rapporto con le figure genitoriali potesse costituire un trauma da sanare, e pertanto, come giustamente notato da Santi, la Merini si è mossa lungo tutta la sua vita alla ricerca di metodi per superari il trauma, senza tuttavia mai riuscirci. Rispetto a ciò, una cosa è piaciuta a tutti: la scelta del dottor G di donare ad Alda una macchina da scrivere come atto terapeutico. Come dice Martina T., la poesia ricuce gli strappi dell’identità, ed è certamente stato uno strumento utile per la Merini per esprimere il proprio irrisolto.
Il gruppo si è indagato sulla collocazione di “L’altra verità” entro un genere letterario, ma non siamo venuti a capo di questo punto: è un diario? È un saggio? È un memoir? Santi, Fabio e Martina danno una risposta che ha convinto quasi tutti: è un resoconto di un evento accaduto; una cronaca delle giornate della Merini in manicomio, scritta di getto dall’autrice senza nessuna elaborazione.
Di fronte a questa “confusione letteraria”, ci siamo chiesti: forse l’editor avrebbe dovuto intervenire per rendere più godibile la lettura? Secondo Antonio e Lucrezia assolutamente sì; secondo Anna e Loredana la struttura ripetitiva potrebbe invece essere una scelta editoriale ben precisa per comprendere l’alienazione del contesto manicomiale: in manicomio, in fondo, vige il tempo dell’eterno ritorno, e tutti i giorni sono uguali.
Mariateresa ha comunque trovato il linguaggio molto bello, e non possiamo che concordare tutti visto le molte citazioni che siamo riusciti a trarre da “L’altra verità”.
Per alcuni le poesie erano la parte migliore del libro; per altri, anche le poesie erano da bocciare. Marco ha offerto una visione pacificatrice: “L’alta verità” è una poesia in prosa, che offre pennellate poetiche di pregio.
Di fronte a un libro del genere, era impossibile non cadere nella riflessione socio-culturale. Lucrezia afferma che “L’altra verità” è un libro più importante che bello, e Serena e Paola concordano: è un libro che andava letto, perché offre uno spaccato di ciò che stato prima della legge Basaglia. “L’altra verità” apparirebbe dunque un libro arido, emotivamente povero, ma coerente al periodo storico, che fa riflettere anche sui risvolti dell’istituzionalizzazione e della spersonalizzazione. Per Francesca e Serena, il libro è una denuncia non alla diagnosi, bensì al metodo di cura: nei manicomi tutti erano immessi nello stesso calderone, e a tutti venivano offerti gli stessi trattamenti, indipendentemente dalle loro reali esigenze.
Abbiamo fatto un parallelismo tra ieri e oggi, e l’amarezza è stata grande: come detto da Fabio, Loredana e Matteo, ancora oggi il più fragile viene svalutato e isolato; anche noi abbiamo difficoltà a venire incontro all’altro, soprattutto se malato. Per chi soffre di una malattia psichica, è difficile la socialità ed è difficile il reintegro; le persone con malattie psichiche vengono spesso respinte dalla società, e Alda Merini ce lo ricorda quando dice di dover andare a “rompere le scatole” alla gente per avere un po’ di compagnia. Matteo ha offerto una comparazione tra i manicomi di ieri e alcune RSA per anziani di oggi, decisamente molto attuale.
Concludendo questo resoconto, nonostante la ricca discussione tante domande sono rimaste nell’aria: cosa è malattia e cosa è legato al contesto? Chi può dirsi sano e chi malato? Cos’è l’umano? Come detto da Emanuele: il libro non ha dato molti spunti di riflessione autonomi, ma ringraziamo la discussione di gruppo perché siamo andati via riflettendo.
La prossima riunione della Marcia si terrà domenica 4 maggio, e il libro votato è “Babel”, di R.F. Kuang, proposto da Paola. A presto!
![]()
![]()
![]()
![]()
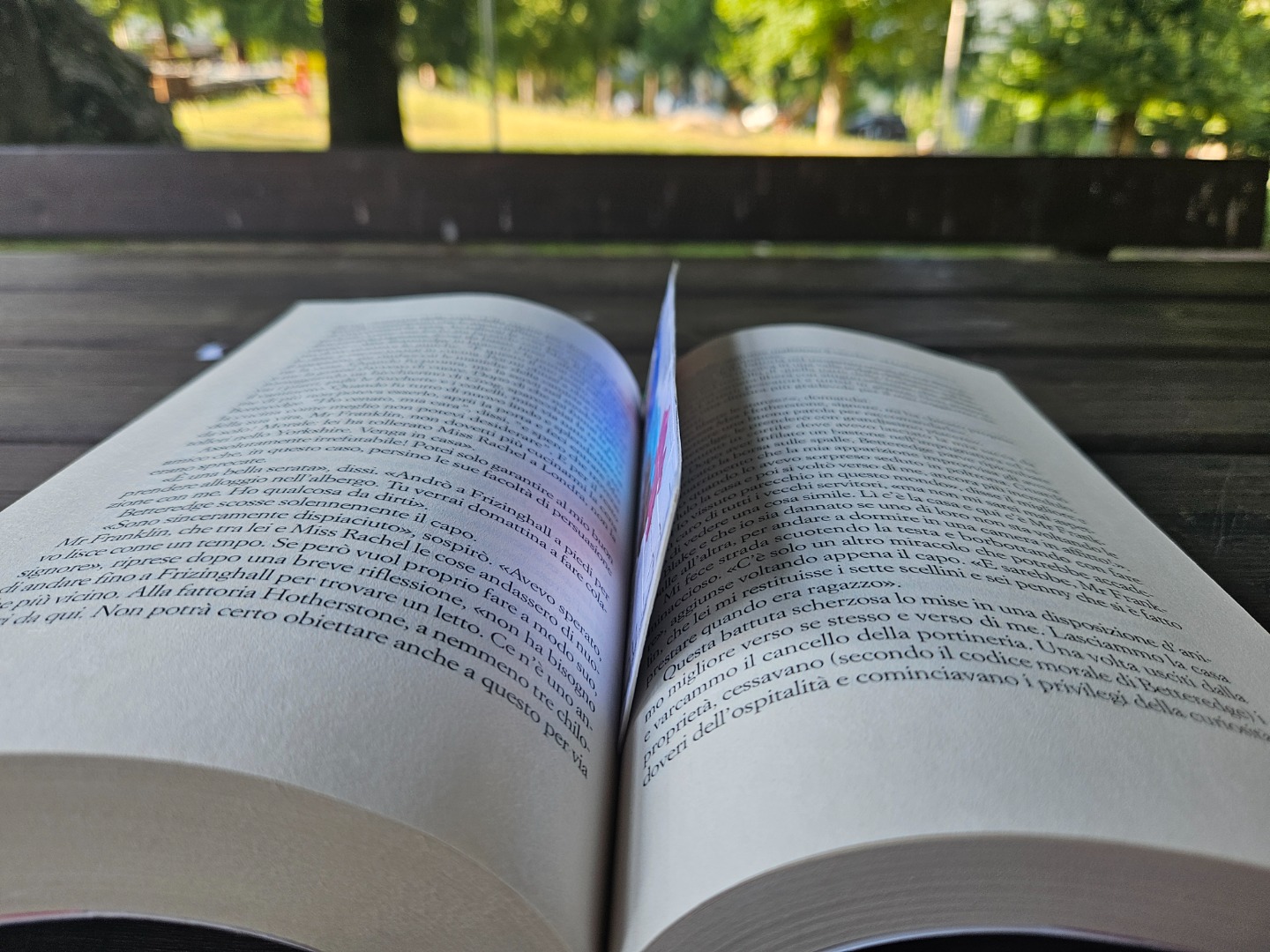 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano





