“Stesso posto, stesso bar …” con una quota rosa, uno studente e un lettore dai turni impossibili a far da spalla a Ciro, Giuseppe e Alberto (stavolta presente in carne ed ossa!). La storia invece non è la stessa e se un ragazzo di 17 anni prende un treno da Agrigento e poi un autobus, per raggiungere dopo tre ore il gruppo, non è forse una storia nella storia? Nuove conoscenze e riti di iniziazione a parte (sto qui a scrivere il resoconto, ahinoi!), è doveroso ammettere che il tempo è volato e la discussione è stata davvero stimolante, vuoi anche un Levi decisamente differente e forse ottimista.La chiave a stella non è un semplice libro sul lavoro. In un mondo fatto di tralicci, ciminiere, bulloni e tempo instabile, paesi vicini e lontani, si compie un viaggio attraverso l’animo umano tra orgoglio, responsabilità e fragilità. Partendo dal tema dominante, sintetizzato da Ciro, ci siamo ritrovati dinanzi un dialogo autentico e aperto tra due uomini che si rispettano: uno racconta con schiettezza la propria vita in giro per il mondo da operaio specializzato, ruolo centrale nell’industria e nell’epoca di riferimento; l’altro ascolta con attenzione e rispetto, restituendogli parola, valore, senso. Siamo tutti concordi sul fatto che Faussone ha una visione del lavoro profonda: ogni derrick o traliccio montato, ogni problema risolto, rappresenta una piccola vittoria personale, una prova di valore. In lui non c’è alienazione, ma coinvolgimento. Il lavoro, anche se duro e a volte solitario, dà senso alla sua vita.Per Alessandro, questo non è un libro che si legge solo con la mente. La chiave a stella si legge anche con le mani e con il cuore. È un romanzo fatto di ingranaggi, strutture, dita indurite, ma soprattutto di orgoglio. Quell’orgoglio che nasce non dal “successo” ma dal saper fare bene qualcosa, dal lasciare una traccia concreta, magari invisibile, nel mondo. Leggerlo ha permesso di dar voce al proprio padre, lavoratore indefesso da una vita, orgoglio del figlio che ne ha seguito le orme. Per Tommaso, la voce è del nonno. Quello che ha colpito Giuseppe è l’assoluta mancanza di retorica. Il lavoro non è inteso come dovere morale o come status affinché si possa far coincidere l’equazione “lavoro uguale dignità umana”. È una possibilità di senso, di compiutezza personale non l’identità stessa. Inevitabile l’attualizzazione: oggi si lavora per necessità e, a volte, si sceglie di andare altrove, come ha fatto Alberto. I riferimenti ai tempi antichi emersi durante la chiacchierata e a cui fa eco l’inno di Faussone - lavoro manuale, competenza e responsabilità individuale - sono per tutti noi un plus ma stridenti in questo presente dove il lavoro tende all’astratto e l’Intelligenza Artificiale esegue, ma non sente. La chiave a stella, di rimando, non ci ricorda forse che esiste la possibilità di amare quello che si fa? L’aver affrontato qualcosa e averlo risolto non è essenza stessa della felicità? Il lavoro è il filo conduttore, certo. Eppure ciò che si intreccia sotto, come una saldatura che regge l’impalcatura, è molto di più: è la vita vissuta che si palesa in tutta la sua poliedricità.
C’è l’amore testardo e concreto per il proprio lavoro, fatto di competenza, impegno, desiderio di lasciare qualcosa che “tenga”.
C’è l’amore libertino, breve, fugace ma motivo di distrazione.
C’è il rapporto padre-figlio, tra chi insegna e chi riceve, tra esperienza e ascolto, tra generazioni che si parlano con semplicità o che non si capiscono se non dopo tempo.
Ci sono le gerarchie professionali,percepite da Faussone con sguardo ironico ma critico: il rispetto si guadagna sul campo, non con il titolo.
C’è la volontà di dare il giusto peso all’etica del lavoro onesto a fronte di pressioni o sabotaggi. Faussone non è infallibile, ma nella sua vulnerabilità risiede la sua grandezza: sbaglia, si arrabbia, si prende la responsabilità e cresce.
E poi ci sono tocchi lievi, quasi nascosti: le zie e il loro tempo cristallizzato, i riti e i valori antichi, la memoria familiare che resta dentro anche quando si è a migliaia di chilometri da casa. Faussone è figlio di un’Italia fatta di mani, di fatica, di storie tramandate a voce.Infine c’è anche poesia: ce lo ricorda Tommaso. Tante brevi frasi incorniciano la narrazione con delicatezza e semplicità disarmante. Faussone dice: “L’ho fatta io. E tiene.” E in questa frase c’è tutta la felicità possibile. Quella vera. Quella che nasce quando ci si riconosce veramente in qualcosa.P.s. Per gli esperti di chiavi a stella del gruppo, operate le dovute analisi del caso, resta contraddittoria la presenza dello strumento alla cintura del nostro protagonista. Che sia un passepartout della libertà o la sua coperta di Linus?
![]()
![]()
![]()
![]()
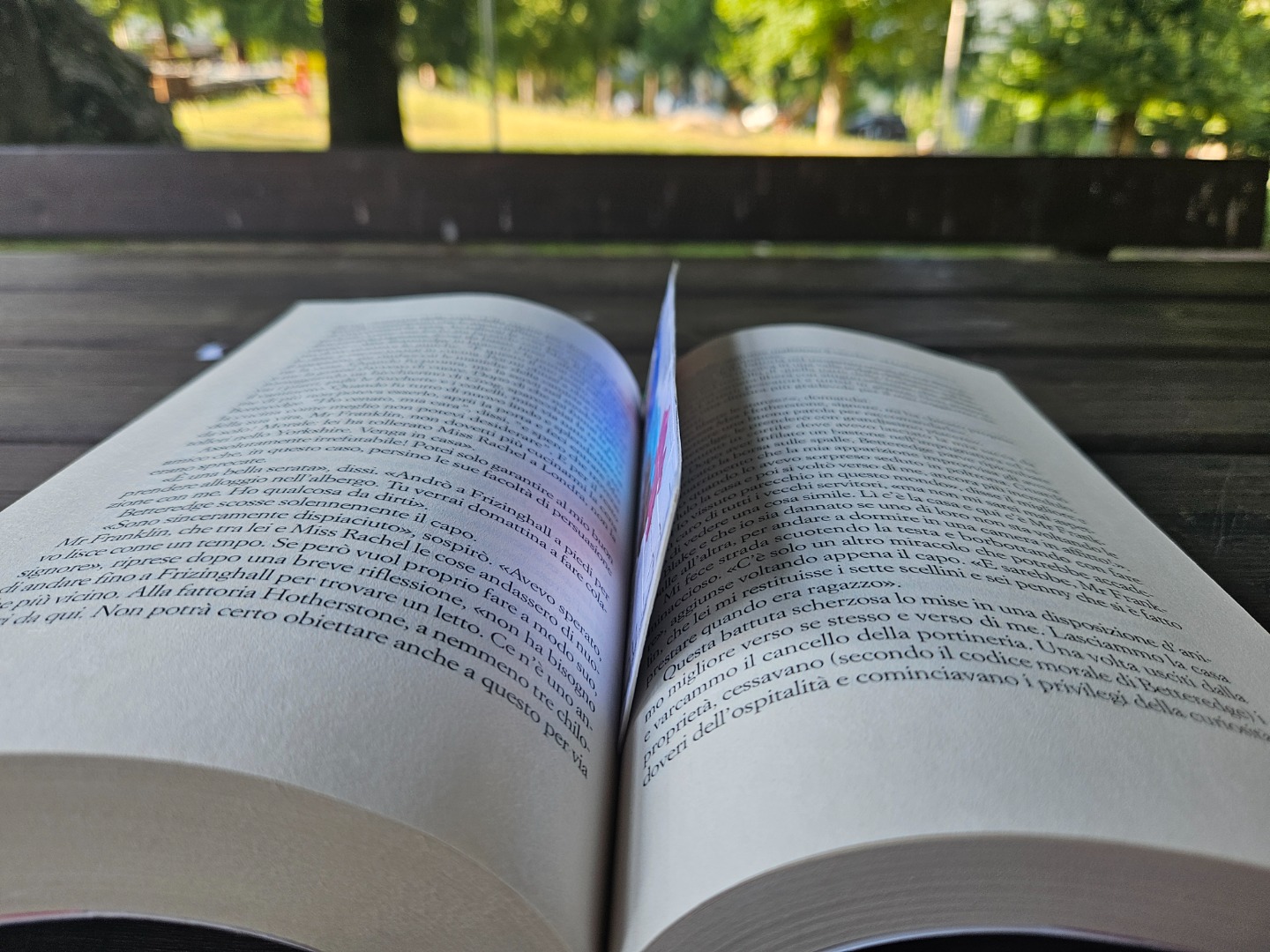 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano





