SINOSSI
Siamo in Sicilia, all'epoca del tramonto borbonico: è di scena una famiglia della più alta aristocrazia isolana, colta nel momento rivelatore del trapasso di regime, mentre già incalzano i tempi nuovi (dall'anno dell'impresa dei Mille di Garibaldi la storia si prolunga fino ai primordi del Novecento). Accentrato quasi interamente intorno a un solo personaggio, il principe Fabrizio Salina, il romanzo, lirico e critico insieme, ben poco concede all'intreccio e al romanzesco tanto cari alla narrativa dell'Ottocento. L'immagine della Sicilia che invece ci offre è un'immagine viva, animata da uno spirito alacre e modernissimo, ampiamente consapevole della problematica storica e politica contemporanea.
RECENSIONE
Il Gattopardo, considerato un capolavoro della letteratura italiana, è un libro di straordinaria bellezza dal punto di vista stilistico. Il linguaggio sontuoso, raffinato, colto e ricercato, è l'espressione dell'aristocrazia italiana dell'Ottocento. La narrazione si svolge in Sicilia a partire dal 1860, nel momento di passaggio dal regno borbonico al regno piemontese. Protagonista è il Principe Fabrizio Salina che assiste al cambiamento politico e sociale in atto, che porta a far emergere la classe sociale della borghesia (nel romanzo rappresentata da Sedara, sindaco di Donnafugata) e al declino della nobiltà. Tuttavia il Principe è un uomo disilluso e crede che nonostante stia cambiando tutto, in Sicilia nulla cambierà, perché i Siciliani, dominati per secoli, non sono mai cambiati e non cambieranno di certo con l'arrivo dei Piemontesi. Il pensiero del Principe incarna in realtà il pensiero dell'autore, che descrive i Siciliani come avvolti dal torpore e una Sicilia che non vuole essere svegliata. Il perchè di tale atteggiamento, a dire dell'autore tipico siciliano, il Principe Fabrizio lo attribuisce a vari fattori, primo fra tutti le dominazioni straniere che per secoli hanno caratterizzato l'isola. Fa da controaltare al pensiero del Principe quello del nipote prediletto Tancredi, pronto invece a credere al cambiamento e ad avere un ruolo attivo nella nuova vita politica e sociale della Sicilia. Tomasi di Lampedusa con il suo stile meraviglioso ci regala descrizioni memorabili di palazzi e dipinti. I personaggi sono tutti ben caratterizzanti, finanche il cane Bendicò, figura da non sottovalutare che, a mio avviso, l'autore utilizza per descrivere la parabola dell'aristocrazia italiana.
[RECENSIONE A CURA DI NAUTILUS]
| Autore | Giuseppe Tomasi di Lampedusa |
| Editore | Feltrinelli |
| Pagine | 299 |
| Anno edizione | 2013 |
| Collana | Universale economica |
| ISBN-10(13) | 9788807883828 |
| Prezzo di copertina | 9,50 € |
| Prezzo e-book | 6,99 € |
| Categoria | Classico - D'ambiente - Storico |





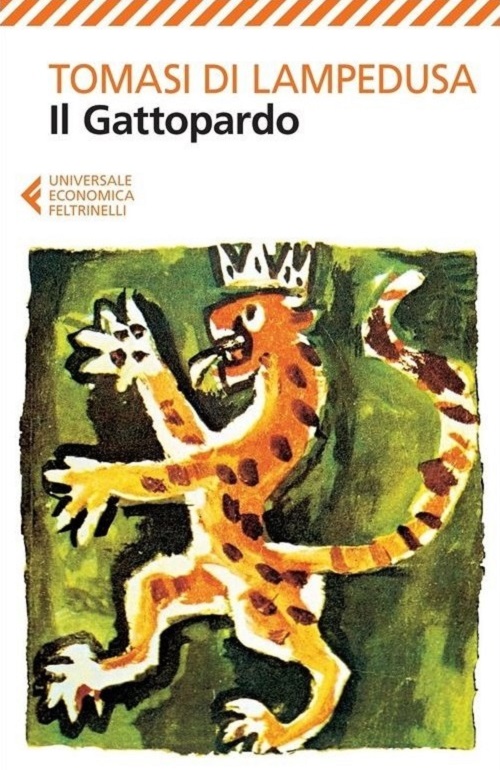

Commenti
Ci sono romanzi che raccontano storie. E poi c’è Il Gattopardo, che racconta la Storia. Ma non lo fa con la retorica degli eroi o la cronaca degli eventi: Giuseppe Tomasi di Lampedusa ci regala, con questo libro postumo ancora oggi amatissimo dai lettori, un’elegia del tempo che scorre, un canto funebre dedicato a un mondo che scompare, non con uno schianto ma con un lungo, sontuoso tramonto.
Siamo in Sicilia, 1860. Il Regno delle Due Sicilie sta per cedere il passo all’Italia unita, i garibaldini sbarcano a Marsala, e il Principe Fabrizio di Salina, aristocratico lucido e disilluso, osserva il cambiamento con l’occhio di chi sa già che non è un vero rinnovamento, ma solo un passaggio di testimone. La sua disillusione emerge in modo straordinario nell’incontro con Chevalley, l’emissario del nuovo Stato italiano che gli propone un seggio da senatore. Don Fabrizio rifiuta, tracciando un ritratto indimenticabile della Sicilia e della sua gente, descritta come apatica, fatalista e priva di speranza nel cambiamento: “La loro vanità è più forte della loro miseria.”
Il romanzo – e qui sta il suo cuore pulsante – non è mai ideologico, né nostalgico. Il Principe non è un eroe tragico, ma un uomo consapevole della fine imminente: della sua casata, della sua classe, del suo mondo. Lo accetta senza combattere, anzi con una malinconia quasi filosofica, come chi osserva le stelle sapendo che la luce che vede è già passata. La sua figura incarna una nobiltà che ha stile e cultura, ma che è stanca, svuotata, irrimediabilmente distante dalla realtà che avanza.
In questo scenario, Tomasi di Lampedusa introduce personaggi memorabili, ognuno simbolo di una transizione. Tancredi, nipote brillante e camaleontico, che incarna il trasformismo politico e sociale, è la nobiltà giovane e opportunista, pronta ad allearsi con la nuova borghesia pur di restare a galla. Il suo celebre aforisma – “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” – è il manifesto di un trasformismo tutto italiano, di un’astuzia sociale che prende il posto dell’ideale.
Angelica, bellissima e magnetica, insieme al padre, l’arricchito don Calogero Sedàra, rappresentano invece l’ascesa della borghesia. Grezza nei modi, priva di raffinatezza ma dotata di una forza prorompente, questa nuova classe sociale irrompe sulla scena non con eleganza, ma con decisione facendo leva su quelli che sembrano essere i nuovi valori: l’ostentazione della beltà e della ricchezza che, unitamente ad una feroce determinazione, sono gli ingredienti per salire al potere in una Italia che cambia.
Ma ciò che rende Il Gattopardo un capolavoro oltre la trama e i simbolismi, è la sua scrittura. Tomasi di Lampedusa ha un talento quasi cinematografico nel dipingere scene con una precisione sensoriale rara nella letteratura italiana. Le descrizioni non sono mai statiche: sono dense, vive, piene di odori, suoni, superfici, luci. Si pensi alla scena della caccia: il calore secco, la polvere, il fremito del coniglio morente tra le mani del Principe. una scena cruda che diventa metafora della storia umana, dove i più deboli soccombono mentre i potenti provano al contempo piacere e indifferente compassione.
O ancora, la scena in cui don Fabrizio scende nel giardino del palazzo di Donnafugata, immerso nella calura del pomeriggio. È un momento sospeso, quasi sacro: il corpo del Principe si muove tra le piante come un’ombra ormai estranea alla vita. Le foglie, il sudore, il silenzio che avvolge tutto: Tomasi sa rendere fisico, palpabile, quel senso di disfacimento che attraversa il libro.
Il Gattopardo è un romanzo sul potere che muore, ma anche sulla bellezza che resiste. È la storia di una Sicilia che cambia per non cambiare, di un’Italia che nasce vecchia, di un’aristocrazia che svanisce lasciando il posto a una borghesia senza grazia. Ma è anche, e forse soprattutto, una meditazione profonda sul tempo, sulla memoria, sull’identità.
Alla fine del romanzo, il declino della famiglia Salina si compie con la morte del principe e il progressivo sgretolarsi del suo mondo. L’ultima scena, con il corpo imbalsamato di Bendicò, il cane amato da Fabrizio, che Concetta getta via come un vecchio oggetto senza valore, segna la rivincita di Concetta stessa che taglia definitivamente con un passato che l’ha vista soccombere alle volontà paterne e, nel contempo, chiude il cerchio con una potente immagine della fine di un’epoca.
Rileggendolo oggi, in un’epoca in cui i confini tra classi, ruoli e poteri sono più fluidi ma non meno rigidi, Il Gattopardo resta un’opera attualissima. Ci ricorda che ogni cambiamento porta con sé un’illusione di rinnovamento, e che spesso, dietro la promessa di un mondo nuovo, si nasconde l’ombra lunga di ciò che non è mai davvero finito.