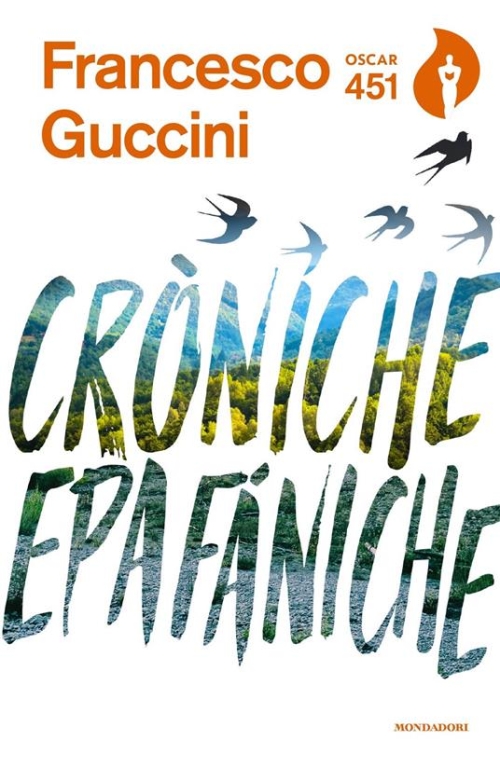SINOSSI
"La ballata più lunga e appassionata di Francesco Guccini." Così nel 1989 Stefano Benni salutava l'uscita di queste "Cròniche epafániche": una vera e propria rivelazione, l'atto di nascita di un talentuoso scrittore fino allora conosciuto solo come insuperabile cantautore. Romanzo se non proprio autobiografico, certo di forte ispirazione autobiografica, le Cròniche riescono a restituire, nel fluire degli aneddoti e delle storie, nella lingua intessuta di termini dialettali e di colore, tutto il sapore di una mitologia di luoghi e affetti personale e familiare, senza retorica ma con toni che sanno alternare la commozione all'ironia, la rievocazione di episodi storici e la fantasia. Il racconto di un'infanzia e una giovinezza maturate in un paesaggio di mezza montagna tra Emilia e Toscana, dagli anni Quaranta in poi, veste così gli abiti dell'epica e della poesia, della cronaca picaresca e del puro divertimento, in quelle che un grande conterraneo di Guccini come Roberto Roversi ha definito "pagine da leggere, da vedere, da immaginare, da ascoltare".
RECENSIONE
Francesco Guccini non sarà ricordato solo come uno dei più grandi cantautori italiani di sempre, ma anche come prolifico e talentuoso scrittore. Cròniche epafániche è il suo romanzo d'esordio, pubblicato in origine per Feltrinelli nel 1989 e recentemente riproposto da Mondadori. Il titolo, innanzitutto, merita una breve riflessione, non tanto per il ricercato e letterario "Cròniche" (con la "i"), quanto per l'ambiguo aggettivo "epafániche", che richiama l'idea della rivelazione, ma al contempo rimanda a Pavana, il paesello tra i monti dell'Appennino tosco-emiliano, in provincia di Pistoia, dove l'autore trascorse l'infanzia (sfollato a causa della guerra), e dove risiede tuttora, ormai da anni. Dunque, cronache pavanesi, potremmo concludere; ma anche un racconto che in un certo senso rivela l'importanza, per Guccini, delle radici montanare.
Il libro, va detto, non è facile da leggere per via della lingua utilizzata: un'autentica invenzione dell'autore, che mescola l'italiano parlato con il dialetto pavanese. Ne esce, paradossalmente (trattandosi di un artificio letterario), una sensazione di autenticità, come se i personaggi del racconto dialogassero apertamente con il lettore. L'ultima sezione del volume è una sorta di agile glossario (anche se Guccini rifiuta questo termine) per chiarire il significato delle parole «che possono suonare misteriose a orecchie a volte toscane a volte padane (siam nel mezzo!)» (p. 209); ma è bene precisare che lo strumento, per quanto indispensabile, non è sufficiente a far luce su tutti i misteri del lessico gucciniano. Occorre pazienza, insomma, possibilmente unita a una sana curiosità. Lo sforzo richiesto dall'autore è però ampiamente ripagato allorché si riesca ad addentrarsi nella narrazione. Guccini racconta la sua infanzia presso i nonni paterni a Pavana; il padre è sotto le armi, e Modena non è un posto altrettanto sicuro. Nel ricordo di un bambino, il paese sugli Appennini diventa un mondo a sé, che finisce oltre la strada che delimita il territorio accessibile e conosciuto. A Pavana c'è il mulino dei nonni, che Guccini descrive minuziosamente; ma c'è anche il fiume (il Limentra), autentico 'protagonista geografico' del romanzo, luogo di magiche avventure, sogni e divertimenti. Ogni dettaglio della vita di montagna è ricordato con la dolcezza e la nostalgia di chi è consapevole che un'autentica civiltà (fatta di lavoro, premure, abitudini secolari, sacrifici, ma anche libertà oggi impensabili) è tramontata per sempre. Accanto alla commozione, non manca peraltro l'ironia. Si legga l'incipit del capitolo 11: «Il gabinetto si può chiamare in tanti modi; cesso per dirne una, o latrina, come dice Nonnamabìlia, o lìscite, o anche lógo cómmodo, e questa non si capisce un gran ché, perché comodo non è proprio per niente» (p. 142). Segue la descrizione accurata di cosa volesse dire, nei primi anni Quaranta (o anche in seguito, durante le vacanze estive che l'autore considera come una liberazione, una volta rientrato a Modena nel dopoguerra), fare i propri bisogni in un contesto come quello di Pavana, senza tutti gli agi (leggasi anche, banalmente, l'acqua corrente) che noi oggi diamo per scontati. Tra le storie narrate nel libro ritroviamo poi anche, sparse qua e là, alcune chicche per gli amanti delle ballate gucciniane. Come la precisazione riguardante il celebre Amerigo (quello che, nella canzone omonima, «probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde», per poi lasciare il paese ed emigrare in America), che in realtà si chiamava Enrico; per metatesi, il nome veniva da tutti storpiato in Nerico, in dialetto Merigo, e quindi, nella canzone, Amerigo, considerando letterariamente la sua destinazione (p. 68). Curiosa e divertente, infine, l'incredulità dei parenti anziani di fronte al giovane Francesco che a letto, anziché dormire, legge (p. 128). Aneddoto che ritroviamo all'inizio di "Canzone di notte n. 4", con il rimprovero, in dialetto pavanese: «E alora, accident'a ti, vot spegner cl'a luse, che a letto andam per dormire, mia per leggere!». Il libro si conclude all'insegna della nostalgia, con l'ingresso in scena di un ultimo, affascinante personaggio: Dante detto Poldo, cuoco nelle sagre popolari, alcolizzato, uso a smaltire le sbornie dialogando con i morti del cimitero, per raccontare loro com'è cambiato, radicalmente e irrimediabilmente, il paese (pp. 203-207).
[RECENSIONE A CURA DI GIGIMALA]
| Autore | Francesco Guccini |
| Editore | Mondadori |
| Pagine | 240 |
| Anno edizione | 2019 |
| Collana | Oscar 451 |
| ISBN-10(13) | 9788804704256 |
| Prezzo di copertina | 13,00 € |
| Prezzo e-book | 7,99 € |
| Categoria | Contemporaneo - Attualità - Sociale - Psicologico |