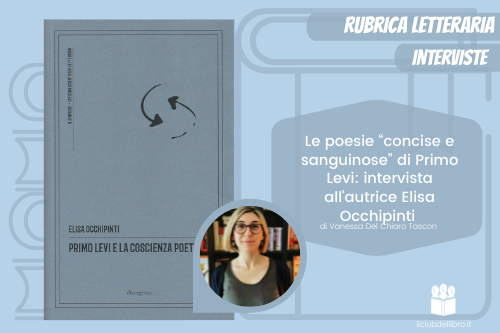
Elisa Occhipinti, dopo il suo primo romanzo E lucevan le stelle (2018, Miraggi Edizioni), torna a sorprenderci con un saggio su un autore italiano di grandissima importanza nella letteratura della Shoah, osservato da un'angolazione diversa. Dal suo nuovo libro Primo Levi e la coscienza poetica (2021, Divergenze) si evince una forte sensibilità dell'autrice verso il periodo e le tematiche che riguardano l'Olocausto. Il ricordo assume un aspetto importante, lo stesso Levi avverte le menti a ricordare, a non rimanere sopite: "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre".
Così il libro di Elisa ci riporta nella dimensione del ricordo ma non solo: nella dimensione del pensiero e dell'analisi profonda della poesia leviana, concentrandosi sui componimenti che riguardano Auschwitz e sui loro legami con la prosa, in particolare proprio con la Trilogia della Shoah.
Elisa, come ti sei avvicinata alla figura di Primo Levi?
Essendo torinese ed essendomi interessata sin da bambina alla Shoah, Primo Levi mi ha accompagnata praticamente da sempre. L'ho letto a scuola, l'ho riletto da adulta. La sua presenza è stata discreta – d'altronde, noi sabaudi siamo fatti così – ma costante. Abbiamo perfino condiviso gli stessi luoghi: penso a Torino, a Corso Re Umberto, ad Avigliana. Nel saggio c'è una breve appendice in cui racconto la sua genesi, il "dietro le quinte": è scrivendola che ho preso coscienza per la prima volta di tutto questo.
Perché secondo te è importante parlare della poesia di questo autore?
La poesia di Primo Levi è molto poco conosciuta e i pochi che ne hanno parlato lo hanno fatto per lo più in contesti accademici che non hanno potuto o saputo raggiungere un pubblico più vasto. Io stessa, nonostante lo conoscessi da sempre e abbia studiato Letteratura, ho scoperto l'esistenza di un Levi-poeta solamente alla soglia dei trent'anni. Levi è uno dei rappresentanti principali della letteratura della Shoah, Se questo è un uomo viene letto nelle scuole, ma quasi sempre si tralascia questo aspetto fondamentale: la sua prosa nasce proprio dalla poesia. Prosa e poesia sono talmente intrecciate da essere indivisibili, sono complementari e necessarie l'una all'altra. Solo tenendo conto di entrambe si può avere un'immagine completa e fedele dell'autore.
Nel tuo libro citi alcune parole dell'autore: "dopo Auschwitz non si può più fare poesia se non su Auschwitz". Cosa puoi dirci di questa necessità di Primo Levi di raccontare tramite la poesia quel periodo?
Questa frase si inserisce nel contesto di un dibattito sorto nel Dopoguerra sulla rappresentabilità della Shoah, avviato da Adorno con la celebre affermazione "Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie". Levi, sopravvissuto al lager, ha sentito sin da subito fortissimo il bisogno – e il dovere – di testimoniare e lo ha fatto innanzitutto attraverso la poesia. Lui stesso afferma che la poesia gli è sembrata più adatta della prosa per esprimere ciò che gli pesava dentro e ha definito le sue poesie "concise e sanguinose". La scrittura, inoltre, è stata terapeutica e lo ha aiutato a "ridiventare uomo, uno come tutti". Oggi sappiamo che questa in realtà non era che una vana speranza, poiché i fantasmi di Auschwitz lo perseguiteranno per tutto il resto della sua vita.
Come citi nel tuo libro, Levi dice: "Scrivo poesie senza crederci troppo". La poesia era per lui una dimensione più personale e spontanea in cui era permesso sbagliare, o in qualche modo non riusciva a credere che fosse un mezzo adeguato per comunicare?
Levi è stato, soprattutto e prima ancora che scrittore, un chimico. La sua parte razionale cede tuttavia di fronte a un istinto primordiale, una "spinta" inspiegabile e profondamente umana verso la poesia. Lui stesso ammette di non intendersene troppo, di non leggerla, ritiene di non saperla nemmeno scrivere. La poesia è per Levi una sorta di "sfogatoio" dove potersi esprimere molto più liberamente che nella prosa.
Nel tuo saggio parli della "poesia del ricordo", in cui riaffiorano ricordi di compagni e partigiani. Lui stesso scrive: "La nostra guerra non è mai finita". Cosa vuole intendere Levi con questa frase?
Questa frase è tratta dalla poesia Partigia, quindi non un ricordo del lager ma del periodo precedente nella Resistenza. Credo che, con quel verso, Levi intenda che la guerra lascia tracce indelebili nell'animo di chi l'ha vissuta, fa vedere chiunque come nemico e stare sul chi va là. Se teniamo in considerazione che la poesia è stata scritta nel 1981, potremmo anche azzardarci a ipotizzare che si tratti di un'occhiata sul mondo attuale, dove siamo purtroppo ancora ben lontani da un ideale di uguaglianza e fratellanza – e dove purtroppo l'antisemitismo è fenomeno ancora diffuso.
Fondamentale per capire l'autore e l'uomo è un altro capitolo della sua poesia, "la poesia del rancore". Colpiscono molto le parole che Levi rivolge ad Adolf Eichmann: "non ti auguriamo la morte/(...) Possa tu vivere insonne cinque milioni di notti". Cosa puoi raccontarci dell'autore visto secondo questa prospettiva?
Levi, nella prosa, è sempre molto pacato ed evita esplicitamente il giudizio. Nella poesia, si può notare talvolta un atteggiamento opposto: come se Levi, tra i versi, si sentisse più libero di tirare fuori rabbia, rancore, giudizi sprezzanti e intransigenti. Levi nelle poesie augura il male agli aguzzini, ai profittatori di guerra, a coloro che sapevano e non hanno agito. C'è un'altra poesia che mi è molto cara, che pure si inserisce in quella che nel mio saggio ho definito "poesia del rancore": A giudizio racconta la storia di Alex Zink, imprenditore di Norimberga che comprava capelli di donna dai lager per farne tappeti; nella poesia Zink è davanti a dio, che lo manda all'inferno.
La poesia più celebre di Primo Levi, Shemà, richiama la preghiera fondamentale della liturgia ebraica ed è quindi strettamente collegata alla religione, eppure non ha dei toni pacati, al contrario. Si fondono religione, rabbia, rancore, follia e molto altro. Cosa capiamo di Levi in questa poesia?
Come dicevamo, Levi nella poesia tira fuori tutti i suoi sentimenti e il suo lato più irrazionale, se così vogliamo chiamarlo. Non dobbiamo però dimenticare che Shemà sta in epigrafe a Se questo è un uomo, anticipando, sintetizzando e rinforzando il significato dell'intero libro. Levi chiede al lettore, ancora prima di iniziare a leggere il suo racconto, di fermarsi ad "ascoltare" ("Shemà" significa proprio "ascolta"): il lettore deve "considerare", deve "meditare" e deve allenare quotidianamente la memoria di ciò che è stato, pena tutta una serie di punizioni bibliche che chiudono il componimento. Levi è iroso e inflessibile. Chi non coltiva e non tramanda la memoria (un concetto, questo, pure derivante dall'ebraismo) merita il peggio del peggio, merita che gli venga tolto o distrutto tutto ciò che una persona ha di più caro: la casa, la salute, i figli.
Elisa, adesso una domanda su di te. Quali sono i prossimi progetti che hai in mente?
Vorrei tornare alla narrativa e cimentarmi con l'autofiction, raccontando la mia storia di emigrazione proprio in questo 2022 in cui prenderò la cittadinanza tedesca. E ho in mente un altro saggio, questa volta di letteratura comparata, sul mito della buona madre: è un tema che mi riguarda da vicino e che mi appassiona moltissimo, anche dal punto di vista letterario.
In questa giornata, ai lettori noi consigliamo il tuo libro! Tu invece cosa ti senti di consigliare per una lettura della memoria?
Andiamo per fasce d'età: per bambini della scuola elementare suggerisco L'albero di Anne di Irène Cohen-Janca e Maurizio A.C. Quarello (orecchio acerbo), per i più grandicelli la graphic novel Primo Levi di Matteo Mastragostino e Alessandro Ranghiasci (Becco Giallo), per gli adulti senza ombra di dubbio Edipo a Berlino di Francesca Veltri (divergenze).
(articolo a cura di Vanessa Del Chiaro Tascon)
Se vuoi collaborare con la Rubrica Letteraria de Il Club del Libro, segnalarci iniziative interessanti o semplicemente comunicare con noi, scrivici a:
![]()






