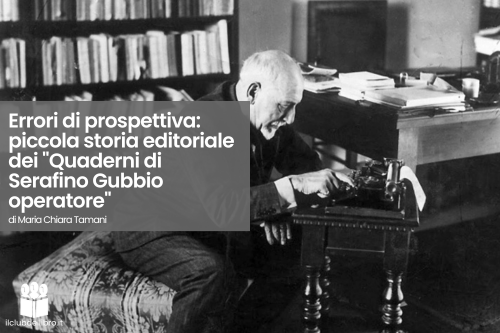
Essere un maestro della letteratura italiana, a quanto pare, non mette al riparo dai rifiuti editoriali. Certo, il settore trabocca di aneddoti di rifiuti celebri: questo è uno di loro, e tira in causa un particolarmente sfortunato Luigi Pirandello. La storia non è molto nota, anche perché riguarda una delle sue opere minori, i Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Libro del Mese di Luglio 2023 del Club del Libro.
In questa occasione, grazie a un'edizione particolarmente curata e ricca di appendici, abbiamo scoperto il "dietro le quinte" della pubblicazione del romanzo. È una storia di cent'anni fa, ma rivela molto delle dinamiche editoriali di ieri e di oggi.
La storia, in due parole, è questa: nel gennaio del 1913 Pirandello, già in contatto con la redazione del Corriere della Sera per la pubblicazione delle sue novelle, si fa avanti e propone qualcosa di più corposo. È da diversi anni, infatti (già da dopo la conclusione de Il fu Mattia Pascal), che lo scrittore ha in testa un nuovo romanzo. Pirandello vi si riferisce come Filauri prima, poi La tigre, poi Si gira, ma la sostanza è sempre la stessa: dieci capitoli circa ambientati nella nascente industria del cinema, che alternano le riflessioni di un narratore interno sul rapporto tra l'arte e la macchina (Serafino è impiegato nel comparto tecnico come, appunto, operatore) e vicende umane a tratti comiche, a tratti strazianti.
Gli ingredienti ci sono tutti: c'è l'ambientazione cinematografica, accattivante; c'è il triangolo amoroso tra la diva del set, il compagno altrettanto divo e un vecchio amante rifiutato; c'è l'ombra di un suicidio antico e di una famiglia caduta in disgrazia; e c'è l'intermezzo comico, da riso triste, della disfunzionale famiglia che affitta l'alloggio al protagonista-narratore. Quando Pirandello propone questa trama ad Alberto Albertini, caporedattore del Corriere, la reazione è positiva: il romanzo potrebbe essere un buon candidato per la pubblicazione a puntate su La lettura, l'inserto mensile che in quel periodo stava dando spazio proprio a romanzi italiani contemporanei.
Va sottolineato un particolare sin qui solo accennato, ma di fondamentale importanza: è Pirandello stesso ad individuare la collocazione editoriale del proprio romanzo e a proporlo. L'Albertini dal canto suo gli dà un "sì con riserva", nel senso che dà per scontata la qualità del prodotto finale, ma esorta lo scrittore a non dare la cosa per certa; gli dice intanto di scrivere e vedere come viene: è solo leggendo le prime bozze che la redazione capirà se il romanzo fa al caso loro. Più fiducioso il recensore d'arte Renato Simoni, anch'egli collaboratore del Corriere, che esorta il maestro a scrivere e mandare presto il suo manoscritto: ha già pronto uno slot per lui a dicembre.
Tutta questa vicenda si può ricostruire a partire dal carteggio tra Pirandello, Albertini, Simoni e Ugo Ojetti, a sua volta redattore del Corriere e amico di Pirandello, che fece un po' da mediatore durante la conclusione della vicenda. Il romanzo, infatti, alla fine fu rifiutato.
La motivazione è piuttosto semplice: l'ultima fatica di Pirandello, per quanto di altissima qualità (Albertini è molto chiaro in proposito) non soddisfa i requisiti di cui è alla ricerca la redazione del Corriere: troppo filosofico, l'azione tarda ad arrivare e questo rende il romanzo inadatto alla pubblicazione a puntate.
"Noi non possiamo giudicare i manoscritti che ci giungono secondo un criterio puramente letterario; dobbiamo tenere conto anche del criterio editoriale, diciamo così, e giornalistico", scrive Albertini a Ojetti nell'aprile del 1914, nel tentativo di chiarire l'equivoco con Pirandello. E aggiunge: "[...] noi non possiamo snaturare il carattere della nostra rivista e farla quello che non è e non vuole essere. Tu sai che fino a un anno e mezzo fa la Lettura non pubblicava che romanzi stranieri tradotti. Ci sedusse l'idea di avere qualche cosa di italiano e di più nobile, ma occorrono sempre lavori aventi quei requisiti che avevo indicato al Pirandello sin dal principio. La trama che egli mandò pareva prometterlo, ma all'attuazione l'opera d'arte gli si è modificata, nel senso non di diminuirne il valore, ma di ritardare l'azione. Ti basti dire questo: che la parte mandata sinora, corrispondente se non erro a cinque o sei puntate ossia a cinque o sei mesi della Lettura, non giunge ancora, con l'azione, a quella che era la trama proposta."
La risposta di Pirandello fu cortese ma amareggiata, anche perché contava economicamente su questa pubblicazione. E all'amico Ojetti parla di "errori di prospettiva": per Albertini l'errore è stato di Pirandello, perché ha rispettato i suoi standard editoriali. Per Pirandello invece è di Albertini, perché crede il pubblico troppo stupido.
Chi ha ragione, chi ha torto? Nessuno dei due. Però la riflessione di Pirandello è importante: avvicinare il pubblico alla lettura, oggi come nel 1914, richiede qualche compromesso. Ma non sarà che stiamo abbassando un po' troppo l'asticella?
(articolo a cura di Maria Chiara Tamani)
Fonte: Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, a cura di S. Costa, Milano, Fabbri Editori, 2004. Il carteggio in appendice è ripreso da Carteggi inediti con Ojetti-Albertini-Orvieto-Novaro-De Gubernatis-Da Filippo, a cura di S. Zappulla Muscarà, Bulzoni, Roma 1980. Viene consigliata anche la lettura di G. Cappello, Quando Pirandello cambia titolo: occasionalità o strategia?, Mursia, Milano 1986.
Se vuoi collaborare con la Rubrica Letteraria del Club del Libro, segnalarci iniziative interessanti o semplicemente comunicare con noi, scrivici a:
![]()






