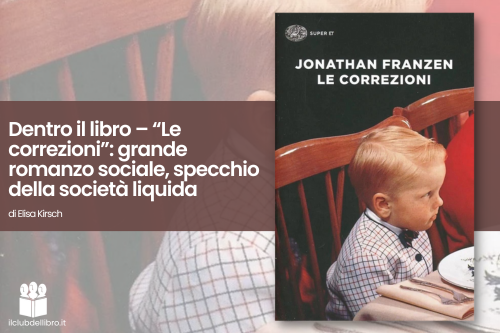
Il Libro del Mese di Settembre 2023, Le correzioni di Jonathan Franzen ha vinto il National Book Award ed è stato letto, negli oltre vent'anni trascorsi dalla sua pubblicazione, da milioni di lettori in tutto il mondo. Ma cosa si è proposto l'autore durante la sua scrittura? E che cosa rende questo romanzo particolarmente interessante addirittura dal punto di vista sociologico?
L'autore stesso, in un saggio sulla rivista Harper's, descrive la sua letteratura come un tentativo di recuperare il valore del realismo sociale. La traduttrice di Franzen, Silvia Pareschi, parte da questa affermazione dell'autore in un suo intervento (nel 2016, organizzato dal Laboratorio Sogno o son testo nell'ambito del Salone Off a Torino) per descrivere a sua volta quale sia la particolarità di questo recupero in Franzen, un recupero che a prima vista e nelle intenzioni sembra legarlo a "mostri sacri della letteratura" come Charles Dickens, Honoré de Balzac e il nostrano Giovanni Verga: "La particolarità di questo recupero sta nel suo prendere le mosse dai personaggi: è come se Franzen lavorasse a forza centrifuga concentrandosi sulla loro creazione". Prosegue, poi, affermando: "Franzen usa il romanzo europeo per ricostruire il romanzo realista, rimetterlo in piedi dalle macerie del postmoderno".
Il romanzo realistico-sociale, nato nella prima metà del XIX secolo, intende fornire un quadro fedele e oggettivo della società contemporanea all'autore, evidenziandone – e denunciandone – le criticità, le ingiustizie, i mali che la affliggono. Un obiettivo altissimo, dunque, che ripropone in un mondo tutto nuovo tematiche e motivi dei grandi romanzi europei dell'Ottocento.
In Le correzioni troviamo la tipica famiglia della classe media del Midwest americano: padre, madre e tre figli. Il padre è affetto dal morbo di Parkinson (elemento parzialmente autobiografico, poiché il padre di Franzen ha sofferto di Alzheimer, come raccontato in un saggio di una trentina di pagine dal titolo Il cervello di mio padre, pure tradotto da Silvia Pareschi, 2013, Einaudi), i tre figli sono adulti e vivono ormai felicemente lontani dalle “correzioni” materne. La madre desidera tuttavia riunire per un ultimo Natale tutta la famiglia e questo porterà a far crollare rovinosamente i delicati equilibri e le apparenze.
La famiglia diventa punto di osservazione del mondo e, così, la famiglia Lambert è specchio di un'intera società: una società (postmoderna) che è stata definita dal sociologo polacco Zygmunt Bauman come "società liquida", caratterizzata da disgregazione, incertezza, disagio. Questa espressione, diventata ormai quasi di uso comune, riassume un articolato metodo di analisi della realtà che aiuta, da un lato, nella comprensione di fenomeni sociali e, dall'altro, nello studio dell'effetto che questi fenomeni sociali hanno sulla psiche individuale. Un saggio pubblicato quest'anno, La società liquida. Che cos’è e perché ci cambia la vita (2023, Il Sole 24 Ore) di Thomas Leoncini aiuta ad approfondire la questione.
Dalla sociologia alla letteratura il passo è breve. D'altronde, anche di questa relazione complementare ha scritto Bauman, insieme a Riccardo Mazzeo, in Elogio della letteratura (2017, Einaudi) – che, a chiudere il cerchio, tra gli autori presi ad esempio presenta anche lui, Franzen.
(articolo a cura di Elisa Kirsch)
Fonti: Tutte le difficoltà e il piacere di tradurre Jonathan Franzen
Se vuoi collaborare con la Rubrica Letteraria del Club del Libro, segnalarci iniziative interessanti o semplicemente comunicare con noi, scrivici a:
![]()






