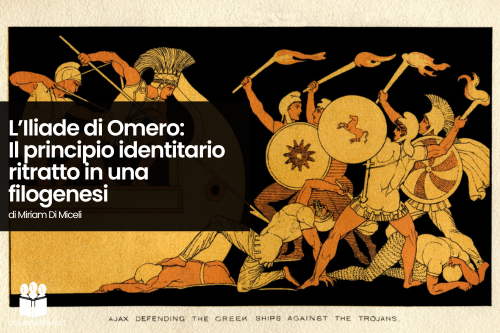
Una domanda antica e sempre bellissima chiede: "Chi sei tu?"
La risposta, secoli fa, per gli umani era racchiusa nei costituenti identitari dati dalla preposizione "di" e dalla preposizione "da". Così gli uomini si presentavano ai tempi di questo poema, poiché l'essere umano, in quanto tale, si riconosceva come appartenente ad una terra, proveniente da un luogo e legato ad una stirpe, facente parte, quindi, di una famiglia, di cui portava con sé la storia.
Il mondo greco è da trattare in termini di filogenesi.
La collettività muove senso alla vita degli uomini, in quanto partecipi di una stessa terra che li genera e li accoglie.
Questa collettività non ha leggi, come noi le intendiamo oggi, ma struttura se stessa nei valori che l'uomo ha stabilito dalla propria intensità sentimentale/emozionale, dalla profonda religiosità che è parte integrante della vita stessa e dalla tradizione che si tramanda da uomo a uomo, come trapasso considerato sacro.
Ha ragione lo studioso Giambattista Vico quando sostiene che i poemi omerici non sono affatto poemi sapienziali, in quanto intrisi e governati da assoluta passionalità, è il sentimento stesso a regolare la vita dell'uomo. Le emozioni che muovono il poema sono purissime e proprio perché tali contengono dentro di sé tutto il loro trasporto, il loro movimento erratico, fino al compimento di un destino che spesso coincide con la morte.
Perché si scatena la guerra di Troia? Non di certo per Elena; non è insomma per un fatto intimo, casalingo e coniugale tra marito e moglie, Menelao ed Elena, che prende piede una delle più famose guerre conosciute al mondo. La guerra di Troia si scatena per il rapimento di Elena ed è qui che sta il nodo cruciale a cui l'uomo di questo mondo è legato. Il rapimento, nella sua categoria semantica, indica una sottrazione, una privazione, una mancanza, un venir meno e, come si vedrà, una violazione.
Paride, ospite in casa di Menelao, dopo aver ricevuto tutti gli onori e i doni concessi allo straniero, secondo la cosiddetta "xenìa", ossia una delle più sacre tradizioni adempiute da colui che ospita nei riguardi di colui che viene ospitato, oserà violarla, calpestarla, infrangerla e da questo momento in avanti, il principe Troiano e, consequenzialmente tutta quanta Ilio ventosa, si macchierà di una colpa.
Paride commette una violazione irreparabile, ha rotto i legami di un'intimità, di un patto, di un'alleanza, di una fiducia tra un uomo e un altro uomo, riconosciuta da tutti, e che smuoverà non solo l'esercito acheo, ma gran parte di regioni e di città della Grecia con esso alleate. La violazione di una tradizione, ancor di più se viene fatta a un capo, non è solo un disonore, ma è una perdita identitaria dell'uomo che abita un mondo in cui è l'uomo stesso che cerca di stabilire delle regole in assenza di un corpus di leggi che tutelino i suoi diritti. Le uniche leggi che esistono sono quelle divine che l'uomo antico rispetta nelle forme di rituali con promesse, cure e totale devozione.
Il sesto libro dell'Iliade, ribadisce l'importanza dell'ospitalità nell'episodio di Diomede e Glauco, due fortissimi combattenti e nemici sul campo di battaglia, che durante l'apice di una giornata insanguinata e feroce, riconosceranno l'ospitalità avvenuta, tempo addietro, tra le proprie famiglie e proprio per la sacra regola smetteranno di combattere, si daranno la mano e rinnoveranno il patto di fede, poiché gli ospiti, come dice Diomede stesso, diventano "ospiti ereditari", tutta la stirpe a venire dovrà onorare e portare avanti tutte le azione di quella precedente, nulla deve essere dimenticato.
Perché si scatena l'ira rovinosa di Achille? Si badi bene alle primissime parole del proemio. L'ira di Achille viene seminata e inflitta non sui Troiani, ma sugli Achei, sui suoi alleati, sui suoi compagni con cui ha vissuto per nove anni in terra straniera, lontano dalla sua patria. E perché? Anche qui il movente è una sottrazione, una violazione alla regola, una mancanza.
Agamennone, capo degli Achei, poiché ha dovuto concedere Criseide al padre, per placare l'ira inarrestabile di Apollo, è rimasto senza merito e pretende immediatamente che gli Achei gli diano un dono, uno di quelli che precedentemente tutti avevano spartito equamente. Consegnare ad Agamennone un dono, significa così restare privi della propria riconoscenza, del proprio guadagno ottenuto dalla lotta, del proprio bottino di guerra.
Briseide rappresenta per Achille simbolo, testimonianza concreta e premio che l'eroe ha ottenuto mediante la riconoscenza da parte di tutti per le nobilissime fatiche affrontate, per la sua intrepida forza, per il suo smisurato coraggio di combattere ogni giorno faccia a faccia con la morte. L'ira di Achille non è superbia, l'ira di Achille è rivoluzionaria e democratica e rivoluzionaria proprio perché democratica, in un tempo in cui la democrazia non era ancora lontanamente pensata. Achille esige il giusto, chiede solo ciò che ha meritato e che ha diviso con tutto l'esercito acheo, non ammette alcun sopruso. Achille è un uomo sincero fin dal proemio, e così sarà fino alla fine di quest'opera.
Achille obbedisce alle leggi divine ma non alla supponenza degli uomini, è un uomo indomabile solo nell'ingiustizia.
Noi siamo obbligati ad entrare nella mente di questi uomini, nel respiro di questo mondo, se vogliamo capire fino in fondo di cosa si sta parlando. Dietro il dono risiede la gloria dell'eroe, quel possesso diventa importante perché solidifica e accerta la costruzione e la crescita dell'uomo valoroso che, nei tempi in cui vive, essendo parte di una viva collettività, non può di certo imparare a bastarsi, per cui il dono diventa necessariamente gli occhi di quella collettività che poggiano su di lui.
L'essere visti è un tratto peculiare nel poema e in tutta l'antichità, per questo motivo Agamennone, il quale capo e in quanto tale, non può rimanere senza un dono, ragion per cui la sua superbia viene giustificata, spiegata e trova sede nella paura di essere gettati nell'oblio, nel terrore di non essere più visti e, di conseguenza, perdere non solo ciò che si ha, ma anche ciò che si è. Più volte, infatti, Achille dirà di essere stato trattato come un "senza patria", ecco così che ritorniamo al punto incipitario di cui ho parlato prima.
Le passioni degli uomini e delle donne di questo poema si sciolgono nel corpo, la manifestazione emotiva si dichiara e coincide nelle membra, non può essere sopportata nel suo mero significato etimologico, ma si apre ed esplode in una fisicità che annebbia la mente.
Esiste certamente saggezza in questa storia, ma la si trova collocata nella "gherusìa", l'assemblea degli anziani, proprio perché è da attribuire alla figura dell'uomo canuto il saggio consiglio. Solo colui che ha già visto e vissuto la furia emotiva, la passionalità rovente, il delirio, l'essere febbricitante, la mania, la cupidigia, conosce e, quindi, può dire parola vera, sviluppando conoscenza profonda tramite sguardo lungimirante, capace di mettere in bocca un pensiero complesso che travalica i confini dell'attimo e si volge anche al domani.
La ricerca di una parola pensata, di un saggio consiglio è costante nell'opera. Il mondo omerico è un mondo dove si chiede aiuto perché, come dice il poema stesso, "sanno cedere i cuori dei forti".
Leggere l’Iliade significa cercare radici, ammettere e, soprattutto, legittimare la paura.
Tutti gli eroi tornano indietro, tutti gli eroi scappano, tutti gli eroi sono feriti, tutti gli eroi sbagliano.
È possibile sbagliare, lo sbaglio è scritto nel destino di ogni uomo. Ate, la dea funesta che tutti fa errare, cacciata dall'Olimpo da Zeus Cronide, ha piedi molli e non si muove sulla terra, bensì tra le teste degli uomini, è lì che cammina, danneggiando il senno, per cui sbagliare non è solo umano, ma si presente come prerogativa inalienabile dell'uomo.
Lo sbaglio e il pentimento fanno parte del mondo greco che li vive dentro l'incubo meraviglioso del tragico.
L'antichità ci insegna che nessuna scelta è per sempre.
Il personaggio di Elena è l'esempio di una donna che porta con sé una pena terribile, una scelta sbagliata, un sciagura tremenda e il suo errore fatale sarà la causa di una terra che ogni giorno si colorerà del sangue morto di tutti i più valorosi eroi, che perderanno la vita lontano dalla loro patria. Elena è un personaggio che si pente, si odia, definisce se stessa "cagna", ed è distrutta dal suo errore, vuole tornare indietro, sente la nostalgia di casa, la nostalgia della figlia e di un marito forte e possente che, al contrario, non ha ritrovato in Paride, l'amante con cui è scappata, uomo vigliacco e disonorevole agli occhi di tutti.
Qui si apre un altro sentimento feroce e rancoroso tra due grandi personaggi, i due fratelli Troiani, Ettore e Paride. Tra le viscere di Ettore si annida un amarissimo rancore nei confronti del fratello, un astio incontenibile, trasmesso più volte in ferocissimi dialoghi. Ettore, in fin dei conti, è molto simile ad Achille, anche su di lui grava una responsabilità grandissima e anche lui vive una solitudine angosciosa; il fratello è solo un vile, non è una spalla, non è un compagno, è rovina. La profonda amarezza che Ettore sente e dichiara nei confronti del fratello, non riguarda la cedevolezza alla passione di Paride, non potrebbe essere così, anche Ettore sa che la passione è una forza divina, in quanto infusa dagli dèi, è l'invasione di un dio dentro l'animo dell'uomo e l'uomo non può fare altro che lasciarsi trascinare verso di essa. L'uomo non può far nulla contro le contese divine che si riversano su di lui. Non è l'arrendevolezza all'amore, dunque, che spinge Ettore ad odiare il fratello, piuttosto la mancanza di responsabilità per il gesto compiuto. Mentre gli Achei lottano insieme per l'oltraggio subito di una sacra regola, i Troiani lottano per l'irresponsabilità di un uomo incapace di portare con coraggio e responsabilmente una sua scelta fino alla fine. Non si è uomini se non si è in grado di amare davvero qualcosa. Non si è uomini se non si è in grado di proteggere quell'amore, di averne cura, di portarlo fino in fondo, sia che esso innalzi alla felicità, sia che porti alla sventura. Per amore, o per meglio dire, per aver scelto di avere il coraggio di amare o si vive o si muore, è un aut-aut su cui il mondo antico ha fissato tutta la sublimazione del tragico.
L'errore di uno, diventa la colpa di tutti all'interno di un sistema collettivo.
Ettore porta il peso di questa collettività, nonostante il focolare intimo, la sua dimensione domestica lo richiami a sé, con le commoventi parole della moglie Andromaca, innamorata del marito, e che ben conosce la gloria di Achille in battaglia, poiché proprio lui ha ucciso tutta la sua famiglia. Andromaca prega Ettore, con calde lacrime, di non combattere, ma il principe Troiano non può sottrarsi. Andromaca, forse la donna più fragile di tutto il poema, ha trasferito in Ettore una stabilità totalizzante che le fa da padre, da madre, da fratello e sarà ancora una volta la mano rovinosa di Achille a darle tremendo dolore e portarle via l’ultimo mondo su cui aveva riposto fragilmente l'amore e la speranza.
Achille viene spesso presentato come feroce, come l'eroe violento, istintivo, iracondo, ma Achille, nel poema stesso, non è mai solo Achille, è la pluralità di voci che ne parla.
Dopo la diatriba con Agamennone, Achille si esclude dal sistema collettivo e si impossessa della sua individualità, si avvolge nella solitudine del singolo, siede spesso sulla spiaggia, fissa il mare e riflette, è un uomo pensante che si rende conto della finitezza e della miseria degli uomini. In lui si rianima il desiderio di tornare a casa e vivere a lungo, ed è l'unico che riconosce la preziosità della vita perché sente il significato profondo dell'unica e irripetibile vita che gli è concessa di vivere. Si rende portatore di questo messaggio, invitando anche i suoi compagni a partire con lui, non sente alcuna vergogna nell'allontanarsi dalla battaglia, capisce il dono della vita e capisce di esserne amante. Perché allora ritorna a combattere l'eroe? La prima motivazione indiscussa è sicuramente da cercare sempre nel destino. Il concetto di pre-destinazione e la presenza di una divinità, come entità e principio primordiale e mobile delle azioni dell'uomo, è una categoria inscindibile nel mondo greco antico. Consequenzialmente quindi a questo fatto, che erge in prima posizione su una scala gerarchica, discende poi il sentimento degli uomini. Achille, quasi paradossalmente, ritorna a combattere proprio perché rimane fedele fino alla fine al concetto di vita che ha elaborato. Scende in battaglia per una vita persa, quella del suo caro amico, compagno e amante Patroclo, ucciso in battaglia da Ettore.
Nell'ultimo respiro di Patroclo, la potenza narrativa descrive in maniera sublime il crollo psicologico di Achille. La reazione per la morte dell'amico è una delle più commoventi pagine di letteratura che abbia mai letto.
L'eroe trema di fronte a un così forte dolore, piange a terra disperato, si strappa i capelli, il suo delirio è tale che Antiloco, il compagno che gli porta il triste messaggio, gli terrà strette le mani furenti per paura che si possa tagliare la gola.
Qui la vendetta, dunque, è un fatto individuale e trascendentalmente comune a tutti gli uomini. Achille si vendica per onorare la vita del caro amico, dopo aver capito l'importanza della vita stessa. La vendetta assume quindi i connotati dell'onorificenza, non della gloria.
La capacità emozionale di Achille, ancora oggi, rimbomba e porta l'eco grandioso di un venerabile pianto dell'uomo, lo dice Zeus stesso: "No, non c'è nulla più degno del pianto dell'uomo fra tutto ciò che respira e cammina sopra la terra".
Queste sono solo brevi considerazioni di un poema che racconta e dice molto di più.
Come ci si pone nei confronti di un'opera eterna?
In ascolto. È un'opera che va letta ad alta voce, dall'inizio alla fine, sia per onorare la sua tradizione orale, sia per la potenza musicale della parola che si scioglie e si rivela in immagini magnifiche e eterne, in cui il passato viene ri-conosciuto dal suo lettore come una parte invisibile che ha preso dimora e abita dentro di lui e che, in fin dei conti, mai è passato.
Il mondo antico è un bellissimo materiale grezzo ed essenziale che rivela, senza necessità di scavare, l'immenso e sconfinato sentimento dell'uomo, un sentimento bambino, puro, ma non per questo immaturo, inabissato nei precordi nascosti, pulsanti e vitali.
Una delle critiche mosse nell'Ottocento dai letterati italiani nei confronti dell'epica classica, quando la disputa tra antico e moderno era ancora in auge, era proprio quella di condannare l'antichità per aver scelto come paradigma la passionalità dell'uomo, la tempesta delle forti emozioni che lo divorano, la personificazione della passione stessa, che sembra soccombere sull'essere umano, ebbene forse oggi, invece, si dovrebbe fare una rivoluzione con l'involuzione e ritornare indietro, perché è certamente vero che il passato non va mai attualizzato, ma è anche innegabilmente assoluto che il passato educa.
(articolo a cura di Miriam Di Miceli)
Se vuoi collaborare con la Rubrica Letteraria del Club del Libro, segnalarci iniziative interessanti o semplicemente comunicare con noi, scrivici a:
![]()






