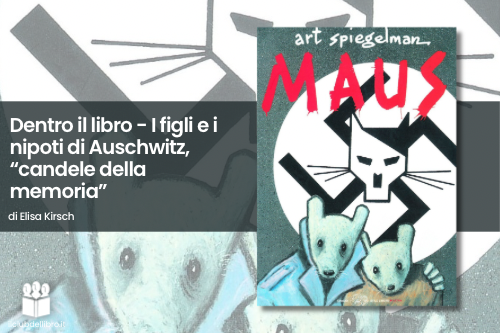
In Maus, nostro Libro del Mese di Luglio 2024, Art Spiegelman ripercorre la propria storia familiare, da una piccola cittadina polacca ad Auschwitz agli Stati Uniti. Un fumetto sulla Shoah che non si limita a raccontare ciò che è accaduto durante quegli anni, ma mette in luce soprattutto il dopo: cosa significa, nella quotidianità, essere un sopravvissuto? E quanto di questo peso viene posto sulle spalle della generazione successiva?
Art Spiegelman descriveva queste dinamiche tra la fine degli Anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. È proprio negli Anni Novanta che la saggista e traduttrice parigina di origine armena Janine Altounian inizia a indagare, sotto una prospettiva psicoanalitica e riallacciandosi a teorie freudiane, la trasmissione transgenerazionale del trauma.
In Italia il nome di spicco per quanto riguarda gli studi sugli effetti generazionali del genocidio è quello di Alberto Sonnino, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana e dirigente medico. In un suo intervento al Palazzo del Quirinale in occasione della Giornata della Memoria 2020, Sonnino ha ben riassunto alcuni pilastri essenziali delle sue riflessioni e dei suoi percorsi di indagine sul tema, che sono stati poi raccolti nel volume Trauma della Shoah, ebraismo e psicoanalisi (Franco Angeli, 2022).
La Shoah è a tutti gli effetti un "trauma collettivo", che ha lasciato tracce sulle vittime, sui carnefici e sui Mitläufer (coloro che "hanno seguito passivamente la corrente"), ma "soprattutto sui loro discendenti".
Moltissimi sopravvissuti hanno inizialmente taciuto sulle loro esperienze (con notevoli eccezioni, come Primo Levi, che inizia la stesura di Se questo è un uomo appena tornato da Auschwitz): da un lato perché impossibile da esprimere in tutto il suo dolore, dall'altra perché gli interlocutori non sembravano "pronti per ascoltare". Yael Danieli, psichiatra e dirigente del Group Project for Holocaust Survivors and their children di New York, ha coniato a questo riguardo l'espressione "cospirazione del silenzio".
Il trauma, tuttavia, per venire elaborato deve essere espresso, raccontato – altrimenti viene trasmesso da una generazione all'altra, provocando disturbi psichici e psicosomatici. E viene trasmesso attraverso il linguaggio emotivo, con conseguenze ancora più devastanti. Lo conferma anche uno studio di Danieli: "nelle famiglie in cui non si è parlato gli effetti dei traumi saranno assolutamente peggiori di quelle in cui si è parlato".
Il superamento del trauma, tuttavia, non riguarda il singolo individuo, ma coinvolge l'intera società nel riconoscimento collettivo dell'esperienza patita: una memoria condivisa e appartenente a tutti, che attraverso la commemorazione unisce individuo e società. Se la società si sottrae a questo compito e fa sentire il sopravvissuto solo con il suo dolore, il trauma sarà ancora più profondo, sulle vittime ma anche sui loro figli e nipoti – definiti "candele della memoria" da Dina Wardi, studiosa della psicopatologia della seconda generazione.
Se da un lato le "candele della memoria" non hanno potuto far altro che soccombere al trauma, dall'altro è stata proprio la loro venuta al mondo a dimostrare a molti sopravvissuti che "la vita può trionfare sulla distruttività" e permettere loro di "ritrovare quella fiducia necessaria ad infrangere la cospirazione del silenzio". Sonnino conclude citando Yerushalmi: "Ma la memoria del passato è incompleta senza il suo naturale complemento: la speranza riguardo al futuro".
I genitori Spiegelman non sono andati in questa direzione, essendosi la madre suicidata e il padre rinchiuso nel suo dolore, eppure Art Spiegelman è davvero una "candela della memoria": ha raccontato la Shoah e la sua storia familiare nel suo personalissimo modo, che gli ha consentito di farla davvero sua, di elaborarla e soprattutto di onorarla.
Fonti:
Alberto Sonnino, Giornata della Memoria 2020: https://www.spiweb.it/cultura-e-societa/giornata-della-memoria-27-1-2020-testo-di-sonnino/
Yael Danieli, "La cospirazione del silenzio", UNA CITTÀ n. 83 / Febbraio 2000: https://www.alexanderlanger.org/it/386/1834
(articolo a cura di Elisa Kirsch)
Se vuoi collaborare con la Rubrica Letteraria del Club del Libro, segnalarci iniziative interessanti o semplicemente comunicare con noi, scrivici a:
![]()






