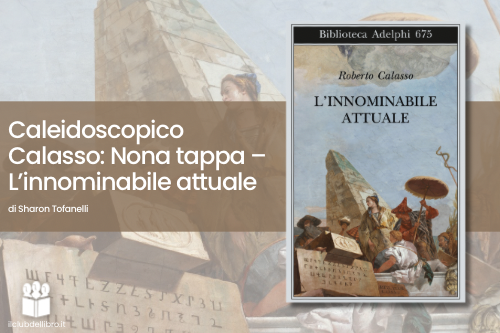
"La sensazione più precisa e più acuta, per chi vive in questo momento, è di non sapere dove ogni giorno sta mettendo i piedi. Il terreno è friabile, le linee si sdoppiano, i tessuti si sfilacciano, le prospettive oscillano. Allora si avverte con maggiore evidenza che ci si trova nell'«innominabile attuale»." (R. Calasso, L'innominabile attuale, Adelphi, 2017, p. 13).
E d'improvviso eccolo che arriva, che si fa spazio tra i Veda e i pensatori illuministi, tra gli scritti di Kafka e le gamme coloristiche del Tiepolo, eccolo qua, e chi se lo sarebbe immaginato ormai? Il presente, noi, oggi, qui.
Il nono volume de "l'Opera senza nome" compare in libreria nel 2017. Sull'edizione più costosa trionfa l'Allegoria dell'Asia nella Residenza di Würzburg, altro affresco del pittore veneto. Di fronte alla principessa orientale, una stele fitta di caratteri che non è possibile interpretare. La non interpretabilità, pare, è un po' la principale caratteristica del tempo che abitiamo. Giorgio Agamben, d'altronde, definisce il contemporaneo come colui che riesce a distanziarsi dal proprio tempo quel tanto che basta affinché possa coglierne le ombre. L'edizione tascabile, non meno interessante, presenta in copertina un disegno di Leon Battista Alberti: su un fondo carta da zucchero un occhio alato fende lo spazio con propaggini da organismo di mare, catturando lo sguardo di chi passa con la sua perfetta improbabilità. Versioni da edicola della pubblicazione sfoggiano la Torre di Babele di Bruegel il Vecchio. Volti differenti per questo "innominabile attuale".
Nessuna mitologia in questo volumetto che si può leggere in due giorni, ma che impegna tanto quanto gli altri: qui troneggia la cronaca, la narrazione minima, senza perdere quel taglio ambiguo che si posiziona tra saggistica e narrativa. Turisti e terroristi, primo capitolo, è un po' il messo che anticipa il cuore del libro: tutto focalizzato sul presente che abitiamo, riafferra le redini di quanto già detto altrove – è come se il Direttore di Adelphi volesse riformulare a oltranza certi concetti, un po' per fissarli entro di sé, un po' per verificarne negli anni il cambiamento, come certi collezionisti che infilzano organismi nei vari stadi di sviluppo. Perno di questa prima parte è il terrorismo islamico da un lato, "rovesciamento preciso delle dottrine vediche" (p.23) raccontate in Ka e ne L'ardore. Se nel mondo antico la perfezione della vittima e la sua scelta accurata compiacevano il divino, l'estremista infagottato di esplosivi punta sul numero degli immolati e li sacrifica proprio in quanto condannabili, ma affidandosi al Caso e non più alla Grazia. Il frutto del rituale odierno è la morte in sé e Calasso vi arriva partendo dalle radici, da quel "Vecchio della Montagna" che nelle narrazioni di Marco Polo incubava assassini da spargere per il mondo, all'impiccato Sayyid Qutb, che avrebbe ispirato al-Zawahiri, Osama bin Laden e Khamenei.
Il secondo protagonista del nostro Occidente è l'Occidente stesso, che ha ucciso il religioso sostituendolo col sociale, nemico contro cui si abbatte la degenerazione del terrorismo. Un'entità che Calasso definisce autistica, poiché presa interamente a riproporre se stessa. Tautologie esemplificate dalla pubblicità:
"Essenziale per la pubblicità, è che si ripeta, così come gli atti rituali. La ripetizione garantisce la costanza del significato. Ed è appunto questo compito che è stato delegato dalla società alla pubblicità." (pp. 60-61)
"Ricordo un varietà televisivo, a cui partecipava una ignota ragazza della profonda provincia italiana […] «Che cosa vorresti essere?» disse la presentatrice. «La pubblicità» rispose la ragazza. La presentatrice non batté ciglio. «E perché?» chiese ancora. «Perché la vedono tutti» rispose la ragazza. Seguì uno scroscio di applausi rituali dall'oscurità del pubblico. Aveva parlato lo Zeitgeist ["spirito del tempo"]." (p.61)
Abita l'"innominabile attuale" l'homo saecularis, senza radici, senza fardelli divini, senza riferimenti esterni alla società che lo permea. Condannato al turismo, "non soltanto quando viaggia […] zapping e link formano una vasta parte della sua vita mentale" (p.62). Il turista è controparte del terrorista nel suo non appartenere e come tale è osservato con "un accenno di riprovazione […] è l'umanità che guarda se stessa e sospetta di aver perduto qualcosa" (p.69), mentre un flusso di dati e intelligenze si moltiplicano e accavallano nel suo orizzonte, operando una censura che, aggiunge Calasso citando Yuval Noah Harari, agisce al contrario rispetto al passato: non più interrompendo l'informazione, ma sommergendola di irrilevanza. "Oggi avere potere significa sapere che cosa ignorare" (p.82), conclude l'autore di Homo Deus per bocca di Calasso, che definisce questa frase "una glossa a un nuovo Machiavelli" (ibidem).
Ma fedelissimo al suo bisogno di narrazione, l'autore giunge al cuore del volume e passa alla cronaca. Il secondo capitolo è un coacervo di voci e diaristiche che percorrono gli anni europei tra il 1933 e il 1945. Qui parrebbe essersi composta la società odierna, che come il progetto nazista uccide sperimentando, che come la dittatura ripropone se stessa a oltranza e tutto pervade. Al turismo di Virginia Woolf, di Céline e Samuel Beckett si intrecciano le osservazioni di Robert Brasillach, scrittore e critico francese, che si perde negli occhi di Hitler, "pieni di un'angoscia insormontabile, di un'ansia inaudita" (p.119) (l'ansia dell'homo saecularis?) e che sarà giustiziato dopo la liberazione di Parigi per collaborazionismo con il Terzo Reich. Dittatori che replicano gesti rituali, inglobando la religione ormai obsoleta e facendone il nucleo della società; e tutto attorno una crudeltà che dilaga senza perdere il metodo, con una grazia sacerdotale. E mentre la battaglia imperversa su Berlino e i beni di prima necessità scarseggiano, Missie Vassiltchikov, principessa russa, racconta soddisfatta del cappellino che ha potuto provare, mentre "tutt'intorno le case bruciavano" e nonostante i "pantalonacci fangosi" (p.156).
Lo abbiamo visto più volte, questo ricorrere al codice della favola, del mito e della cronaca per commentare il presente, come se Calasso mettesse in pratica quanto asserito da Giorgio Agamben:
"È davvero contemporaneo chi non coincide perfettamente col suo tempo né si adegua alle sue pretese ed è perciò, in questo senso, inattuale; ma, proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e afferrare il suo tempo" (G. Agamben, Che cos'è il contemporaneo?, Nottetempo, 2008)
E dunque, consenta il paziente Lettore a chi scrive di affiancare all'"innominabile attuale" colui che riesce a comprendere (e nominare?) il presente proprio in virtù della propria inattualità. Balzi di tempo e spazio che il Direttore di Adelphi compie abbracciando qualcosa che parrebbe impossibile cogliere dall'interno, o fissare frontalmente, come certe divinità che accecano o creature che pietrificano – ancora il divino che ritorna!
La fine? Avvistamento delle Torri, capitoletto di una pagina e mezza. Da La Folie Baudelaire il poeta francese torna di nuovo e nuovamente in veste di sognatore. E su un foglietto senza data custodito nella Biblioteca Jacques Doucet, narra di una torre immensa e pericolante, un labirinto che sta per crollare, "intaccato da una malattia segreta" (p.163), in cui Baudelaire è intrappolato, ma Baudelaire solo?
E Calasso?
"Quando la notizia di questo sogno giunse alle nazioni, tutto corrispondeva, con una sola aggiunta: le torri erano due – e gemelle." (p.164)
(articolo a cura di Sharon Tofanelli)
Bibliografia:
Giorgio Agamben, Che cos'è il contemporaneo?, Nottetempo, 2008, ISBN 9788874521357
Roberto Calasso, L'innominabile attuale, Adelphi, 2017, ISBN 9788845935275
Elena Sbrojavacca, Letteratura assoluta. Le opere e il pensiero di Roberto Calasso, Feltrinelli 2021, ISBN 9788807105555
Se vuoi collaborare con la Rubrica Letteraria del Club del Libro, segnalarci iniziative interessanti o semplicemente comunicare con noi, scrivici a:
![]()






