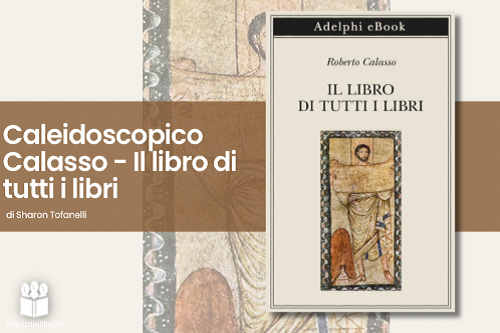
Calasso non riesce a sfuggire a se stesso. Ovunque il suo sguardo si spinga, tra le scritture vediche, nelle nostalgie del Tiepolo o a ridosso del mare ellenico, i lacci che ha tessuto si ripresentano puntuali: immagine, imitazione, sacrificio. E la rete torna a ghermire il mondo.
È il turno di Iahvè. Il libro di tutti i libri (Adelphi 2019), decimo volume de "l'Opera senza nome" è il più massiccio, il più articolato. Le vicende dell'Antico Testamento scorrono nei dodici capitoli, riportando in scena, verificando, sincerando ancora una volta i temi dell'autore: se il mondo che conosciamo sopravvive perpetrando un rito continuo, i libri de "l'Opera" sono il rituale che sempre arde per Calasso e la sua perfetta impalcatura.
Il viaggio è, come sempre, vorticoso – si sposano così bene, questi libri, alla circolarità delle mappe mentali. Pochi termini che pilotano la narrazione: idolo, grazia, elezione, diaspora. E sacrificio, naturalmente. Si parla sempre di sacrificio con Calasso. E tutto ha inizio con Abele, con quel primo sacrificio cruento che Iahvè accetta, rifiutando l'offerta vegetale di Caino. Abele stesso, assassinato dal fratello, incarna un olocausto. E tuttavia, i personaggi più celebrati della Bibbia si caratterizzano per la loro irregolarità. «Mi darai il primo dei tuoi figli», è l'enunciato di Elohim, ma il primogenito è Caino, dunque l'offerta favorita doveva essere lui. E la medesima regola è violata in Isacco, il sacrificato par exellence, «il tuo unico figlio», dice Iahvè ad Abramo, sebbene Ismaele, il primo da lui avuto dalla schiava Hagar, errasse cacciato nel deserto con la madre. L'eletto è quasi sempre infrazione alla regola, prole cadetta, madre tecnicamente sterile: così è per Giacobbe, che si fa vendere la primogenitura da Esaù; e per Giuseppe, l'ultimo di tanti fratelli, prima che nasca Beniamino.
"Tutto il racconto biblico vuole mostrare come giusto ciò che appare inaccettabile e suscita ripetute, tenaci rivolte. L'inaccettabile è innaturale […] e l'elezione, in questo senso, è quanto di più innaturale. Ma senza l'elezione, che è la forma prima della grazia, tutta la Bibbia non avrebbe fondamento." (p.196)
La scelta di Iahvè è imperscrutabile, spesso contraddittoria. "Se Abramo era la grazia non fondata sul merito, Giobbe era la disgrazia non fondata sulla colpa" (p.168). E comporta sempre una separazione. Perché il popolo eletto è tale in quanto discostato, tagliato fuori. La diaspora ha principio nella Torre di Babele, con l'imposizione di molteplici lingue, poi nella suddivisione delle tribù. C'è la partenza dall'Egitto, l'Impero più antico, fondato sulla ripetizione, sull'immutabilità e su dèi molteplici. L'Egitto che è, in un certo senso, l'incarnazione del mondo intero, dal quale il popolo eletto si discosta, smarrendosi per quarant'anni nelle sabbie del deserto.
E l'Esodo?
"Doveva essere una prima prova di separazione da tutto, un esercizio per abrogare ogni natura proliferante, per dimenticare le immani acque nilotiche e soprattutto quegli animali ovunque venerati e incombenti in ogni angolo dell'Egitto." (p.252)
L'Ebreo nel mondo può essere ortodosso o assimilato. E in entrambi i casi, ha storicamente subito persecuzioni, nel primo per la sua voluta estraneità, nel secondo per il suo "troppo imitare". L'animale umano, ci insegna Il cacciatore celeste (Adelphi, 2016), si fa mangiatore di carne imitando la iena, poi il predatore stesso. Imitare l'avversario è il primo passo per sostituirsi a lui, sgominarlo. La stessa imitazione è la colpa che abbatte gli abitanti di Babele, che troppo si assimilano a Iahvè nell'altezza della loro Torre; o i progenitori, che col pomo della conoscenza pervengono al suo sapere. La colpa, parrebbe, sta nell'imitazione. E ciò porta a un altro punto cruciale, quello delle immagini:
"Iahvè aveva creato l'uomo, un essere che con le immagini respirava e di immagini si nutriva, già nell'incessante lavorio della mente – e ora doveva rinunciarvi, forzando la propria costituzione.
Recidere il nesso con le immagini implicava recidere il nesso con il cosmo, in quanto gli dèi erano intrecciati al cosmo. E le immagini permettevano di passare, di ramo in ramo, dall'uno all'altro degli elementi del cosmo, fino agli dèi […]. Per questo Iahvè aveva posto il divieto sulle immagini prima di ogni altro" (p.254).
Ma Iahvè stesso creando l'uomo lo aveva plasmato "a nostra immagine, a nostra somiglianza".
"E anche a quell'essere si sarebbe trasmessa l'inclinazione a creare qualcosa a immagine di se stesso o di altro" (p.257).
E l'Egitto? È la culla delle immagini e "più grave era la sua bellezza" (p. 405), il cui influsso echeggia nel maledetto vitello d'oro, atto supremo di idolatria, alla quale il popolo di Israele ancora soggiace dopo la fuga. Ma l'Egitto è anche l'Impero delle acque, i cui dèi solcano il Nilo. Quanto al popolo ebraico, sanciranno la propria distanza dividendo il Mar Rosso e attraversandolo senza bagnarsi. "L'odio per l'Egitto discendeva dall'odio per le acque […] muovere contro l'Egitto significava soprattutto debellare le acque" (p.408-409).
E tuttavia, Giuseppe fu assimilato al popolo egizio, protetto dal Faraone. E così Mosè, che una principessa volle crescere. L'Egitto si pone come il predatore prima imitato e poi rinnegato, come la chimera che affascina e atterrisce. È il momento che ormai sappiamo, quello in cui Roberto Calasso balza nel tempo e nello spazio, ricordandosi che ne Il disperso di Franz Kafka c'è un capitolo intitolato La marcia verso Ramses:
"In nessun punto del romanzo si dice perché Karl Rossmann dovesse avviarsi verso Ramses […] Il disperso è la storia di un tentativo di uscita dall'Egitto" (p.234).
Un intero capitolo è poi dedicato a L'uomo Mosè e la religione monoteistica, opera tardiva di Sigmund Freud, costellata di esitazioni e timori perché "sottrarre a un popolo l'uomo che esso celebra come il più grande dei suoi figli non è cosa che si intraprenda volentieri o alla leggera, quando oltre tutto a tale popolo si appartiene" (p.300). Così Freud, una volta affermato e che "Mosè era un Egizio" e che "ha creato l'Ebreo", non può che rammentare quanto il monoteismo esclusivista fosse creazione prima del Faraone Ekhnaton e del suo culto di Aton. Neppure la circoncisione, il segno che avrebbe distinto le genti di Iahvè dalle altre, era ignota alla cultura nilotica. I lacci con l'aborrito popolo egizio si fanno intensi, soffocanti. "Freud aveva inferto agli Ebrei quella che, nel suo linguaggio, avrebbe chiamato una grave ferita narcisistica" (p.314).
Ma il colpo più violento ancora doveva essere scagliato. Freud avrebbe cercato di dimostrare come, nonostante la reticenza dei testi biblici, Mosè fosse stato lapidato dal popolo. E ciò in quanto voce di Iahvè, suo sostituto in terra. "Gli uomini hanno sempre saputo", scrive Freud e riporta Calasso, "di aver avuto un padre primordiale e di averlo ucciso" (p.319). Ecco quale sarebbe la colpa che l'intero genere umano si porta dietro dalle proprie origini: l'assassinio di un patriarca, poi ripetuto nel sacrificio di Cristo. Destino del popolo ebraico sarebbe quello di rappresentare ogni volta l'evento della colpa, ricordandolo al resto dell'umanità e riaprendo costantemente la ferita:
"A causa di questo "privilegio" gli Ebrei erano esposti a un "odio perenne", in quanto ponevano sotto gli occhi di tutti ciò che tutti avevano compiuto, ma non avevano alcuna intenzione di rammentare. E fu un audace artificio di Freud far passare tutto questo, che la Bibbia non dice, come fondamento della Bibbia stessa" (p.323).
E poi, ecco lo stravolgimento:
"Quando il Tempio di Gerusalemme venne distrutto per ordine dell'imperatore Tito, gli Ebrei dovettero interrompere totalmente i sacrifici cruenti, ammessi soltanto nel Tempio" (p.447).
E così, il popolo dell'olocausto e dell'uccisione dovette cessare di versare sangue. Dopo aver paragonato i collerici Profeti dell'Antico Testamento ai ŗși ("rishi") vedici sempre pronti a macellare agli dèi, Calasso narra di genti che tutti gli antichi avrebbero sbeffeggiato assieme ai cristiani, "perché parlavano sempre di sacrificio ma si rifiutavano di uccidere animali" (p.449). Così Giuliano l'Apostata, Imperatore del Tardo Impero, avrebbe tentato di rendere a questi irregolari il proprio Tempio, dunque il sacrificio cruento; ma il suo tentativo sarebbe stato vano: il popolo che ripudiava le immagini doveva evolversi sempre più nel simbolo e nella rappresentazione astratta.
Ed ecco giungere l'arma cristiana: il passaggio dall'atto del sacrificio al suo ricordo. Ecco la sostituzione del pane e del vino, ecco quell'unico Agnello da immolare una volta per sempre e riprodurre ogni domenica su un altare rituale:
"Doveva essere un doppio ricordo: di un fatto singolo e databile – l'uccisione di Gesù sulla croce – e di una metamorfosi proclamata: il pane e il vino che diventavano corpo e sangue di Cristo e venivano mangiati e bevuti. Occorreva ricordare due atti, i soli inevitabili e inestricabilmente connessi: l'uccisione e la consumazione" (p.453).
È il sacrificio che sempre si rinnova, ma che è già stato, ancor prima che sulla croce. E a pagina 361 Calasso cita "la domanda più temibile" di Simone Weil: "L'Agnello è in qualche modo sgozzato in cielo prima di esserlo sulla terra. Chi lo sgozza?". E la stessa citazione apre un volumetto postumo del compianto Direttore, Sotto gli occhi dell'Agnello (Adelphi, 2022), che volge al futuro il mistero di questo essere sacrificale, che regnerà nell'Apocalisse, osservando impassibile la distruzione del mondo che lo ha ucciso. Ed è bello pensare questo pamphlet come un'appendice tardiva de Il libro di tutti i libri, come l'ultimo anello di una catena di enigmi.
Siamo quasi alla fine del viaggio. Ma c'è poi una fine in Roberto Calasso?
(articolo a cura di Sharon Tofanelli)
Bibliografia:
Roberto Calasso, Il libro di tutti i libri, Adelphi 2019, ISBN 9788845934179
Roberto Calasso, Sotto gli occhi dell'Agnello, Adelphi 2022, ISBN 9788845936715
Se vuoi collaborare con la Rubrica Letteraria del Club del Libro, segnalarci iniziative interessanti o semplicemente comunicare con noi, scrivici a:
![]()






