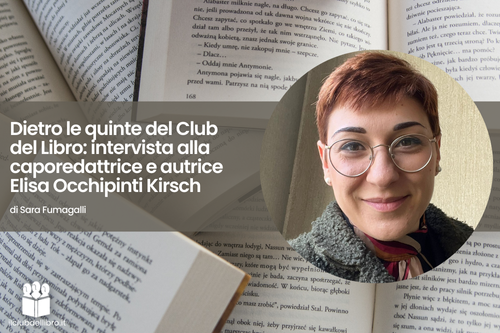
Dopo l'intervista a Guido Cilia, fondatore e amministratore, guardiamo nuovamente dietro le quinte del Club del Libro con un'intervista alla caporedattrice della Rubrica letteraria. Elisa Occhipinti Kirsch è anche autrice e in questa intervista nell'ambito di Redattore per un giorno le chiediamo di raccontarci meglio delle sue opere e del premio letterario che ha appena vinto.
Ciao Elisa, che piacere intervistarti per il Club! A proposito di Club del Libro, prima di partire subito con le domande sulle tue opere, c’è un avvenimento importante da ricordare: quest’anno sono 15 anni che fai parte di questo bellissimo mondo. Che sensazioni provi a riguardo?
Se penso a tutta la vita che è passata in questi quindici anni, mi gira la testa! Quando ho cercato in internet un club del libro e sono incappata qui, era il 2010 e io avevo solo 22 anni: nel frattempo mi sono sposata, ho avuto un figlio, sono emigrata in Germania, ho divorziato, mi sono laureata, ho avuto un secondo figlio, mi sono risposata, ho adottato una cagnolina, ho cambiato completamente direzione in ambito professionale. E Il Club del Libro è stato la mia presenza costante, un punto di riferimento della mia quotidianità con buone letture, scambi di riflessioni, risate, amicizie (la mia migliore amica Katya l'ho conosciuta proprio qui!) e mooolti articoli da scrivere o revisionare per la Rubrica Letteraria. Anche la Rubrica Letteraria ne ha fatta di strada: i primi anni l'ho gestita da sola, ora abbiamo uno Staff molto valido. Provo molta gioia e gratitudine, sarei stata un'altra persona senza Il Club del Libro e di sicuro non sarei diventata autrice.
Nel tuo primo romanzo, E lucevan le stelle (Miraggi Edizioni, 2018) racconti la storia di Ulrike, che è morta ma la sua anima è ancora intatta. C’è un messaggio che hai voluto comunicare con questo libro?
Ulrike è un personaggio liberamente ispirato a un'anziana signora tedesca che ho avuto il piacere di conoscere appena emigrata in Germania, ma purtroppo non di conoscere bene quanto avrei voluto, essendo venuta a mancare dopo nemmeno un anno. Non parlava volentieri della sua vita, che pensava fosse "una vita come tante" e una vita con troppo dolore, a partire dalla sua fuga da Danzica da bambina. Così, dopo la sua morte, ho iniziato a fare delle ricerche sul poco che sapevo di lei e da quelle suggestioni è nata la mia storia. Ho riflettuto sulla morte, perché non sappiamo esattamente cosa verrà dopo, e ho riflettuto su come ogni vita sia straordinaria e nonostante tutto degna di essere vissuta, fino alla fine – perché non è mai troppo tardi.
In Primo Levi e la coscienza poetica (Divergenze, 2021) affronti la lirica di Primo Levi come origine delle sue prose. In che modo la vocazione poetica di Primo Levi riesce a trasformare esperienze personali e storiche in riflessioni universali che restano attuali nel tempo?
La lirica ha un’immediatezza diversa dalla prosa e, per questo, ha un impatto diverso sul lettore. Se leggiamo il libro Se questo è un uomo ci rimangono in mente alcune immagini terribili, ma leggere la poesia Shemà è un vero e proprio pugno nello stomaco. L'attualità del messaggio leviano è sotto gli occhi di tutti: viviamo ancora in un mondo in cui c'è sempre un "diverso" da discriminare, combattere, uccidere. Le sue parole riecheggiano ancora oggi e non si capacitano del perché l'uomo ancora non abbia imparato dalla Storia.
Nel mio saggio mi concentro sulle tre poesie dalle quali sono nati i libri che compongono la cosiddetta "trilogia della Shoah", ma vale la pena conoscere a pieno il Primo Levi poeta, perché ci ha regalato anche poesie delicatissime e meravigliose come, ad esempio, Avigliana.
Nel tuo terzo libro, Gastarbeiterliteratur. La letteratura interculturale: tre poeti italiani in Germania (Divergenze, 2023), analizzi la Gastarbeiterliteratur come movimento letterario interculturale e multilingue, esplorando il contributo di tre poeti italiani emigrati in Germania. Ritieni che la Gastarbeiterliteratur abbia lasciato un’eredità nel panorama letterario tedesco e internazionale?
La "Gastarbeiterliteratur" – tra virgolette perché il termine nasce come provocatorio e si è rivelato infelice – nasce e si sviluppa in Germania negli anni Settanta-Ottanta, anni in cui non si era come oggi orientati alla multiculturalità e alla differenza. I Gastarbeiter (e gli stranieri in generale) non erano visti per nulla di buon occhio. Perciò quello che hanno fatto questi giovani autori è stato rivoluzionario e molto ottimista: volevano cambiare il mondo letterario ma anche la società, dimostrando che anche lo straniero può fare letteratura utilizzando, in molti casi, persino la lingua dell'altro. Questo è stato il germe di ciò che noi oggi chiamiamo letteratura interculturale, un fenomeno su scala mondiale sul quale oggi ci sono manuali e antologie, che riconosce agli scrittori "tra due mondi" un proprio posto nella letteratura.
Qual è stato il percorso che ti ha portata a esplorare argomenti così diversi, dall’opera in E lucevan le stelle alla letteratura interculturale in Gastarbeiterliteratur, passando per l’analisi della poetica di Primo Levi?
In realtà l'opera non ha un ruolo prominente in E lucevan le stelle, è semplicemente una delle passioni di Ulrike. Sono passata dalla narrativa alla saggistica perché quelli sono stati gli anni del mio studio e del mio lavoro alla Ruhr-Universität Bochum: anni molto stimolanti, in cui ho vissuto in simbiosi coi libri. I libri su Primo Levi e sulla "Gastarbeiterliteratur" sono nati entrambi da testi scritti in ambito universitario, che sono poi diventati piccoli saggi "divulgativi". Ne ho ancora uno inedito nel cassetto, che magari proporrò a qualche editore dopo averlo rielaborato, anche se la mia intenzione è tornare alla narrativa.
Il prossimo marzo a Roma verrai proclamata vincitrice del Premio Italia Radici nel Mondo 2024 con il tuo racconto Il Paese dove (s)fioriscono i limoni. A dicembre è anche già uscita l’antologia Sconfinamenti (Ianieri editore) con i racconti finalisti del premio. Che emozioni provi ad aver vinto un premio letterario, contando anche che questa è la prima edizione di questo premio?
È stata un'emozione fortissima perché questo premio – che per la prima volta onora "l'Italia fuori dall'Italia", essendo destinato solamente a italiani e italodiscendenti residenti all'estero – ha per me un forte significato simbolico: il tema delle radici mi è molto caro ed è da molti anni che mi ci arrovello. In più per me è stato come un "riconoscimento" conferito al mio vissuto degli ultimi 12 anni, visto che il mio racconto è autobiografico. Emigrare non è mai facile, trovare la propria strada in un altro luogo, crescerci persino dei figli. Ci si sente sempre, fondamentalmente, "né carne né pesce" e col cuore diviso a metà. Nel mio racconto ho condensato la mia esperienza di emigrazione attraverso piccoli aneddoti – e ci ho messo dentro anche Goethe, come si evince dal titolo.
(articolo a cura di Sara Fumagalli)
Se vuoi collaborare con la Rubrica Letteraria del Club del Libro, segnalarci iniziative interessanti o semplicemente comunicare con noi, scrivici a:
![]()






