Pur non essendo un appassionato del circo, sono rimasto sempre affascinato da questo mondo che dietro all’apparenza di magia, mistero e mirabilia nasconde una faccia fatta di tutta una umanità che ha ben poco di eccezionale. Spesso si tratta di persone che per la loro passione, lo spettacolo, si votano ad una vita di sacrificio fatto di tante ore di esercizio, una vita nomade con tutti i pro e i contro che essa comporta.
La moglie lo attribuiva alla vita errante del circo, sempre peregrinando senza una meta fissa, mangiando male, dipingendosi la faccia con quegli impudici intrugli permessi da Dio alle donne di strada, ma dannosi per una persona dabbene.
E l’emblema del circo è senza dubbio il pagliaccio.
Quanto questa figura, che piaccia o meno, sia entrata nel nostro immaginario collettivo lo si riscontra facilmente nella diffusione di opere che la hanno posta al centro. Si pensi a “IT” di Stephen King nella letteratura horror o a “I Clowns” di Fellini in ambito cinematografico. E come non citare il mitico “Joker”, tornato nuovamente alla ribalta grazie al bravissimo Joaquin Phoenix?
E ciò che secondo me, più di tutto, forse del clown ci affascina e in cui talvolta ci rispecchiamo, è questa sua duplice natura divertente e ridanciana da un lato, ma che cela spesso un’interiorità malinconica e seria dall’altro.
Pare che anche uno dei più grandi “pagliacci” che abbiamo avuto nel mondo della comicità italiana, il grande Totò de Curtis, avesse, lontano dagli schermi, una certa vena di tristezza.
Uno dei miei film preferiti, forse il mio preferito, è Patch Adams. Il film interpretato dal grandissimo Robin Willliams narra le vicende realmente accadute di un medico che cercò di applicare un principio che ormai è ampiamente assodato anche a livello scientifico: ridere fa bene alla salute e aiuta a superare momenti difficili. Eppure anche Robin Williams, a un certo punto, ha sentito di non poter trovare altra scappatoia a questa profonda malinconia (leggi depressione) che attraverso la rinuncia a la vita stessa.
In questa nostra lettura del mese ho apprezzato molto come la Allende ha caratterizzato il personaggio di Hipolito Ranquileo che è appunto inscindibile, secondo me, dal suo lavoro come pagliaccio. Sembra anzi che per Hipolito fare il pagliaccio non sia solo un lavoro, ma uno stile di vita. Può essere, secondo voi, il tentativo estremo di scrollarsi di dosso questa sorta di innata tristezza?
In pochi anni il gagliardo giovanotto che aveva accettato in sposo si era trasformato in quell’ometto contratto dalla faccia incartapecorita a forza di far smorfie, dove il naso sembrava una patata, che tossiva troppo e si addormentava nel mezzo di una conversazione. Nei mesi di freddo e di forzata inattività soleva far divertire i bambini indossando il costume da pagliaccio. Sotto la maschera bianca e l’enorme bocca rossa aperta in una risata perenne, la moglie vedeva le rughe della stanchezza. Poiché era ormai un po’ decrepito, ogni volta gli era sempre più difficile trovar lavoro e lei nutriva la speranza di vederlo stabilito nei campi ad aiutarla a lavorare.
Bello come la moglie Digna è quella persona che riesce a vedere oltre la maschera di Hipolito. Come a dire che c’è per ognuno di noi una persona con cui non abbiamo bisogno di portare una maschera, ma possiamo mostrarci per quello che siamo. Anzi, quella persona ha la capacità di vedere oltre la nostra maschera anche se c’è la vogliamo gelosamente tenere addosso. E questo alla fine ci libera.
Dapprima era stato trapezista e saltimbanco, ma con gli anni aveva perso l’equilibrio e la destrezza. Poi aveva fatto una breve incursione come domatore di certe misere fiere, che sconvolgevano la sua pietà e avevano logorato i nervi. Alla fine si era rassegnato a fare il pagliaccio.
Bellissima la figura di Hipolito che prova pietà per le fiere che è quasi costretto a domare. Il pagliaccio ha un animo sensibile ed è per questo che talvolta arriva al cuore delle persone. Devo dire che anche a me gli animali al circo fanno parecchia pietà!
Notare poi come la Allende associa alla figura del pagliaccio il sentimento della rassegnazione.
In seguito Digna non permetteva loro di andar al circo a vedere il padre declinare fra le sue tristi piroette, preferiva che conservassero nella memoria quell’aerea immagine e non si vergognassero alla vista dei suoi grotteschi panni da pagliaccio vecchio, battuto e umile, mollando scoregge, parlando in falsetto e ridendo senza motivo.
E qui c’è secondo me l’apoteosi del simbolismo associato al pagliaccio. Egli è colui di cui ci si vergogna perché si mette in ridicolo (si pensi all’uso del termine nel linguaggio comune), è grottesco e agisce senza una logica. Il pagliaccio ci va bene quei cinque minuti in cui ci fa divertire, poi subentra la pena e infine anche lo stigma.
"Bea sostiene che leggere è un'arte in via di estinzione e che i libri sono specchi in cui troviamo solo ciò che abbiamo dentro di noi, e che la lettura coinvolge mente e cuore, due merci sempre più rare"
Carlos Ruiz Zafon
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
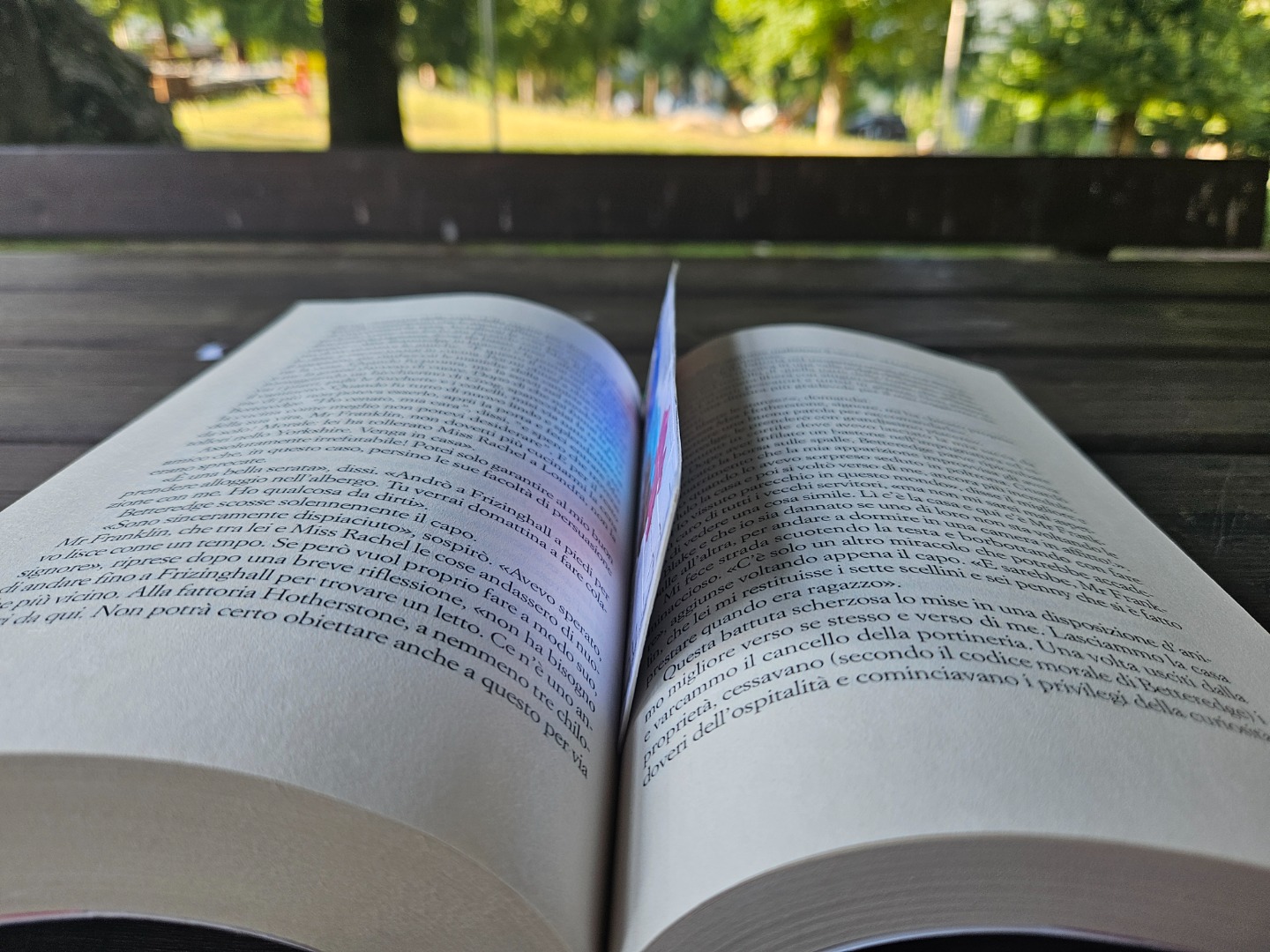 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano





