Dato che una sezione dedicata agli italiani ancora mancava

, ho pensato di aprirla.
Il mio desiderio fu esaudito: conobbi finalmente Fosca … Dio! Come esprimere colle parole la bruttezza orrenda di quella donna! Come vi sono beltà di cui è impossibile il dare una idea, così vi sono bruttezze che sfuggono ad ogni manifestazione, e tale era la sua.
L’autore è Igino Ugo Tarchetti, uno dei maggiori esponenti della Scapigliatura milanese. “Anticonformista e tendente alla malinconia e alle fantasie macabre, ha lasciato diverse opere tra romanzi, racconti e poesie”: l’opera più famosa è appunto
Fosca, la malattia personificata, l'isterismo fatto donna, un miracolo vivente del sistema nervoso.
Se fosse un libro al buio, “inquietante” sarebbe l’aggettivo (piuttosto abusato, purtroppo) che userei per dare un indizio, ma potrei aggiungere anche “appassionante”, visto che di passione si tratta. Talmente morbosa però, da non lascia alcuno spazio ai sogni, ma solo agli incubi:
più che l’analisi di un affetto, più che il racconto di una passione d’amore, io faccio forse qui la diagnosi d’una malattia – Quell’amore io non l’ho sentito, l’ho subito.
E infatti Fosca “è romanzo che ruota intorno all'amore implorato, preteso, anche a costo di diventare persecutorio e forzato”. Una sorta di
La Bella e la Bestia a ruoli rovesciati, si potrebbe anche pensare (
Mi disprezzerete! Ebbene, non importa; purché mi soffriate, purché mi permettiate di vedervi, di dirvi il mio amore, di raccontarvi i miei patimenti, di piangere con voi. Se non l’avessi confessato io che vi amava, voi non me l’avreste detto mai, nessuno me l’avrebbe detto perché hanno tutti orrore di me. Oh, abbiate compassione! amatemi, amatemi; si ama un cane, una bestia … e perché non amerete me che sono una creatura come voi?), ma senza alcun elemento romantico, fantastico o fiabesco.
E’ invece molto realistica e moderna la critica - più o meno velata, anche d’ironia - di Tarchetti a certe norme sociali (dell’epoca?), che imponevano alla donna il ruolo esclusivo di oggetto di seduzione:
tu non sai cosa voglia dire per una donna non essere bella. Per noi la bellezza è tutto. Non vivendo che per essere amate, e non potendolo essere che alla condizione di essere avvenenti, l’esistenza di una donna brutta diventa la più terribile, la più angosciosa di tutte le torture.
Insomma, una lettura iniziata un po’ per caso, ma rivelatasi sorprendentemente avvincente e molto piacevole. Almeno una volta superato lo scoglio dello stile: e qui colgo lo spunto per accennare ad un possibile tema di discussione.
Ho letto
Fosca subito dopo aver concluso la lettura di
Orgoglio e Pregiudizio. Tra le due opere v’è uno scarto di circa mezzo secolo: eppure – potenza delle traduzioni! – la seconda pareva stilisticamente assai più moderna della prima. Sicché m’è venuto il dubbio che forse sarebbe opportuno svecchiare anche i nostri classici, per renderli più al passo coi tempi, o almeno al passo con i classici stranieri che vengono costantemente ritradotti, riveduti e corretti. Perché è vero che “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire”, come diceva Italo Calvino, però bisognerebbe anche che si facesse capire.
Curiosamente ho scoperto però che la medesima definizione è sbandierata sia dai sostenitori che dai detrattori delle “traduzioni” di classici italiani. Aldo Busi, ad esempio, che nel 1990 si occupò della traduzione del
Decameron di Boccaccio, riteneva naturale e addirittura “indispensabile” una “traduzione” del capolavoro boccaccesco, in quanto “l'italiano del trecento è una lingua totalmente straniera”. E così anche l’italiano dei secoli successivi. Per rimanere viva, un'opera letteraria deve essere periodicamente riadattata secondo il linguaggio corrente.
D’altra parte, ritenendo che tra l’italiano del passato e quello attuale vi sia assai più affinità di quanta potrebbe essere riscontrata in altre lingue, altri si proclamano contrari a questo tipo d'operazione, perché contribuirebbe a quella standardizzazione e banalizzazione che già impoverisce il linguaggio del nostro tempo. Così Salvatore Settis, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, afferma: “se Dante è ancora un poeta italiano non è perché le nostre biblioteche conservano, chiusi a chiave negli armadi, tanti manoscritti della ”Divina Commedia”, ma è perché (o finché) sappiamo ancora leggerla o intenderla, dato che per fortuna la lingua che parliamo è più vicina a quella di Dante di quanto l’inglese parlato sia simile a quello del molto più recente Shakespeare. In questo senso, Roberto Benigni che fa letture pubbliche di Dante trascinando migliaia di uditori rende un miglior servizio a Dante di quegli italianisti che si accingono a “tradurre” la “Divina Commedia” in “italiano parlato” impoverito e pastorizzato per adeguarsi alla banalità del linguaggio televisivo” ...
E voi, cosa ne pensate?
![]()
![]()
![]()
![]()
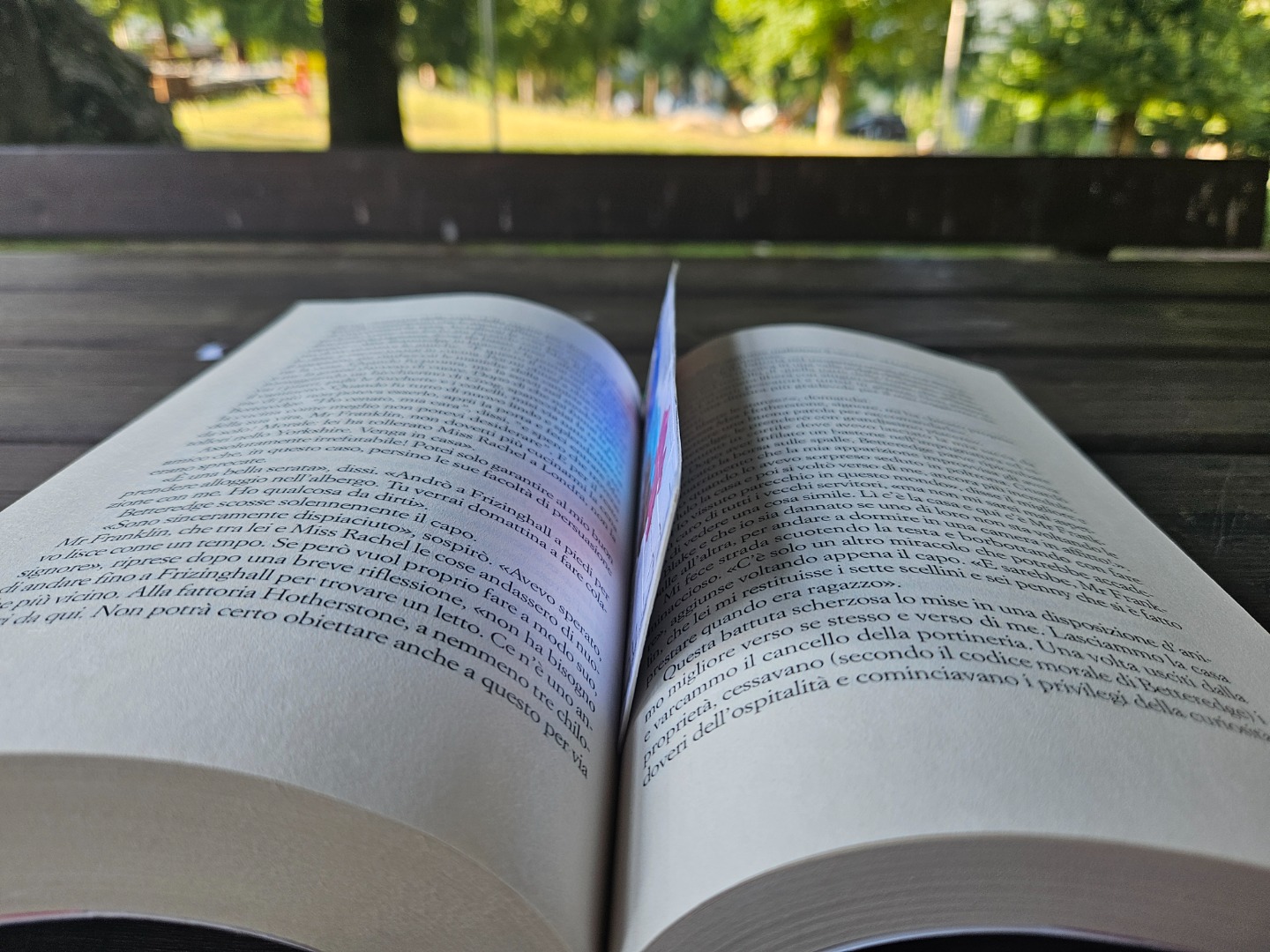 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano





