Alla fine ho letto anche io questo romanzo e sì, sicuramente non è una lettura che ricorderò per tutta la vita, ma devo dire che a me non è dispiaciuto e l'ho trovata anche gradevole. L'idea mi pare originale per come è stata pensata, poi ovviamente i viaggi nel tempo sono numerosi nella letteratura.
La traduzione non mi è sembrata pessima, qualcosa non l'ho gradita, ma nel complesso non la boccio e, inoltre, avendo letto sia
Memorie di una geisha (semi-realtà jappo ma scritto da un americano) che
La storia proibita di una geisha (che non mi ha fatto impazzire) ritrovo alcune cose simili, specialmente con il secondo, tra cui la ripetizione (che sia una cosa della cultura giapponese?).
Secondo me, oltre a storie che possiamo tranquillamente vedere come attuali (viaggio nel tempo a parte), nel libro ho trovato alcune giapponesità e un po' di filosofia orientale. Tra le cose tipicamente giapponesi ci sono i già citati "sorellona" e il segno V con le dita che sono molto tipici nei cartoni animati giapponesi (detti
anime) e, almeno per il secondo, anche dal vivo quando ho visto giovani giapponesi nei miei viaggi all'estero. Ci sono poi una sorta di rito del tè, stavolta declinato al caffè, e lo stacanovismo sul lavoro di Goro. Volendo anche la lentezza. Per quanto riguarda la filosofia orientale, io ho visto tanto "qui e ora" nel primo racconto.
Rispondendo a Greta:
1) il modo di presentare i personaggi: nome e cognome, come sono vestiti. Mi è sembrato di leggere un manga, infatti in alcuni i personaggi vengono proprio mostrati così: c'è la loro foto e un cartellino con nome, cognome, età e magari qualcos'altro, professione o un tratto particolare.
A me, invece, ha dato l'impressione che l'autore volesse descrivere attori su un palcoscenico, ma così come li vedrebbe uno spettatore (quindi con abiti di scena) e non dal punto di vista dello sceneggiatore. Ho avuto questa percezione anche con gli intermezzi del campanello, come a voler "cambiare scena".
Il fatto che si debba aspettare che il posto si liberi forse vuol dire che non è sempre il momento giusto per affrontare il passato e i rimorsi, bisogna prima accettarli e al momento giusto ci si può tornare su.
Sì, anche io ho pensato fosse così anche perché le due che vogliono sedersi sulla sedia impulsivamente, quindi senza pensare molto alle conseguenze, si beccano la maledizione.
Non ho capito perché l'autore si sia soffermato molto sul conto, su quanto ciascuno pagasse. Ipotizzo che avesse un significato e che indicasse il carattere dei personaggi. Ricordo, ad esempio, il conto enorme dell'ordine fatto dalla sorella di Hirai perché affamata, ma più che fame sembrava avesse una sorta di buco nero nello stomaco... ecco, qui ho pensato che qualunque cosa ingurgitasse non l'avrebbe mai saziata perché la sua era fame d'amore.
Non ho capito neanche io la questione degli orologi, ma forse era solo un modo per disorientare i clienti (e noi lettori) e dare l'idea di essere in una bolla in quel locale, cioè fuori dal tempo. Bolla che, secondo me, trova un po' conferma anche con le temperature differenti rispetto a quelle fuori dalla sala.
Le quattro storie non le ho trovate inverosimili, forse solo l'innamoramento di Kei all'ospedale mi ha fatto un po' sorridere, però alla fine una cosa del genere può capitare. Mi hanno toccato di più le ultime due storie, specialmente l'ultima che mi ha regalato un momento di occhi lucidi. Più che altro, l'autore pone il punto sulla incapacità di comunicare con le persone amate sia perché ogni personaggio ha le sue emozioni che lo bloccano, sia perché si fa anche i propri film mentali... incomunicabilità che porta, ovviamente, a non centrare mai il pensiero dell'altra persona e a sentirsi soli, quando poi non è così. Forse il messaggio finale del romanzo è di parlare, di aprirsi, di dire effettivamente le cose che vorremmo dire invece di stare zitti e di avere poi rimpianti. Quindi, in un certo senso, di lanciarsi e di non avere paura, essere cioè coraggiosi.
Il viaggio nel tempo, comunque, serve non per cambiare il presente o il futuro (cosa impossibile da fare come da regole del locale), ma per cambiare il modo di vivere della persona che affronta quel viaggio. E' accaduto in tutte e quattro le storie, ma è palese proprio nella quarta perché Kei ci fa tutto lo spiegone.
Per me il libro del fantasma (di cui avrei tanto voluto conoscere la storia) potrebbe essere "
Gl'innamorati
" di Goldoni visto che si tratta di teatro, ma chissà! Sinceramente mi ha un po' infastidito che del fantasma non si conosca la storia, avrei voluto una rivelazione su questo misterioso personaggio: sembra essere in un mondo tutto suo, indifferente a tutto, ma alla fine scopriamo che è presente "nel presente" tant'è che cede il posto, volutamente, a Kei dopo aver ascoltato la sua storia guardandola fissa.
Credo che il successo sia dovuto al fatto che il romanzo ha vinto un premio nipponico e ha fatto molto successo in patria, da lì è stato tradotto in più lingue. E' surreale ma allo stesso tempo le storie personali sono comuni e plausibili, affrontano temi importanti (rottura, alzheimer, morte, abbandono) ma non sono pesanti, diciamo che sono solo accennate e quindi comunque il libro dà anche un senso di "leggerezza".
Sul successo editoriale, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo ma, secondo me, l'unica domanda che possiamo farci è la seguente: chi pompa affinché un autore o un romanzo diventi un successo editoriale? Circa una ventina di anni fa, in Italia, ci furono due successi editoriali di cui ancora mi chiedo "ma perché?" e cioè
100 colpi di spazzola prima di andare a dormire e
Tre metri sopra il cielo. Non dimentichiamoci neanche della trilogia di
Cinquanta sfumature negli USA. Insomma, non sempre "caso editoriale" significa "qualità/profondità". Chiaro che poi i gusti sono gusti, ma chi li ha letti converrà con me che non si tratta di libri memorabili
![]()
![]()
![]()
![]()
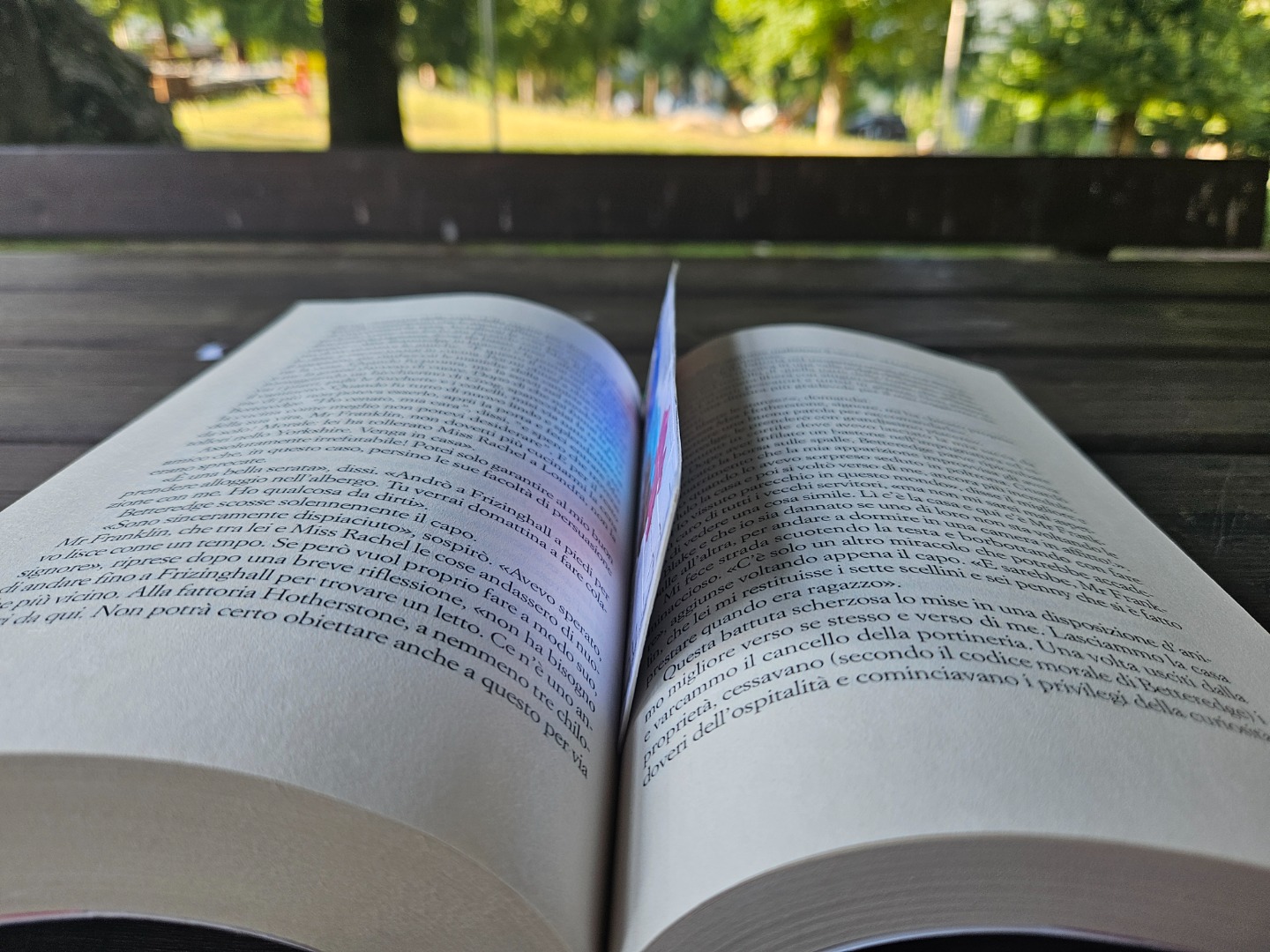 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano






