bibbagood ha scritto: Iniziato anche io,ma per ora è più che altro la descrizione del contesto in cui hanno deciso di creare il "club".
Due cose però mi hanno colpito: l´autrice parla degli autobus, in cui le donne dovevano (devono?) salire dalla porta posteriore e di sedersi nello spazio riservato alle donne. Una mia amica a giugno di quest´anno è andata in un paesino sperduto a occidente della Turchia, è atterrata a Istanbul e da là ha preso un aereo piccolo turco e appunto era rimasta sconvolta di come le donne dovessero sedere tutte insieme in fondo e gli uomini tutti insieme avanti (quindi famiglie e amici devono dividersi,ma in generale faceva impressione proprio il distacco netto, metteva angoscia solo il sentirlo raccontare).
Poi vabeh,una riflessione superflua, visto che sono cose che si sanno,ma che comunque mi impressiona sempre, riguarda la frase in cui l´autrice fa riferimento alla reintroduzione della lapidazione per le adultere e le prostitute. Capisco che sia una società maschilista,ma si potrebbe anche usare senza troppi problemi un´espressione neutra ovvero "per l´adulterio, per chi commette adulterio, ecc", invece l´autrice sottolinea il fatto che è riservato solo alle donne; ribadisco, è una cosa che si sa, e anche con l´utilizzo di un´espressione neutra avremmo capito tutti che le uniche ad essere lapidate per adulterio sono le donne e non gli uomini,però trovo comunque molto più forte l´utilizzo del´l´espressione al femminile,come se fosse una cosa data per scontata che le persone cui si rivolgono queste leggi sono esclusivamente donne e non c´è quindi bisogno di ricorrere ad espressioni più generiche.
Questo pezzo sull adulterio succede nella stessa frase al pezzo in cui l´autrice accenna all abbassamento dell età minima per sposarsi da 18 a nove anni, e non c´è bisogno di commento.
E' importante
cercare di capire
quale fosse la situazione in Iran prima della rivoluzione islamica del 1979:
Il benessere e lo sviluppo propiziati dallo Shah erano privilegi per una minoranza degli iraniani, soprattutto per la classe medio-alta delle città, mentre nelle campagne permaneva l'analfabetismo e la mancanza di infrastrutture. Il laicismo imposto dalla dinastia Pahlavi, oltre alla corruzione e agli sfarzi di corte, continuamente ostentati in pubblico per accrescere il lustro della "grande Persia", non faceva altro che alimentare l'astio di una società gelosa delle sue radici e distante da un modello di vita troppo occidentale. Indossare il hijab era proibito, ma per molte donne avere la testa coperta da un velo era un segno di appartenenza e di rispetto di antiche tradizioni. Specialmente negli ultimi anni del suo regno Reza Pahlavi si lanciò in spese folli e populiste (beni di consumo, armamenti militari) che stridevano clamorosamente con una rete di servizi e di infrastrutture assai carente e con una disoccupazione e un'inflazione giunte a livelli non più controllabili.
La paura di perdere il potere aveva indotto lo Shah a rafforzare la polizia segreta, la Savak, che pattugliava giorno e notte le vie delle città con orecchie tese ad ascoltare qualsiasi critica, diretta o meno, al sovrano e ai suoi fedeli. Sempre attraverso la Savak e l'esercito, il regime si premurava di sedare qualsiasi tentativo di ribellione e di perseguitare ed arrestare gli avversari politici, dai sindacati agli intellettuali, dal partito comunista Tudeh agli ulema seguaci dell'ayatollah Khomeini, già costretto in esilio a Najaf, in Iraq prima e a Parigi poi. La rivoluzione che ne seguì aveva quindi un terreno fertile per coinvolgere attori diversi fra loro, tanto che molti degli osservatori internazionali che avevano salutato con entusiasmo il cambiamento iraniano, all'insegna di una maggiore libertà, non furono capaci di prevedere quello che sarebbe successo subito dopo.
La debolezza e le divisioni di molte componenti della rivoluzione, dai comunisti ai sindacati passando per gli intellettuali e l'esercito, favorirono la presa egemone del potere da parte del clero religioso che in breve tempo riuscì ad organizzare un referendum per il passaggio dalla monarchia alla repubblica islamica, che venne stravinto con il 98% dei voti. Alla trasformazione dell'Iran in un Paese guidato dai dettami dell'Islam si accompagnò l'epurazione dei nemici interni, marchiando con l'epiteto di "infedele" chiunque si opponesse al regime o tradisse, seconda la visione dei mullah e ulema, gli ideali della rivoluzione. Cancellati i sindacati, i comunisti e buona parte dell'esercito e ridotto al silenzio il mondo intellettuale, il consiglio supremo della rivoluzione, maggior organo costituzionale guidato da Khomeini fino alla sua morte, rimase il padre-padrone dell'Iran.
Insomma in Iran i presupposti della presa del potere da parte degli islamici affondano tutti nel sistema di potere corrotto dell'allora scià di Persia e della sua dinastia Pahlavi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
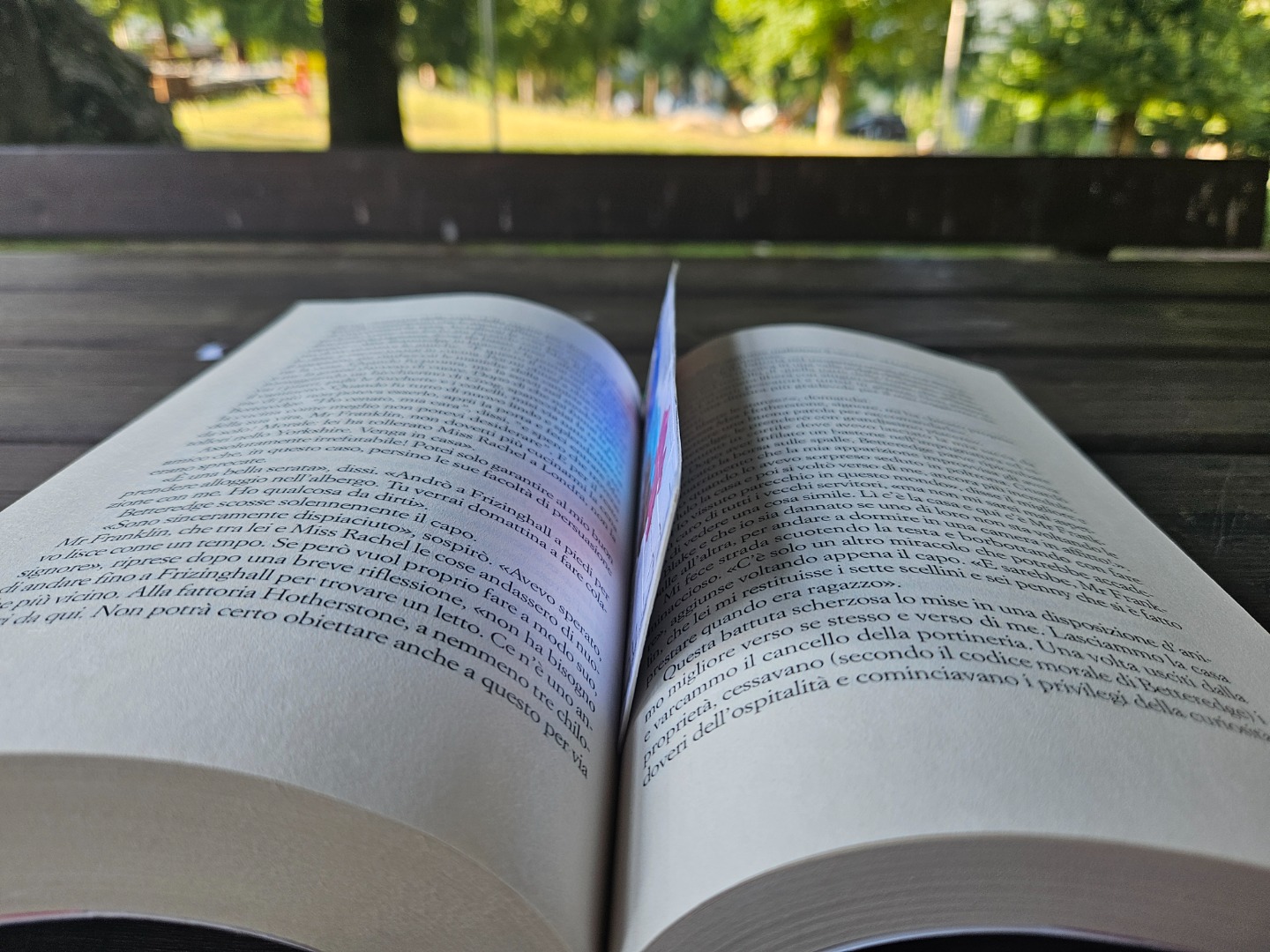 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano





