- Messaggi: 2518
- Ringraziamenti ricevuti 1627
Sorprese letterarie (aprile 2023)
Newsletter
Eventi
Shoutbox
Ciao a tutti,Sono una lettrice non molto assidua, mi sono appena iscritta con l' intento di farmi ispirare da voi dai vostri consigli.
Scusatemi ieri ho sbagliato ed addirittura confuso il giorno l'incontro era il 28 e non il 29. Quindi vorrei prepararmi per il prossimo mi dite dove posso trovare le informazioni, grazie.
Buon Natale!
Ciao Stefania, certo che può esserle d'aiuto. Qua leggiamo e scriviamo, ci confrontiamo e col tempo ci apriamo. La lettura diventa strumento di condivisione e crescita. Vi aspettiamo ![]()
Ciao sono Stefania mamma di una 23enne booklover amante di romance e thriller Mi sono iscritta al club perché ho bisogno di capire se può essere di aiuto a mia figlia in questo periodo difficile
Vi aspettiamo nel topic di SORPRESE LETTERARIE, il gioco di novembre!!! ![]()
Buongiorno! Se qualcuno avesse ancora problemi di login, dovete prima cancellare la cache del pc/smartphone, ricaricare la pagina, riaccettare i cookies e poi fare il login ![]()
Ciao Cristina, in che senso? Oggi sei riuscita a scrivere sul forum :-/ scrivimi una mail (![]()
Ciao a tutti non riesco ad accedere al forum ne con pc ne con il cellulare ![]()
Accedi per utilizzare la Shoutbox.
Ultimi commenti
-
Intermezzo
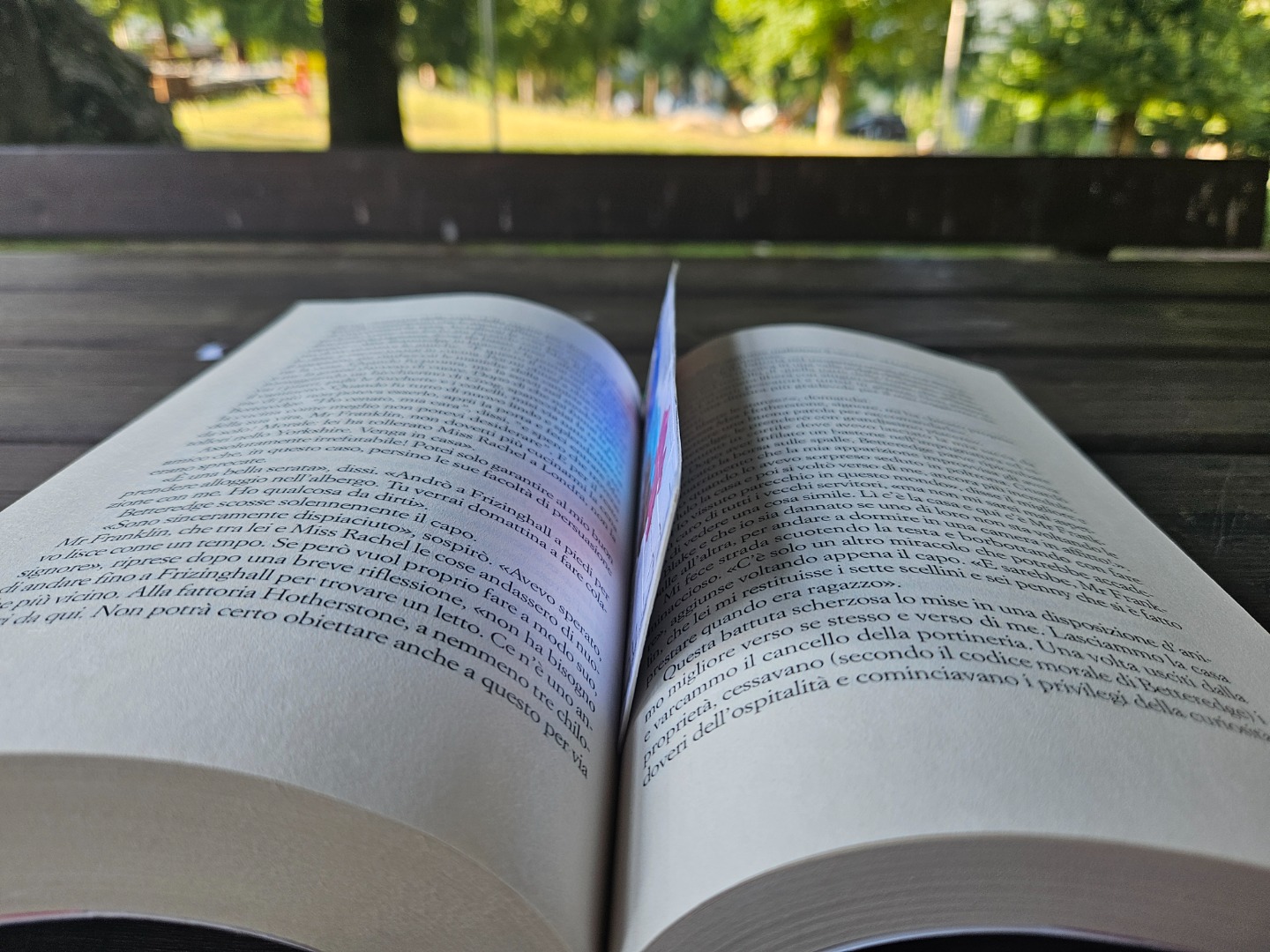 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. -
Luxnova. L'inizio
Martedì, 09 Dicembre 2025 12:36bellissimo e coinvolgente!!! -
Dentro il libro - Il deserto dei tartari e l'attesa del futuro: Dino Buzzati nell'era delle
 Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... -
Gruppo di lettura di Roma (LeggerMente Letturati) - Incontro di Novembre 2025
Sabato, 22 Novembre 2025 15:27Peccato questo l’ho perso.. grazie per la risposta!! A presto -
Gruppo di lettura di Roma (LeggerMente Letturati) - Incontro di Novembre 2025
 Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
ULTIME NOTIZIE
STATISTICHE
- Utenti registrati 10263
- Articoli 3236
- Visite agli articoli 7620025





