Margarethe ha scritto: Sono fattori istintivi che noi abbiamo trasformato in principi morali. Io penso che se vogliamo vivere in una società con dei principi dovremmo rassegnarci al fatto che molti di questi non hanno nessun senso dal punto di vista biologico/evoluzionistico. Ormai abbiamo uno stile di vita così lontano da quello "naturale", che possiamo scegliere i nostri principi, senza sentire il bisogno di un fondamento scientifico degli stessi.. Che ne pensate? I diritti umani, per dire, per me fondamentali ma che senso biologico avrebbero?
Come accade in molti casi, probabilmente anche in questo non è per forza tutto bianco o tutto nero. Magari c'è una via di mezzo. Ci sono i colori. Mi spiego.
Magari alcuni principi morali sono davvero insiti in noi a livello biologico, mentre altri semplicemente no.
Non credo che l'obiettivo degli studiosi sia quello di voler dimostrare a tutti i costi la presenza di un fondamento scientifico/biologico
in tutti i principi che oggi ci paiono assodati, come i diritti umani per l'appunto. Anche perché non arriverei mai a dire che il diritto alla protezione dei miei dati personali (che è stato inserito recentemente nell'elenco dei diritti umani) è biologicamente insito in me dalla nascita




Però forse ci sono aspetti che invece possono essere davvero ricondotti alla biologia.
Ed è quello che scopriamo a pag. 108 del saggio, dove l'autore ci dice che questo è proprio quello che Mikhail ha trovato, arrivando a definire i bambini "
avvocati intuitivi".
"
I bambini danno giudizi morali incredibilmente sofisticati, che rispecchiano non solo la moralità degli adulti, ma sistemi giuridici complessi. I bambini di tre e quattro anni usano l'idea dell'intenzionalità per distinguere due atti che hanno le stesse conseguenze: la persona che sbadatamente urta un uomo, facendolo cadere dal cavalcavia, e la persona che lo fa deliberatamente. [...] A quattro e cinque anni riconoscono una distinzione molto più complessa, ancora una volta simile a un distinguo legale, tra errore di fatto e errore di diritto".
È qui che fa il parallelo tra "cablaggio morale" e "linguaggio", operanti entrambi a livelli molto astratti, tenendo presente che comunque ci saranno alcune variazioni locali nella morale, così come ci sono tra le lingue (e qui torna il binomio morale - cultura).
In definitiva, se la domanda è da cosa deriva la morale di ciascuno di noi, secondo me la risposta corretta è: da
un'infinità di fattori! Abbiamo provato in queste settimane ad identificarne alcuni e secondo me ne abbiamo individuati molti ma sono certo che non siano tutti ed è proprio per questo che secondo me è impossibile trovare una "formula magica morale" da adattare a tutti i contesti. Potrei stare a parlarne per ore e non cambierei idea su questo...




Margarethe ha scritto:
Guido: inizio a capire come mai la filosofia è odiata da molti... farla alle superiori deve essere stato tremendo per tanti ragazzi e ragazze
Dipende molto da come è fatta. Io ho avuto due professori diversi: il primo partiva dai principi filosofici per farci ragionare sulle cose pratiche della vita, e avevamo il via libera nei ragionamenti, anzi lui cercava di spingerci a farli; l'altro voleva che imparassimo i concetti e basta, e non ci dava un collegamento con la realtà. Naturalmente il primo l'ho adorato e ricordo ancora le sue lezioni, del secondo mi è rimasta solo qualche caricatura e l'immagine di lui che si disperava per la nostra ignoranza 
"Lui che si disperava per la nostra ignoranza" è fantastico!





Immagino (e questo magari ce lo confermerà Vanna che è stata professoressa alle scuole superiori per molti anni) che un professore debba trovare un compromesso tra un metodo d'insegnamento e l'altro (anche in questo caso banalizzo facendo riferimento a due metodi, ma sono sicuro che ce ne siano moltissimi).
Nell'esempio che hai fatto, sicuramente tutti abbiamo apprezzato (o avremmo apprezzato) situazioni come quella in cui vi ha messo il primo professore. I concetti in quel caso, se rapportati a cose pratiche della vita, secondo me rimangono anche più impressi e si affrontano le ore di lezione volentieri.
Dall'altro lato però immagino che i professori debbano seguire dei programmi specifici ed in qualche modo dimostrare di aver coperto l'intero programma previsto per l'anno scolastico. Quindi suppongo che questo possa determinare, insieme ad altri fattori sicuramente, un calo della passione del professore nel coinvolgere gli alunni in un certo modo. Aspetto che determina il configurarsi di situazioni come quelle da te descritte con il secondo professore. Ci vorrebbe anche qui una via di mezzo

E magari anche una classe di ragazzi ben disposta...




Comunque, tornando al libro, ho iniziato la terza parte (sto provando a procedere più speditamente con la lettura perché si avvicina il momento dell'approfondimento con la Dott.ssa Zanon e vorrei finire di leggere il libro prima dell'evento).
Leggendo questo capitolo ho trovato elementi in comune con quanto dicevo all'inizio del post e con quanto probabilmente discuteremo durante l'incontro del 28/10.
"
Anche se ci piace autoingannarci e credere che prendiamo le decisioni liberamente e alla luce di una riflessione consapevole e motivata, sempre più dati sperimentali indicano che spesso la ragione fa un passo indietro di fronte a influenze inconsce".
E ancora:
"
Anche se c'è un numero infinito di fattori che potenzialmente potrebbero influenzare i nostri comportamenti e giudizi morali, sta emergendo un consenso generale sul fatto che sono coinvolti due grandi processi. Come caratterizzare esattamente questi due processi, e quale sia l'equilibrio di potere tra di essi, è oggetto di contesa".
E quali sono questi processi? Ormai lo abbiamo capito: la
ragione (la nostra parte razionale) e le
emozioni.
"
Ma se Haidt ritiene che a regnare siano le emozioni, altri non ne sono così sicuri: vedono lo scontro tra ragione ed emozione come un vero e proprio tiro alla fune".
Questo secondo me sarà proprio uno degli aspetti di cui parleremo la prossima settimana e che non vedo l'ora di approfondire


![]()
![]()
![]()
![]()
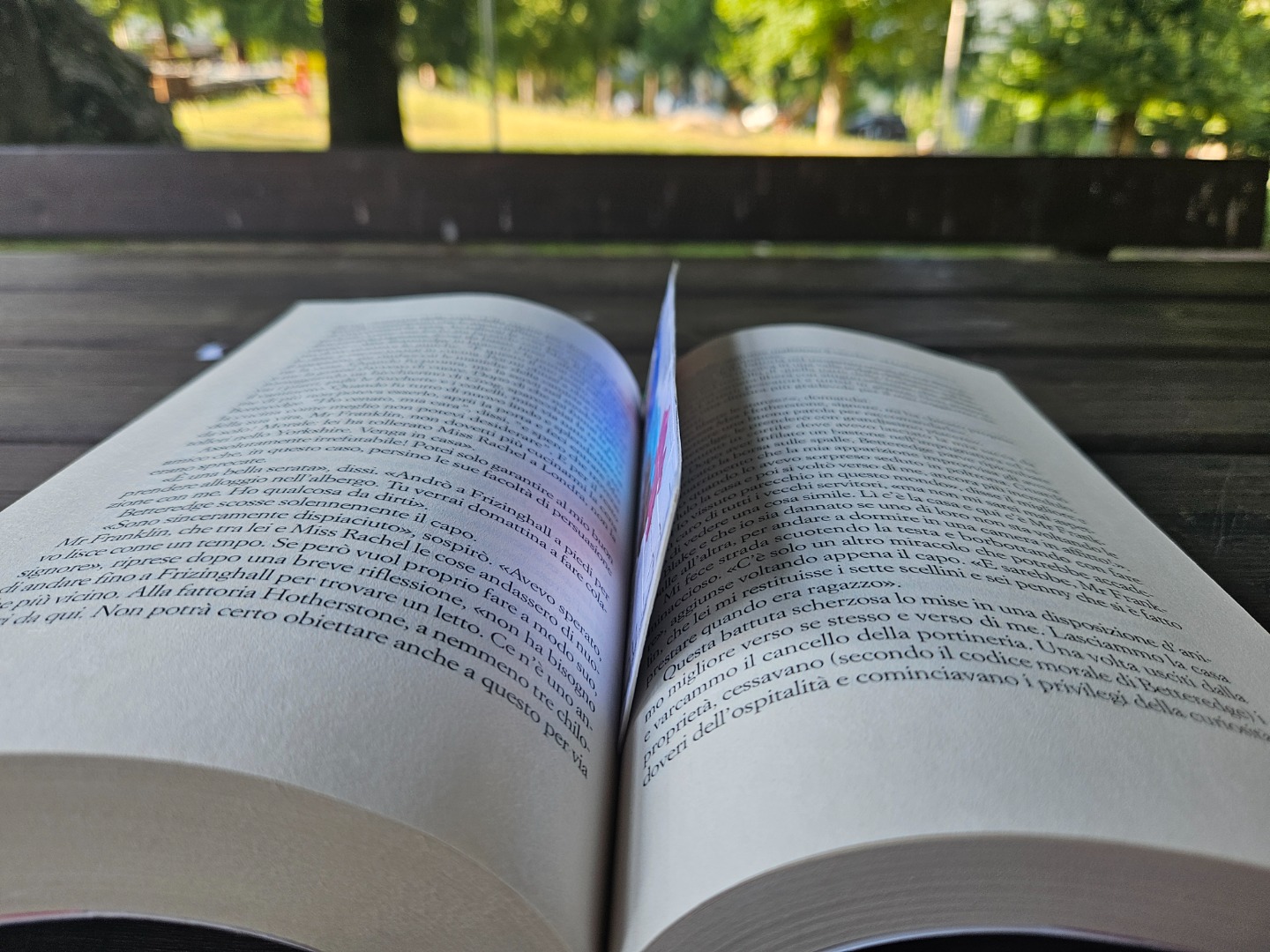 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano





