Sono tornata! E ho ben due estrazioni da recuperare, assieme a quella di oggi.
Libro n° 2, pag. 51, Siddharta di Herman Hesse:
"Che età credi che abbia il più vecchio dei nostri Samana, il nostro venerabile maestro?"
Disse Govinda: "Il più vecchio potrà avere un sessant'anni".
E Siddharta: "Sessant'anni ha vissuto, e il nirvana non l'ha mai raggiunto. Ne vivrà settanta, ottanta, e tu e io, anche noi, diverremo vecchi e faremo i nostri esercizi, digiuneremo, mediteremo. Ma il nirvana non lo raggiungeremo: non lo raggiungerà il maestro, non lo raggiungeremo noi. O Govinda, di tutti i Samana che esistono non uno, io credo, neanche uno raggiunge il nirvana. Troviamo conforti, troviamo da stordirci, acquistiamo abilità con le quali cerchiamo d'illuderci. Ma l'essenziale, la strada delle strade non la troviamo".
Siddharta parte giovane con l'amico Govinda dalla casa del padre, dopo avere appreso tutto ciò che può dalla saggezza dei brahmini. I due si uniscono ai Samana, eremiti erranti, dove molto apprendono, ma non abbastanza, per Siddharta: Siddharta nel suo percorso verso la saggezza è diligente, temperato, apprende in fretta e a fondo, ma avverte sempre la mancanza di "qualcosa". Per questo, quando sente che è giunta l'ora, lascerà i Samana per cercare il proprio cammino.
L'aspetto che più ho amato del libro è proprio questa continua ricerca di Siddharta, che non è inquieta bensì determinata. Fa propria la raccomandazione stessa del Buddha: non credete a ciò che dico solo perché lo dico io, voi soli siete i vostri stessi maestri.
Libro n° 5, pag. 63, Sapiens: da animali a dèi di Yuval Noah Harari:
"Sapiens" è un'ambiziosa storia dell'umanità dagli inizi a oggi, e a questo punto del libro siamo ancora abbastanza indietro, alle tribù di cacciatori-raccoglitori, i nostri antenati che vivevano in maniera molto diversa da noi (ma a cui noi dobbiamo praticamente tutti gli istinti di base e la formulazione genetica, ancora saldamente presenti nonostante le nostre condizioni di vita siano molto cambiate).
Il pezzo che riprendo segue la considerazione che quel tipo si società presentava tantissimi gruppi e sottogruppi anche molto diversi tra loro per religione, usanze, costumi. Harari attribuisce questo stato delle cose alla rivoluzione cognitiva, che cambiò il modo di pensare dei Sapiens e di conseguenza il modo di utilizzare il linguaggio, che si fece sempre più articolato e in grado di riferirsi a concetti astratti.
È difficile pensare che fra gli antichi cacciatori-raccoglitori la varietà etnica e culturale non sia stata altrettanto forte, e che i i 5-8 milioni di Sapiens che popolavano il mondo alla vigilia della Rivoluzione agricola non fossero suddivisi in migliaia di tribù con migliaia di differenti lingue e culture. Questa, dopotutto, era una delle principali eredità della Rivoluzione cognitiva. Grazie alla comparsa della finzione, anche individui della medesima costituzione genetica che vivevano in condizioni ecologiche simili furono in grado di elaborare realtà immaginate assai differenti, che si manifestavano secondo norme e valori pure differenti.
Libro n° 7, pag. 45, Geografia e storia della letteratura italiana di Carlo Dionisotti:
Sopportate questo passo tecnico, perché nel suo contesto dice una cosa fortissima. Si parla di letteratura italiana del Cinquecento, che è il consolidamento della nostra letteratura nazionale, interiorizzata e rielaborata l'esperienza dei modelli tre-quattrocenteschi (Dante, Petrarca, Boccaccio e seguenti):
Torquato Tasso e Battista Guarini sono per l'appunto i primi poeti in Italia dei quali possa dirsi che siano nati italiani, che cioè si siano educati nell'ambito di una già pacificamente costruita letteratura italiana: essi osano e aprono quel loro ormai facile, fluido linguaggio poetico all'intima crudeltà e al lento gioco delle effimere passioni umane, e aggiungono all'italianismo, come scuola di eleganza umanistica e cortese, una seduzione immediata e profonda che accompagna nell'età successiva l'inchiesta psicologica e l'interpretazione drammatica della vita, propria di altre letterature europee.
Che cosa ci sta dicendo Dionisotti? Sostanzialmente che solo i poeti della generazione successiva alla "solidificazione del canone" si sono potuti permettere di giocare con la lingua ed approfondire le tematiche, aprendo all'introspezione psicologica. Prima non c'erano, banalmente, gli strumenti per farlo: tutto lo sforzo era teso a costruire quel codice, quella lingua, limandola per dargli lustro poetico. Questo ha contribuito a formare quel carattere un po' pomposo e retorico proprio della letteratura italiana (con le dovute eccezioni).
Mi affascina che Dionisotti lo attribuisca a questa sorta di "sforzo" nel costruire una lingua letteraria che prima non era presente, e che dunque non doveva avere cedimenti di nessun tipo. Gli artisti successivi, che avranno maggiore dimestichezza grazie al lavoro dei loro predecessori, potranno permettersi di spostare il focus dalla retorica all'indagine psicologica e al mondo delle emozioni.
Maria Chiara | Redattrice editoriale e per il Web | Social: @lettereminute
Anch'egli sarebbe invecchiato, anch'egli un giorno sarebbe dovuto morire [...]. Ma oggi egli era giovane, era un bambino, il nuovo Siddharta, ed era pieno di gioia. (Siddharta, Herman Hesse)
![]()
![]()
![]()
![]()
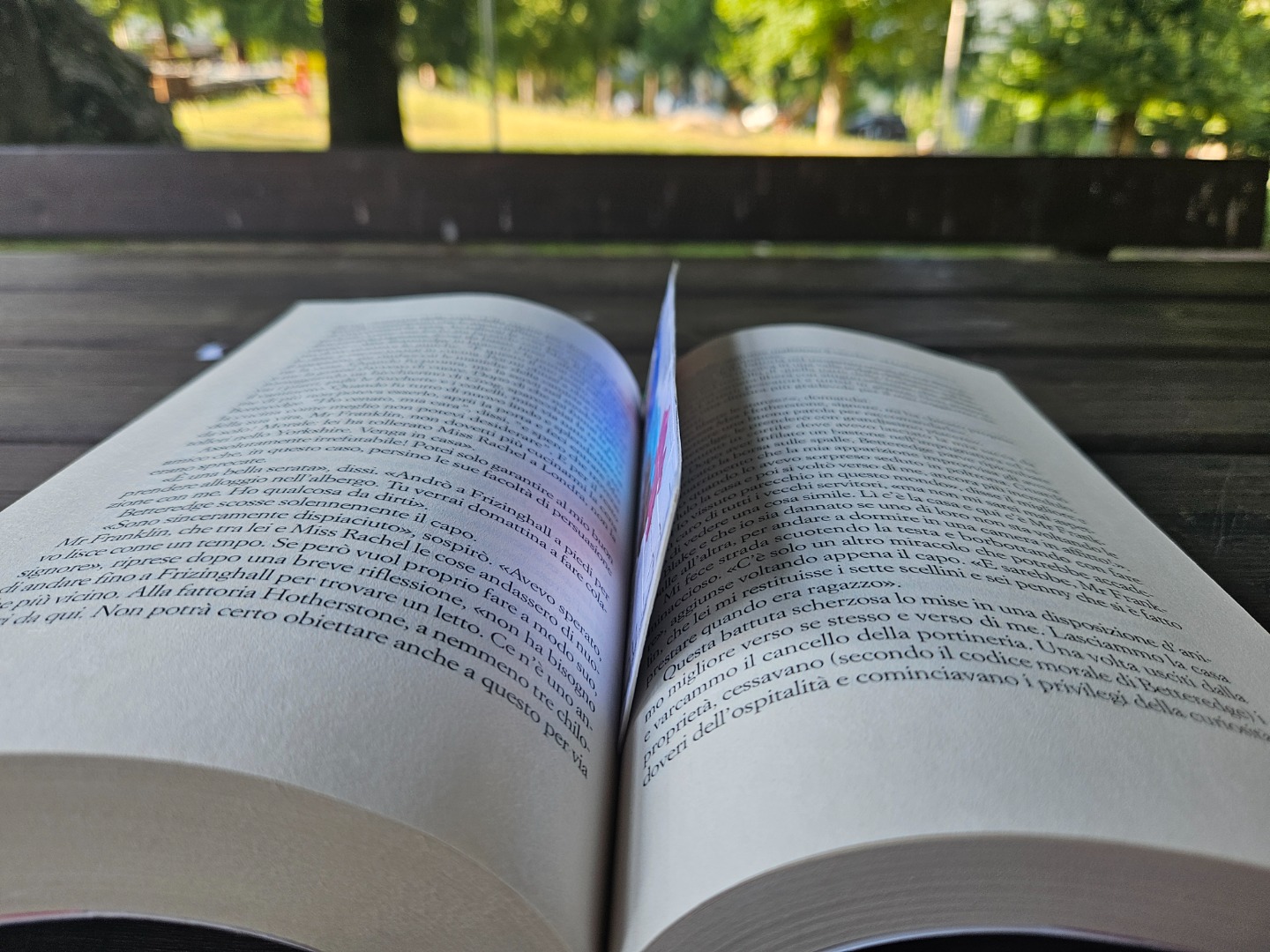 Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore.
Domenica, 21 Dicembre 2025 21:47
Bellissima recensione, dettagliata e ricca di spunti di riflessione. Complimenti all'autore. Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ...
Domenica, 07 Dicembre 2025 18:31
Bellissimo articolo Elisa, un approfondimento stupendo per il nostro Libro del Mese, effettivamente molto ... Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano
Sabato, 22 Novembre 2025 12:30
ciao! Vieni direttamente al Meeting Place alle 15:00, trovi il gruppo al secondo piano





