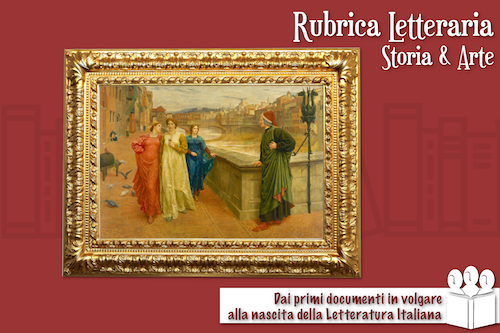
La scelta di utilizzare il "volgare" per la letteratura deve essere stata sofferta e sicuramente è stata combattuta. La lingua ufficiale della cultura è il latino e la lingua del popolo (il "volgo"), cioè la lingua parlata, non poteva aspirare, o almeno così sembrava all'inizio, al rango di lingua della letteratura. Eppure è accaduto, e a partire dal XIII secolo possiamo vantare la nascita di una splendida tradizione culturale che ci ha regalato autori tra i più famosi ed apprezzati al mondo.
Non si può parlare della nascita della Letteratura Italiana senza un breve accenno alla storia della nostra lingua. E già qui ci troviamo di fronte a un gran problema: quale italiano? Eh sì, perché ogni grande città del nostro territorio aveva un suo dialetto, derivato a suo modo dal latino. Non è esistita una lingua ufficiale per l'Italia finché Alessandro Manzoni non è intervenuto, nel XIX secolo, in quella che è stata per secoli definita la questione della lingua, e che ha visto alla fine trionfare il "dialetto" di Firenze come lingua dell'unità nazionale.
Le prime testimonianze del superamento del latino si hanno a partire già dall'VIII secolo, periodo a cui risale il celebre indovinello veronese, che è ancora scritto in latino, ma chiaramente mostra i segni di una trasformazione già in atto. Qui il breve testo e alla fine dell'articolo la soluzione: "Se pareba boves, alba pratalia araba et albo versorio teneba et negro semen seminaba" ("Teneva davanti a sé i buoi, arava bianchi prati e aveva un aratro bianco e seminava un seme nero". Chi è?). Indovinello a parte, comunque, un cultore del latino classico storcerebbe il naso a leggere queste poche parole, in cui non riconoscerebbe certo la lingua di Cicerone! Segno che ormai nel parlato il latino si stava trasformando in qualcosa di diverso.
Il primo gruppo di documenti scritto non più in latino, ma in un volgare italiano, è un insieme di placiti, cioè di documenti giuridici. Uno dei più famosi è il placito capuano, in cui è registrata la testimonianza di un uomo di cui vengono riportate le esatte parole, "messe a verbale" diremmo noi oggi. E questo signore non parlava certo in latino! Per cui, grazie alla sua testimonianza davanti ad un notaio, noi oggi possiamo leggere il primo vero documento scritto in volgare della nostra storia. Qui siamo tra il 960 e il 963.
Dall'XI secolo in poi le testimonianze dell'uso scritto del volgare si infittiscono. Non si può non citare la famosa iscrizione nella Catacomba di San Clemente (Roma), rivolta ad un pubblico non colto e quindi ancora più importante dal punto di vista storico. San Clemente è un papa che si trova a scontrarsi con il prefetto romano Sisinno, il quale tenta di farlo arrestare. Tuttavia il corpo del papa si fa talmente pesante che gli scagnozzi di Sisinno si trovano a dover sollevare una colonna, come un masso. Uno di questi, Albertellus, come si legge nell'iscrizione, urla al collega: Falite de reto co lo palo, Carvoncelle! (non v'è certo bisogno di tradurre: pensavano di smuoverlo col sistema della leva). Ovviamente il papa risponde in latino, con una frase che suona tipo così: "Per la durezza del vostro cuore avete meritato di dover sollevare un macigno". A questo punto interviene il poco elegante Sisinno: "Fili de le pute, trahite!" (anche qui mi sembra che non ci sia bisogno di tradurre...).
Tutti gli esempi di cui sopra, in definitiva, sono testimonianze non letterarie, perché non sono nate con l'intento di trasmettere cultura. Qual è dunque il testo che viene considerato ufficialmente il primo nella nostra letteratura? Una notte, tra il 1224 e il 1225, un ormai affermato e conosciuto Francesco d'Assisi detta un poema ad un suo confratello, il quale comincia a scrivere: Altissimo, onnipotente bon Signore... La lingua è volgare umbro, ma sicuramente colto, epurato di tutte le forme più popolari. L'intento di Francesco è quello di comporre un testo letterario (probabilmente anche musicato). L'opera, nota oggi come Cantico delle creature, è il primissimo esempio di testo letterario in volgare.
L'esperienza di Francesco d'Assisi resta quasi isolata, almeno all'inizio, perché in realtà la prima vera "scuola" di scrittori e letterati nasce a Palermo, alla corte di Federico II di Svevia. La grande innovazione di questa scuola è stata quella di prendere a modello non più soltanto le opere dei grandi autori latini, ma di guardare alla letteratura che già in Francia si produceva in una lingua "volgare", cioè il provenzale (la lingua francese del sud, detta lingua d'oc). Lo stesso Federico II fu autore di opere in latino e volgare, ma bisogna tra tutti ricordare il suo fedele consigliere Pier delle Vigne e, ancor di più, Jacopo da Lentini, considerato l'inventore del sonetto, una delle forme poetiche più diffuse e utilizzate della nostra letteratura.
Alla morte di Federico II il prestigio della corte palermitana si perde (i figli sono uccisi in varie battaglie, il Meridione viene conquistato dai francesi d'Angiò...). Tuttavia l'esperienza della nuova letteratura non va perduta: in Toscana, infatti, si cominciano a trascrivere i testi siciliani e se ne prendono a modello le strutture poetiche. Avviene una cosa simpatica: poiché il latino si è evoluto in modo diverso in Sicilia e in Toscana, come nelle altre parti d'Italia, i toscani hanno modificato alcune parole che per loro sembravano troppo ostiche. Ad esempio, quando i siciliani scrivevano ditto, i toscani riportavano detto. Ma se ditto faceva rima con ritto, in Toscana la rima diventava detto/ritto. Che stranezza, dicevano i toscani, i quali definirono questa sorta di rima "sbagliata" una rima siciliana.
Uno dei più grandi esponenti della cosiddetta scuola siculo-toscana fu senz'altro Guittone d'Arezzo, il quale proponeva una scrittura ricca di provenzalismi, termini siciliani e strutture ardite, tanto che lo stesso Dante Alighieri in seguitò ne considerò le opere troppo oscure e quasi incomprensibili. Tuttavia lo scrittore aretino fece scuola, tanto che si creò una vera e propria corrente "guittoniana", i cui più brillanti esponenti furono Bonagiunta Orbicciani da Lucca e soprattutto Monte Andrea.
Nacque tuttavia sin da subito una corrente contraria a quella guittoniana, che sarebbe stata destinata a fama ben più brillante. Si sta parlando del cosiddetto Dolce Stilnovo. Lo definisce così lo stesso Dante, che incontra proprio Orbicciani nel suo personale Purgatorio, appositamente per polemizzare con la poetica siculo-toscana. Il "nuovo stile" è definito "dolce" perché fluido, armonico, diverso dalla scrittura complicata dei guittoniani. Guido Guinizzelli è iniziatore di questo stile, tra i cui esponenti spicca anche il nome dell'amico Guido Cavalcanti.
Concludere non si può diversamente questa lunga carrellata generale sulla nascita della nostra lingua e della nostra letteratura. C'è un opera che è stata la prima in cui si è cominciato a discutere a livello teorico intorno alla "questione della lingua" di cui prima. Tra il 1302 e il 1305 Dante Alighieri scrive il suo trattato De vulgari eloquentia, interrogandosi sul volgare italiano, che naturalmente gli appare come una lingua non unitaria, fatta di particolarismi dialettali e locali. Una questione, insomma, per altri capitoli della storia della nostra letteratura.
PS: la soluzione dell'indovinello veronese è: lo scrittore (l'aratro bianco è la penna d'oca; il seme nero è l'inchiostro; il campo bianco è il foglio; i buoi sono le dita della mano).
(articolo a cura di Francesco Isidoro Gioia)
Se vuoi collaborare con la Rubrica Letteraria del Club del Libro, segnalarci iniziative interessanti o semplicemente comunicare con noi, scrivici a:
![]()






